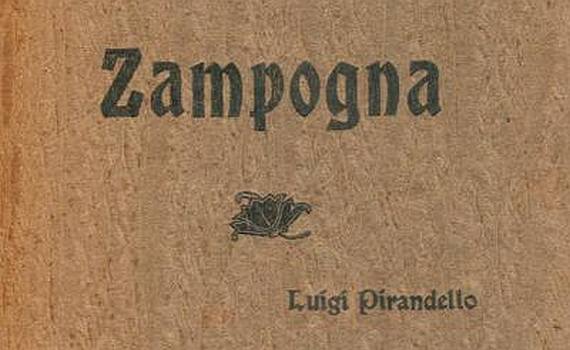Raccolta “Mal giocondo” (1889)
03. Allegre.
I
Chi mai vorrà comprare le mie nuvole?
Da l’Atlantiade nembi-adunatore,
m’ebbi in retaggio quante van pe ‘l cielo
nuvole in giro.
Sappi, mi disse il dio, ch’esse son vacche
sparse pe i campi liberi de l’aria;
n’abbi custodia e cura: io te ne cedo
l’alto dominio.
Gran mercé, rispos’io, liberal nume:
ben largo io vedo è il dono. Ma le poppe
di quelle vacche non dan latte, e in vano
or premo e spremo.
Ereditato in vece avrei piú tosto
la tua sagacità fine in rubare
bovi ai pastori, e la facondia e il ratto
alato piede.
Che non mi starei ora, resupino
da mane a sera, afflitto aerimante,
il viaggio a seguir di tante vane
nuvole, vano.
Or sú, chi vuol comprare le mie nuvole?
Io de i doni del dio non fo mercato,
ma a gran derrata vendo e senza usura
l’aerea merce.
Ne consiglio ai filosofi l’acquisto,
al papa, ai re regnanti e decaduti,
agli amanti fedeli, ai sognatori,
ai mille illusi;
ed agli uomini onesti ed ai poeti,
specialmente: Potranno su le nuvole
vivere gli uni onestamente, e gli altri
di poesia.
II
Tu m’hai tessuto, o Diva, come serico velo,
un nuovo canto. Egli ha li umani desiderî
le speranze, gli affetti, per fila; e su pe ’l cielo
sta sospeso a quattro astri in torno agli emisferi.
Enorme ragno in grembo a immenso ragnatelo,
or vi porgo il cervello. E dove piú s’intrica
fitto l’ordito, ei vigile e tutto in sé raccolto,
ne l’ansia che di smanie represse l’affatica,
fa la posta, spiando; poi salta, e de lo stolto
midollo dei terreni insetti si notrica.
Da lungi un gufo avvisa nel suo maligno verso,
che d’aura un lieve spiro l’ordito strapperà:
Una nottola in tanto per torto e per traverso
vi svola sotto, e stride: «Forse, io dico, sarà
il pensier d’un filosofo ebro, per l’aer perso.»
Ma già la Luna supera, tonda e flammea, del mare
e vaste treman l’acque continuamente sotto
il luminoso bacio. Lenta ella sale, e pare,
pe i silenzi dal murmure misurati del fiotto,
una diva che passi intenta a vigilare.
Le numerose fila del sottile mio velo
han brividi di luce, come gli astri del cielo.
III – La caccia di Domiziano
«T’abbia in grazia Minerva, o Imperatore:
la caccia come va?» Goccia il sudore
pe ‘l divin fronte: Con l’estivo ardore
le mosche ricominciano abondare.
Calvo, le gambe povere, ed acceso
in volto, il divo imperatore, inteso
a la caccia, piú mosche a l’ago ha preso,
e pago esclama: Questo, è un bel cacciare!
Scocca, stiletto, e infilza quel moscone:
È un discepol di Paride istrïone;
questo che ronza è Acilio Glabrïone.
e quello è Orfito; vieta lor l’andare.
O perché vai tant’alto, Cerïale,
bel moscone proconsole? Lo strale
mio va piú ratto che non le tue ale,
e ti coglie nel ventre consolare.
Pe ‘l natal celebrato il divo Ottone,
o Coccejan, devoto calabrone,
questa freccia or ti manda in su ‘l groppone:
Meglio era il funeral tuo celebrare.
Tu, Sallustio Lucullo, hai già messo ale
se piú de le tue lance or questo vale
mio stil, giudica tu, savio animale,
che il nome su le lance ami fermare.
O mosche nere, che svolate in festa,
questo sole divin, che mi molesta,
ebre di luce, vi farà la testa
su ‘l mio marmo fengite esercitare.
Dice, e su i lunghi labbri un tristo riso
si torce in una smorfia. «Io sono avviso
che per un ch’io mi sia, molti avrò ucciso,
pria ch’abbia effetto il vostro congiurare»,
E ne l’occhio di bue, freddo e severo,
vaga torvo fra tanto un gran pensiero:
Ne lo stile infilzar tutto l’impero,
il moscon matto, che un’aquila pare.
O calvo imperator Domizïano,
nepote vostro, anch’io, se ben lontano,
infilzo ne l’aguzzo stil, che ho in mano,
ogni insetto che vienmi a molestare.
Ma ne l’accidia, nel tedio mortale
di far bene, e financo di far male,
la mia vita io vorrei, mosca senz’ale,
anche lei, ne lo stil freddo infilzare.
IV
Io non so che bestie sieno
le viventi, o Stelle, in voi;
ma sien pur come si sieno,
non essendo come noi,
questo è certo, che degli esseri
curïosi in voi saranno,
che, si come noi, de l’essere
la ragione non sapranno.
Voi non siete accese lampade,
né men chiodi da solajo
conficcati in una splendida
lastra concava d’acciajo;
se ben poco me ne torni,
so che siete mostruosi
corpi o fissi o perdigiorni
via pei ciel silenzïosi,
proprio come, e non v’incomodi
il notturno paragone,
questa sciocca enorme trottola
che ci porta in su ‘l groppone.
Ora, voi parete, o Stelle
splendienti costà sú,
ne la notte, tanto belle,
che non v’è cane qua giú,
che non v’abbia insieme a molti
grandi e piccoli poeti,
in latrati, o in versi sciolti,
inni sciolto or tristi or lieti…
Però ho vivo desiderîo
di saper, Stelle, se pure
tra le bestie che in voi vivono,
vi sia almeno un cane, oppure
un consimile animale,
cui, veduta da lontano,
la mia Terra piaccia, e quale
se mai n’abbia pensier strano.
Come voi parete agli uomini,
d’oro forse ella a voi pare?
e non fango, o Stelle vigili?
e non fango, o Stelle care?
V – Serenata ad Allegra
Tu che a l’amico Massimo Gilorda,
meglio acconcio a uccellar a merli e a tordi,
frullar fai tutto il mondo per la testa
cosí e cosí
la notte e il dí,
o bella Allegra, non mi far la sorda;
ma de la mia chitarra ai dolci accordi
sorridi in sonno prima, indi ti desta,
ti desta, or sú!
e vieni giú…
Io canto le canzoni innamorate,
che a notte mi procacciano ventura,
e fan gittar da le finestre a terra
(non so il perché,
né dico te)
le donne che piú paiono impietrate:
Ma tu che ridi sempre, e d’ogni cura
scevra ti vivi, non mi dar piú guerra;
Levati, sú!
e vieni giú…
Vieni; io mi muoio dal disio d’amare;
voglio una donna e non abbado a patto,
che amor mi stringe e tiene in mala pena;
Odimi un po’,
odi, non fo
non fo non fo non fo che soffïare…
Or la tôrrei, se mi venisse fatto,
in fino a Cristo un’altra Maddalena!
Levati, sú!
e vieni giú.
Freme scorrendo in queste corde il suono,
sí come il sangue per ogni mia vena;
Oh sii tu acconcia a far quel che mi piace…
No sangue, no,
sí fuoco m’ho,
e addormento il brucior ne l’abbandono
di questa rotta, e matta cantilena…
Ladra del sonno, ladra de la pace,
levati, sú!
e vieni giú…
Un sospiretto sbadigliar non sai?
Al bujo, come il meglio puoi, ti vesti;
sospingi l’uscio, divora le scale,
un salto, e a me!
Tardi? oh perché?
Vedrai, bel giuoco!… vieni a me; vedrai…
Allegra, oh via, ti desti o non ti desti?
Oh che tu trema, non vi sia del male?
Levati, sú
e vieni giú…
VI
Già di ritorno, stagione dei fiori,
stagione degli amori?
Tra gli orrori de l’ultima vernata
mi s’era questa nozïon scordata,
che c’è una primavera ne l’annata,
per dar fiori a la terra e pace ai cuori.
E se non pace, o stagion nova, in fondo,
d’ogni cura ne dà l’oblio giocondo:
Di giovinezza vesti il vecchio mondo,
e con ben fatta maschera innamori.
Sotto ogni fiore in tanto si nasconde
un nudo e freddo teschio, che risponde
co’l riso de la morte a le gioconde
vanità de la vita e ai nostri amori.
Già, l’ho veduto, quest’inverno, il grullo
Vecchio, sol rido al tuo crudel trastullo,
che sí me ‘l concia, ch’ei paja un fanciullo,
e grinze e rughe imbiaccate di fiori.
Trista sei, ma pur bella. Io t’amo, e rido,
ed il segreto del cuor mio t’affido:
tu nascondilo dentro un vecchio nido
di rondine, o se vuoi, càntalo fuori.
Ma se ne nasce scandalo e vergogna,
ai poeti del secolo rampogna
non mover tu: Gli opprime tanta rogna,
che non è cosa che non gli addolori.
E un’altra volta ti farò lamento
del brutto tempo; e dirò come il vento
gl’inganni tutti ed ogni sentimento
soffiando dentro m’abbia tratto fuori.
Nel vecchio mondo, o non mai vecchia, tu
da sei mil’anni, in tanto ed anche piú,
ancor ti piaci di ritornar sú
sempre ad un modo, vestita di fiori.
Ma non ti s’è crepata ancor la pelle
sotto le rime a pioggia, a manatelle,
in vario stile, in tutte le favelle?
non ne hai cocciuole in carne e pizzicori?
Oggi i versi han l’umore de l’ortica,
e ridon acre i vati: «Gran nimica,
urlan la vita!» e il ciel gli benedica…
Che cocomeri in corpo e che dolori!
Saluta Primavera, e va, canzone;
dille il nome dei re vivi, Leone
XIII papa, idest prigione,
e quei che han fama, se tu non gl’ignori.
VII – Cnf. Macchiavelli
Su i prim’anni ancora tenero,
Roderico di Castiglia
(Belfagor arcidïavolo)
lasciò Spagna e la famiglia.
In Soria visse; in Aleppe
acquistò dovizia e onore:
e in Italia, poi che seppe
ch’è il paese de l’amore,
a tôr giovine piú bella,
dal desio d’amor portato
se ne venne. La favella
del paese gli ha garbato,
e il bel cielo e il clima mite,
e il bel suolo fruttuoso
de l’arancio e de la vite;
ma il nero occhio pensieroso
de le donne del paese,
il crin d’ oro pettinato
e le labbra fine e accese
di piú certo gli han garbato.
Ogni onesto fiorentino
sa da un pezzo quest’istoria,
e l’onesto cervellino
con onesta e grave boria
la rivolge, accarezzando
l’amor proprio cittadino
(ogni c dura aspirando
da sputato fiorentino):
Bella è Napoli e fangosa,
è città da carnasciale;
ma Firenze grazïosa
vive e pensa, genïale.
Roma sta su i colli assisa,
grave, almen ne l’apparenze;
l’Arno porta sabbia a Pisa,
porta ciottoli a Firenze;
e a Firenze, a Ognissanti,
Roderico elesse stanza,
per nutrirvi de gli amanti
il tormento e la speranza.
(E dirò fuori ballata,
per usar discrezïone,
che il demonio a l’impensata
non elesse, ma a ragione
veramente quella sede:
Si procaccia gran ventura
chi vi esercita, si crede,
la bell’arte de l’usura.)
VIII
Poi che Pompea, l’adultera, a le voglie
del giovine, lascive apre le braccia,
i fior di furto maritali coglie
Clodio, e ventura a notte si procaccia,
quando Colui che già fu a Nicomede
moglie fatal, va d’altri amori in caccia.
Dolci vezzi ha Pompea. Nuda concede
gagliardamente tutta la persona,
e vita e onore a un solo bacio cede.
Stolto chi a tanto amor non s’abbandona!
Crispo Sallustio il sa, che nova astuzia
pensa per riamar Fausta, matrona.
Viva l’amor furtivo! In braccio a Muzia,
romani, o a Lollia, o a Postumia, o a Tertulla!
Egli solo non sa, che fine arguzia
o grave stile, in cui, tuonando, culla
in sacro amor di patria, in concïone,
or di Roma in favor spreca per nulla,
urbano seccatore, Cicerone.
IX
Una vecchia parente e la figliuola,
di quarant’anni a pena,
ricorrendo non so che festicciuola,
m’invitarono a cena.
La vecchia madre è stata al manicomio
tre volte o quattro pazza.
La figliuola ha il furor del matrimonio
e veste da ragazza.
Ma, ahimè, la pesca è andata male. Il pesce
ha fiutato l’insidia:
abbocca altrove. Ella ne gli anni cresce,
e la guasta l’invidia.
Già è rimprosciuttita; il tempo or mai
passa e nemmen la sfiora…
La zia mi chiede: “Quanti anni le dài?.
non n’ha ventitré ancora”.
Oh guarda caso! solo gli anni miei
son cresciuti e gli affannj…
Ero ragazzo, e sí com’ ora lei
avea ventitré anni:
Me la ricordo a un vecchio uscier promessa,
tutta smorfie e moine,
brutta cosí com’è, sempre l’istessa,
con quest’arti assassine…
Dal dí che l’uscio infilò l’usciere, otto
coltri ella in tutto ha ordito,
sempre sperando di schiacciarvi sotto
un povero marito.
Ben vedo al fin, com’è l’Arte al presente
in condizion non lieta,
se a la vecchia mia zia venir può in mente
dar tal figlia a un poeta.
Io vado a farmi monaco: Ho paura!
Troppo buona la cena,
e troppa ti prendesti di me cura,
o quarantenne a pena.
X
Un coperchio di vecchia casseruola
da i gobbi di scrignute bestie (o monti!)
sorge, e i poeti de la nuova scuola
da le liliacee fronti,
salutan Cintia. Come di zitelle
cisposi occhi, a quel canti vegetali,
lappoleggiando diventan le stelle
fontini lacrimali.
Sale per la cerulea cartapesta
tra nubi di bambagia il rame (o lume!)
e in un’enorme sputacchiera
desta gialli desii d’untume:
«Ave, clarissimo radio d’ariento!
sú per le verdi perfidie del mare
nàviga, nàviga, nàviga lento,
fa Sirene cantare.
Nàviga, nàviga, suscita, o radio,
liquidi incendi nel mar sottostante:
Luca ogni flutto, sí come al sol gladio
d’acciaio battagliante.
Un barbagianni in tanto senza mora
in torno al capo d’ogni vate svola,
mentr’egli tasta, posa, gusta, odora,
cantando, ogni parola.
XI
Mi ronzano intorno a le orecchie,
nel tedio, con suono confuso,
sí come uno sciame di pecchie,
le vecchie
parole sconciate dall’uso.
Ahi fiore non sboccia, o stuol nero
di pecchie, a quest’algido sole:
nel fosco cervello piú un fiero
pensiero
non nasce, o sconciate parole.
Gli amor de la terra ed i vani
piaceri, le glorie ed i mali,
pagani cristiani nostrani
estrani
poeti (e son morti immortali)
han detto già tutto; ed i loro
pensieri, voi pigre, involuto,
avete, aggirandovi a coro
sonoro,
sí come le mosche uno sputo.
E nulla piú a dire or ci resta.
Anch’essa, la noja, ha trovato,
che m’introni la testa,
molesta
legione, un poeta annojato.
È vecchio, o vecchissime, il mondo.
Sol una è la storia in eterno:
Mutatis mutandis, in fondo
è tondo
pur sempre, e non ha che un sol perno.
E movemi a riso codesto
continuo ronzar che voi fate,
qual vago per futil pretesto
ridesto
grugnito di bimbe imbronciate.
XII
O del pianeta Giove abitatore,
per cortesia
qua giú disceso a far da professore
d’astronomia,
come par che mortal cosa terrena
voi già non siete:
la vostra lunga chioma nazarena
è da comete,
ma da comete popolate, credo,
che troppo spesso
vi grattate la zucca, e sempre, vedo,
nel punto istesso.
O professor d’astronomia rapito
serenamente
ne la contemplazion de l’infinito,
ponete mente
a ciò che fa la vaga vostra moglie:
la poverina
dicitur che un incomodo vi toglie
e ogni mattina,
mentre che voi studiate pei lunari,
massaja accorta,
in casa le lunar con gli scolari
corna vi porta.
XIII
La mia vicina, su ‘l mattin d’aprile,
compresa ancora dei tepor del letto,
esce al terrazzo, e al sol primaverile
spiega i tesori del ricolmo petto.
Ella ha piú grazie, la vicina, in quella
acconciatura che le cangia aspetto:
Un camicino bianco, e una gonnella
di panno lano oscura. Io mai veduto
creatura piú semplice e piú bella
non ho. Dal mio poggiuolo la saluto;
ed ecco, ella venendo al pilastrino,
su cui ride beffardo un fauno arguto,
mi risponde “Buon dí caro vicino”,
e aggiunge. “ Sogno ancora? o com’è andata?
qual gallo v’ha cantato il mattutino?”
Cosí, tra i fior, su la balaustrata,
dei vasi messi in fila e con amore
coltivati da lei lungo l’annata,
un grande anch’ella pare e vivo fiore.
E dei fiori or mi parla, e d’una mano
si fa solecchio. È certo che l’odore,
io penso, s’ella è un vivo fiore umano,
saran le sue parole (e in questo intralcio
un madrigale, che dirò persiano)
– Cara vicina, o di che cuore un calcio
darei con forza ad ogni vasellino,
che vi sta in torno co’l novello tralcio.
Ogni vaso mi pare un cervellino
di moderno botanico poeta,
che levi dal suo fango un inno fino
tra il cessin le pillaccole e la creta,
e faccia fede dei non fatti studî
a la dolce stagione che l’allieta.
Spesso, di notte, lumaconi ignudi
quei metallici fiori, che son rime,
infestano, ma voi coi piedi crudi,
voi li schiacciate, e accorta, dal concime
anche i vermi traete, che la nera
umida terra dal suo grasso esprime.
Oh dei terrazzi sciocca primavera,
sciocca di nuove rime fioritura!
Mi duol che voi, vicina giardiniera,
ve ne prendiate cosí assidua cura…
Codesti fior che vi civettan smorti,
non vi pajono sforzi di natura?
Guardate: I fauni ammiccano con torti
occhi da i pilastrini, argutamente;
ma pur nei loro versi aspri e scontorti
lo sforzo de l’artefice si sente,
e in quel sogghigno su i labri impietrato,
una furbesca smorfia ridente.
Due tartarughe, cui il sole ha scaldato,
su i torti piè s’inseguono, in amore,
raspando il piano d’asfalto bruciato.
Cara vicina, fatemi il favore
di rivoltare, a la rabbia del sole,
su la scatola d’osso, pe ‘l pudore,
codeste sciocche e sozze bestïole,
che sono, ahimè, per fare atto villano,
mentre che noi facciam solo parole:
Le vedremo armeggiar, nel vuoto, in vano.
Widget not in any sidebars
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com