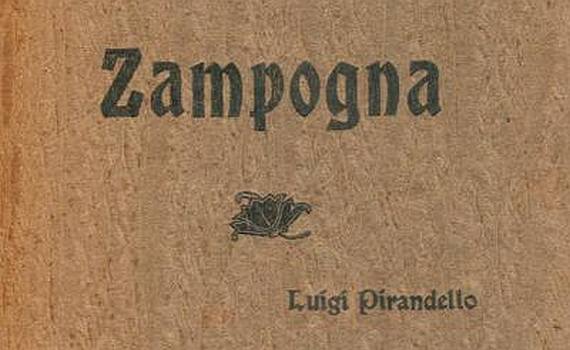La prima stesura del Belfagor risale al 1886, e fu distrutta nel 1887 (v. lettera dell’Autore alla sorella Lina, 25 marzo 1887, pubblicata nella rassegna Terzo programma, 1961, N. 3, pag. 281); dodici quartine furono però salvate, e incluse in Mal giocondo, 1882 (Allegre, VII). La seconda stesura, in otto canti, è degli anni 1890—1892.
Belfagor – Introduzione
La prima stesura del Belfagor risale al 1886, e fu distrutta nel 1887 (v. lettera dell’Autore alla sorella Lina, 25 marzo 1887, pubblicata nella rassegna Terzo programma, 1961, N. 3, pag. 281); dodici quartine furono però salvate, e incluse in Mal giocondo, 1882 (Allegre, VII). La seconda stesura, in otto canti, è degli anni 1890—1892.
Il primo canto apparve nella Tavola rotonda, «giornale letterario illustrato della domenica », Napoli, anno II, N. 28, 10 luglio 1892, col sottotitolo “La visita” (85 quartine). Successivamente, nel Roma di Roma, « giornale politico—letterario quotidiano », anno I, N. 139, 16 settembre 1896, furono ripubblicate, con varianti, quaranta quartine del primo canto, suddivise in due capitoli:
I. Presentazione (14 quartine), II. L’antica novella (26 quartine). Il testo era preceduto da una nota di Luigi Capuana, nella quale venivano citate tredici altre quartine. Infine, nell’articolo Belfagor, poemetto di Luigi Pirandello (in Belfagor, « rassegna di varia umanità », Firenze, anno XXII, N. 5, 30 settembre 1967) Elio Providenti, pronipote di Lina Pirandello, ha riportato, trascrivendole da una lettera dell’Autore del settembre 1890, altre venti quartine (del III canto), tre delle quali risultano citate, con varianti, nella nota apparsa nel Roma di Roma, da Luigi Capuana. Sulla definitiva distruzione del poemetto, si veda la lettera autobiografica (apparsa su Le Lettere il 15 ottobre 1924 e successivamente il 28 febbraio 1936) Si riproduce qui l’intero testo del I canto apparso nella Tavola rotonda del 10 luglio 1922.
Belfagor
Su la vecchia sedia a dondolo
mi spingevo innanzi e indietro,
quando udii con molta grazia
dar tre colpi a l’uscio a vetro.
Prego, avanti! faccio. Schiudesi
l’uscio, e in atto di saluto
si fa innanzi, sorridendomi,
un signore sconosciuto.
Chiusa in man reca una lettera;
me la porge. — Prego, segga —
io gli dico, ed ei schermendosi. —
«Oh no, scusi! prima legga.»
Che bel tipo! e di che trattasi?
fo tra me; voglio vedere
chi mai serbi ancor memoria
di me, in patria forestiere!
M’alzo anch’io, la busta lacero:
è una lettera in latino,
con la firma: “ Nicolaus
segretario fiorentino”.
Nicolaus? Mi metto a ridere.
L’altro sta tra serio e mesto.
Dico: — Sa? non so comprendere
il suo scherzo! è scherzo, questo?
«Non è scherzo; legga, e subito
capirà» dice il signore,
sempre serio. Da la ruvida
carta sal non so che odore.
Io mi metto dunque a leggere;
ma quei segni agili e snelli
su la carta par che saltino…
Chi mi scrive è il Machiavelli!
Signor mio, se un manicomio
ella cerca, non è mica
qui. Qui è casa mia. Vuol prendersi
di me gioco? E allora il dica!
«Di nessun vo’ gioco io prendermi,
se l’è preso altri di me.
Credi a ciò che il grande storico
fiorentin scrisse per te»,
mi risponde. Ed il suo pallido
volto, i lucidi occhi intensi,
piú gli guardo, piú conturbano
stranamente ora i miei sensi.
Dico alfine. — E dovrei credere
dunque in vero ch’Ella sia
Belfagor arcidiavolo?
È un po’ troppo, in fede mia!
e che a me l’illustre storico
fiorentin la raccomandi,
com’è d’uso, con la lettera
che m’ha data? dunque, i bandi
che già contro a tutti i diavoli
la scienza nostra ha emesso,
ella ignora? e vuol sul serio
che la creda? proprio adesso? —
Ragionandoci, un po’ d’animo
io prendea, cosí, man mano;
ma l’incognito appressandosi
e sedendo, dice piano:
«La fa bene a piú non credere
ai diavoli, fa bene;
neppur io ci credo, e frottole
ogn’uom savio li ritiene».
— Dunque?
— « Dunque è semplicissimo:
niun ci crede, e bene sta;
ma l’inferno c’è, coi diavoli,
tanto, ch’io vengo di là…
Solamente son diavoli,
condannati nelle spese,
e l’inferno è di delizie
divenuto ora un paese.
Sissignore, di delizie!
La mi stia bene ad udire,
le farò venir grandissimo
desiderio di morire.
Saprà come in lontanissimi
tempi, Pluto, re d’Averno,
come un re, poniam, d’Italia,
o un ministro de l’interno,
si trovasse in gravi angustie
a cagion de l’affluenza
strabocchevole de l’anime,
che ad eterna penitenza
pur dannate, discendeano
ne l’inferno col sorriso
su le labbra: quasi andassero
tutte quante in paradiso!
Chiesto lor perché in tal numero
e con tanta faccia tosta
nel suo regno rovinassero,
ebbe il dio Pluto in risposta:
“Pluto, re mite e benevolo,
(e qui: bravo! ebbene! evviva!)
venga a noi la pece liquida,
venga a noi la fiamma viva!
Pluto, re mite e benevolo,
tra i tormenti tuoi ci togli,
ci parran carezze d’angeli
a confronto de le mogli!
Pluto re, sai tu che fossimo
noi lassú? fummo mariti!
(e qui in turbine d’orribili
urli, gemiti, grugniti).
Altri ancora, innumerevoli
turbe qui rovineranno
e te re mite e benevolo
come noi saluteranno”.
E ciò detto, via di furia!
sollevando in cento cori
per quell’aer denso, tangibile,
una zuffa di clamori.
Restò il dio come una statua,
restò lì muto, intontito…
Forse mai, come in quell’attimo,
si sentí tanto marito.
Ma d’un subito riebbesi,
e ad urlar diessi anche lui:
Fu un accorrer di demonii
spaventati, fuor dei buj
antri uscenti a precipizio;
Pluto in mezzo delirava,
sghignazzando; restringevasi
ne le cosce, poi saltava
e gridava. “Ecco, ecco vengono!
Ridon tutti… Ajuta! ajuta!
Pluto re mite e benevolo,
ognun d’essi mi saluta!…”
I demonii si consigliano
con grandi occhi, a bocca aperta…
Ed io dico: “Ahimè, il plutonio,
alto senno si sconcerta!
Minos venga, e l’altro giudice
de l’inferno, Radamanto.”
I demonii allor si diedero
a un dirotto, ontuoso pianto.
Proprio in quella, da le viscere
de l’inferno atre e profonde,
di dannati a noi giungeano
risa e voci alte e gioconde!
I due giudici sudarono
un bel poco a ritornare
Pluto in sensi; poi si chiesero
un rimedio d’adottare.
— “Un rimedio? qual rimedio?
esclamò Pluto iracondo.
Posso io far che tutti gli uomini
restin celibi nel mondo?”
— “Ma tu credi, o mio saturnio
Zio, rispose Radamanto,
che di ciò sien sola causa
donne e mogli? Io credo intanto,
che faremmo opra piú savia
non prestando tanta fede
a quest’anime di reprobi.
A un dannato non si crede.
Facciam meglio: un buon diavolo,
d’oro e d’altro ben fornito,
su la terra per noi mandisi,
e colà faccia il marito.”
Corse un freddo e lungo tremito
quelle fiere carni al nome
di marito, ed ogni diavolo
non sapea perché ne come.
Ma del già re de la Licia
la proposta alfin fu accolta,
e allor fu che venne al secolo
Belfagor la prima volta.
E sa ben che lì, dal cerulo
Arno in riva, io stanza presi;
mi spacciai per ricco e nobile,
e il danar con arte spesi.
Tolsi quindi in matrimonio
Monna Onesta dei Donati,
che mi die’ poi tanti triboli
sperperando i miei ducati.
Io scappai tra un pazzo strepito
di trombette e tamburelli…
ma narrato ha questa istoria
degnamente il Machiavelli.
Di dannati ora rigurgita
nuovamente il regno negro,
questi modo non vi tengono
degli antichi meno allegro.
Come prima entrati, traggono
dal profondo un gran respiro.
Trae qualcuno anche un binoculo
da viaggio, e guarda in giro.
Poi tra canti e risa imbarcansi,
qual per gita di piacere.
A Minos l’antico giudice,
dei peccati il doganiere.
e a Pluton la barba tirano!
cosí pazzi, cosí arditi,
che i diavoli s’affollano
loro intorno, sbalorditi.
E fra tanto ognun dimentica
d’adempire al proprio uffizio.
Nessun piú sa fare il menomo
brutto scherzo, un malefizio.
Ma se pur qualcuno accingesi
a trattare male un dannato,
questi trova un mezzo esplicito
per non esser molestato.
Lì, con quanti ha mai retorici
artifizii la parola,
gli dimostri che lui, diavolo,
non è altro che una fola;
che l’inferno, Ieova, gli angeli,
marionette de la fede,
sono anch’essi vuote favole,
cui nessuno ormai piú crede.
A siffatto raziocinio,
dato lì, tra naso e muso,
resta il diavol malinconico,
come un coso uscito d’uso.
Pajon tanti Amleti. Vansene
ruminando il gran mistero,
e han finito ormai col credersi
ombre e favole davvero.
Tal follia cagione è a l’anime
di perfetta libertà.
Cosí, un bravo sociologo
di fondar pensato ha già,
messi i dritti in equilibrio
del cervello e de la pancia,
ne l’inferno una republica,
da oscurar quella di Francia.
Fonderà lo Stato—esempio,
specchio in tutto del progresso,
se però l’ajutan chimici
e ingegner’, come han promesso.
Tutti i sogni inattuabili
che la mente d’ogni eletto
su la terra sconcertarono,
finalmente avranno effetto.
Molti stan per la republica
di Platone, chi sa poi
come andrà questa baldoria
a finir! Torniamo a noi.
Capirà che Pluto, il povero
nostro re, di questo passo
non può andar piú avanti. Attonito
sta a guardar, par già di sasso.
Gli si chiede: “O re, quest’asini
debbon proprio sopraffarci?
“ Leva in faccia gli occhi stupidi,
e risponde. “E che vuol farci?”
Nulla, dunque. E allor si lascino
fare in pace! Or essi fatto
han già tanto, ch’ei, re, scendere
dové alfin con loro a un patto
vergognoso. Quei, s’imagini,
gli hanno offerto un trono eterno
su la terra; perché, dicono,
che la terra è un vero inferno.
La m’intende? In brevi termini:
“Va’ a riporti! gli han risposto.
Senza far de l’altre chiacchiere,
è lassú, non qui il tuo posto!
Troppo, troppo abbiam, com’uomini.
noi sofferto su la terra,
perché tu da morti or ci abbia
da seccar con altra guerra!”
Pluto disse: “Dunque è proprio
cosí piena di malanni
questa terra? E chi assicurami
che il dir vostro non m’inganni?”.
— “Fa la prova?” gli risposero
i dannati. E il re: “La faccio.
Mando subito un diavolo.”
E me mise ne l’impaccio,
proprio me, come il piú pratico.
Ma ciò è nulla! il peggio è stato,
che quei cani non mi vollero
far partir, che addottorato.
Son dottore, ah voglio ridere!
Ci voleva la scienza… “
Già, perché se andrai, mi dissero.
ne la tua sincera essenza,
cioè a dire da diavolo,
ne la vita, capirai,
come dentro al vero e proprio
elemento tuo, starai.
Andar dêi com’uom, né semplice
o volgar! com’uomo dotto,
capacissimo di scernere
ogni mal che covi sotto.”
Ed in mezzo allor mi presero:
Chi m’infuse un sentimento,
e chi un altro; un desiderîo,
questi; quegli, il suo talento.
Mezzo morto mi lasciarono:
finché dentro ebbi ogni affetto,
tutto ciò che han dentro gli uomini,
coscienza ed intelletto.
Né bastò! che poi mi vollero
ragionar la lor follia.
Sapienza essi la chiamano,
io direi ch’è malattia!
Se Dio esiste o no, se l’anima
è mortale od immortale,
come spiegasi il fenomeno
de le cose, ciò che è male,
ciò che è ben, qual sia la regola,
qual de l’esser sia lo scopo,
se ebbe il mondo o no un principio,
se avrà un fin; che avverrà dopo…
e altre ancora, altre scempiaggini,
ch’or mi giran per la mente!
Ah perdio! dite sul serio?
Questo è il senno, che ha la gente?
Ma perché di tante chiacchiere
v’opprimete l’esistenza,
quando, io dico, a la men facile,
con un po’ di pazienza
solamente può risolversi?
Dura tanto poco. Quasi
pare un sogno, è un sogno. In aria
perché mai dovete i nasi
tener sempre e gli occhi in estasi?
Ma imitate il savio armento,
per cui il vero è l’erba tenera,
che gli cresce sotto il mento!
Pazzi! Par quasi incredibile…
Basta. Or io mi trovo qui,
s’ella ha inteso, con l’incarico
d’annojarmici cosí,
da potere il giorno, prossimo
o lontan, del mio ritorno
confermar ciò che i suoi simili
del terren loro soggiorno
e del viver d’oggi dissero.
Però badi: non mi pare
tanto facile! di vivere
amo, e assai la vita amare
è il mio solo desiderîo.
Può far lei, che, per la pace
dei suoi morti, in odio or mutisi
quest’amor, ch’è la mia face?
Laomache
I
Fiera Laòmache a fianco del giovane Gàrgaro, vinto
nella gara recente, saliva al monte su cui
l’ara dall’alba sorgea dei sacrifìzii a Diana.
Eran di primavera i giorni segnati. Le elette
vergini Amazoni, dopo le gare annuali, per una
notte il possente corpo abbandonavano al vinto
rivale, che della tribù confinante era spesso
dei Gàrgari. Sotto la grande zona di fiamma
che in quel vespro incombeva sul monte, Laòmache obliqui
sguardi di tratto in tratto al suo compagno lanciava.
Questi allora le tumide labbra schiudeva a un sorriso
impercettibile, e gli occhi intanto abbassava. Dal bruno
volto, a umile aria composto, e anche dal molle
tentennare del corpo gagliardo comprendere a quella
sua domatrice lasciava, com’egli non dalla possanza
ma per amore di lei si fosse fatto domare.
Ben l’intendea Laòmache adesso, e fremeva, dagli occhi
sdegno, dispetto schizzando; ed or l’azza scoteva,
or la pelta lunata; squassava or le piume dell’elmo.
Era nell’aria un’amara fragranza d’arnica, ed ella
con dilatate nari la respirava. Com’egli,
stesa un mano e divelto da un cespo un virgulto
ora un ginocchio ora l’altro se ne batteva, stizzita
glielo strappò, lo gittò lontano gridando con dura
voce: «Cammina!» — «Ecco, cammino», il Gàrgaro disse,
sorridendo a suo modo. E, cúpido, di sotto al cuojo
belluino che a lei dall’òmero manco, sul seno
là sagliente qua scemo, giú fino ai ginocchi scendeva,
l’òmero destro lasciando e il braccio scoperti e l’ascella,
insinuò lo sguardo. Laòmache l’azza su lui
terribilmente brandí. Le braccia egli aperse, aspettando.
Ma trattenuta fu l’ira tra sprazzi di sdegno e bramiti.
Giunti che furono in vetta al monte, nel tempio, con l’altre
coppie sacrificarono anch’essi a Diana. Di rose
quindi le ancelle, a un cenno d’Ocíale sacerdotessa,
inghirlandarono i vinti. Scomparso era il sole e sorgeva
dall’opposto orizzonte, rosea e grande, la Luna.
II
Ora a piantar le tende per la lor notte d’amore,
là su la vetta, badan le coppie. Laòmache al suo
Gàrgaro ne commette la cura. Caparbia, proterva,
sdegnosamente si trae da parte. Zighi sommessi
di lepri in amore, fritinnii lunghi di grilli,
strani fili di lucidi suoni, in quell’alba lunare,
giú dalle sodaglie, dai greppi le giungon del monte.
Par che raggiorni. E dal prossimo tempio si levan preghiere.
Presto alzata è la tenda. Il Gàrgaro invita l’acerba
sua compagna ad entrare. Entra egli per primo; si stende
come leone al suolo. Poggiato su un gomito, aspetta.
Nel vederlo cosí, Laòmache, entrando, s’adira.
— «Lèvati sú!» — gli grida — «ch’io entro e mio schiavo tu sei!»
Ma rimane per terra sdrajato il Gàrgaro e solo
alza il capo a guardarla e sorride. Poi dice: — «Tuo schiavo;
ma, per servirti, bisogna ch’io ora mi senta padrone.
Tu certo uccidermi puoi; ti freme l’arma nel pugno;
ma se vivere io debbo per tua e mia gioja, bisogna
che mansueta or ti veda e docile meco. Sconfitto,
tanto della tua forza mi son penetrato e del fiero
odio che tu dimostri per l’uomo, ch’io, vedi, a toccarti
or non m’arrischio nemmeno. Tu m’impauri. E bisogna
che tu m’alletti invece, m’induca ad osare, siccome
fan l’altre donne sommesse al potere dell’uomo.
Stènditi qua benigna; carezzami un poco; a slacciarmi
questo calzare ti china…» — Laòmache, a tale proposta,
regger piú non si può; un urlo ferino le rompe
dalla gola; gli è sopra, furente: dal capo gli strappa
la ghirlanda di rose; e, calpestandola, — «Mai!
No, mai!» — rugge; e via dalla tenda con impeto. A tale
deve dunque una donna, a tale ridursi? E le altre
sue compagne si sono fino a tal punto avvilite
forse, di fronte all’uomo, piegate al volere di lui?
Vibra nell’alta notte serena la vergine offesa;
ansa; guarda smarrita, com’ebbra, nell’ampio chiarore
ch’ora diffonde la Luna dal sommo dei cieli, e s’avvia.
— «Cènia! Ippolita! Aèlla!» — geme. Le fide compagne,
fiere com’essa, non vagano fuor delle tende: ella sola,
come tigre ferita, vaga e si lagna. S’accosta
càuta a una tenda: sconvolta, dà indietro; procede.
Ode delle compagne, perdutamente obliose,
qua, là nell’orgia rubesta, i seni bramosi anelare.
Corre al tempio, inseguita da quell’obbrobrio; si gitta
tra le braccia d’Ocíale, raccapricciata, gridando.
Questa però, severa, del rito le parla; le intíma
di ritornare all’uomo che a lei Diana accordava.
Stavasi il Gàrgaro innanzi la tenda, in attesa. La accolse
fremebondo sul petto possente, di peso la tolse
tra le braccia, e di lei fu, tutta la notte, signore.
III
Sia il tuo cenere ai venti disperso, o Tanàis! Ah quale
stolido regno ti piacque fondare! Son queste le fiere
tue seguaci, del sangue degli uomini avide, queste
le belligeranti che, impubi, la destra mammella
schiaccian sul seno o recidon per esser piú abili a trarre
d’arco? E spasimi acuti or dà loro il succo materno
nella compressa poppa urgendo. E guàrdale! otri
gonfie son fatte, ne piú cingersi or posson l’irsuto
corsaletto di ferree scaglie; e guazza l’immane
ventre sotto il lupigno cuojo che mal lo ricopre,
né riverenza ispira, che frutto non è già d’amore,
ma sol della loro fecondità bestiale.
Pigre, oppresse, deformi, trascinansi. — «Ippolita! Aèlla!
Cènia!» — chiama Laòmache. E quelle a lei, che sul volto
ha l’accorata nausea dipinta del làido suo stato,
vengono e la deridono. Eh via, non le piace davvero
per alcun tempo cosi lo Stato, oziando, servire
e per razza e per latte? La verginità? Ma bisogna
perderla pure un giorno, se perdere il regno non vuolsi
delle femmine. Onta? eh via, perché, se Diana
vuole cosí, comanda che a tutte in quel modo la festa
delle rose sia sacra? Oh, verrà pur la volta di quelle
vergini acerbe che passano loro davanti sdegnose,
strette nel corsaletto, con l’azza nel pugno! Tra breve,
dopo tante prodezze e tante vittorie su l’uomo,
soggiaceranno anch’esse. Conoscono i Gàrgari bene
l’arte di perdere prima per vincere dopo. Di loro
dunque non abbia invidia Laòmache.
Invidia? Ma schifo,
piú che disprezzo, di tutte, di sé, Laòmache or prova.
Nota a quelle era dunque l’arte dei Gàrgari? E questo
ventre deforme è delle ambite vittorie il trofeo?
Via di là! Via, lontano, per piangere occulta le amare
lagrime del rimpianto, le acri dell’odio compresso.
IV
Giunse ai confini estremi del regno. La Scizia, dall’alto
delle montagne, in un fitto continuo silenzioso
turbinare di candide innumerevoli piume
giú dai cieli, le vaneggiava sotto, d’un cupo
bianco mistero avvolta. Rimase Laòmache a lungo
dello stupore in preda, davanti al prodigio di quella
muta, lenta, lieve caduta perenne. Oh ma quanta,
quanta d’uccelli raminga moltitudine avea
quelle del cielo invase inospiti plaghe, se tanta
copia di piume cadeva? Qual fato crudele gli uccelli
d’ogni terra traeva a quelle plaghe? Lo stesso
fato di lei? Che se quegli uccelli le candide piume,
lei la baldanza e gl’impeti e i voli dell’anima e tutto
quivi lasciato avrebbe. E come quelle nel cavo
della sua mano in acqua scioglievansi, in lagrime i suoi
impeti si scioglievano.
Laòmache or tutta di gelo
livida e irta, tra quel turbinio senza fine,
giú pe’ greppi guardando, da un nuovo stupor fu assalita.
Altre Amazoni, al pari di lei, ma già madri altra volta,
libere adesso, furtivamente a quei limiti estremi
s’erano tratte; e per quei greppi scendevan soppiatte,
càute, al paese dei Gàrgari. E i Gàrgari forse
eran là sotto, a piè di quei monti in attesa,
e deridevan tra loro lo sdegno famoso delle alte
donne guerriere. Ah dunque non attendevan neppure
la rituale festa dei fiori le socie sue fiere?
Senza lotta, all’amplesso degli uomini, non invitate,
ritornavan furtive? Si torse per l’onta, avvampando
tutta d’odio e di sdegno. Ma un moto in quel punto, non suo,
dentro di sé, nel grembo, un fremito nuovo, uno strano
palpito la rattenne, e attonita a lungo rimase,
rabbrividendo.
«O Diana» — gridò, levando la faccia
contro il cielo, sconvolta, — «Diana fa’ tu che non sia
questo che in grembo io porto frutto odioso, una donna
all’obbrobrio mio stesso serbata, ma un maschio ch’io debba
con le proprie mie mani, per la tua legge, strozzare!»
Come la carne tua che palpita e vive, recisa
da te, carne che piange fuori di te, che il tuo seno
cerca subito, cieca, e il calor che le manca, strozzare?
E la mammella Laòmache porse al suo bimbo, godendo
ch’entro al piccolo corpo dal corpo suo grande ora uscito
subito quella entrasse sua tepida vena materna,
sí che il grembo di lei sentisse il pargolo ancora.
Scese quindi furtiva al paese dei Gàrgari; chiese
umile, col fardello suo dolce sul seno, del padre,
si prosternò davanti alla tenda ed il pargolo porse
supplice all’uomo e insieme il materno suo cuore di sposa.
Pier Gudrò
I
Pier Gudrò vuole la guerra.
Lui risponde della sorte.
Noi, per lui, siam la piú forte
nazione della terra.
Non vorrebbe egli, però,
dire: — Andate, io vengo dopo. —
S’è ridotto un vecchio topo
di campagna, Pier Gudrò.
Ma già i vecchi il lor dovere
l’hanno fatto. Or tocca a noi,
a noi figli degli eroi,
correr sotto le bandiere.
E saprem combatter bene.
Dican pur quest’età molle:
scorre, in fondo, e in noi ribolle
fiero sangue per le vene.
II
Solitario Pier Gudrò,
per la vigna piano errando
e gestendo a quando a quando,
pensa e crede tutto ciò.
Erra fin dal primo albore
col suo fulvo gatto appresso,
cui privato egli ha di sesso
per guarirlo dell’amore.
Un vapore tenue suole,
velo fulgido di brina,
sú pe’ campi, la mattina,
ondulare al primo sole.
Frullan passeri tra i rami
dei novelli alberi intorno;
son saluti al nuovo giorno
e son timidi richiami.
Pier Gudrò, di tratto in tratto,
qualche tralcio osserva, chino:
ei pur pensa, il vecchio, al vino;
e, con amorevol’atto,
delle viti ancora basse,
càuto, i pampini rimuove,
come se le poppe nuove
a una vergin denudasse.
Avverrà forse ch’ei beva
del suo vino ancora un anno!
Che sbaldor gli uccelli fanno,
messi sú dai tralci a leva!
Non per mal ch’ei voglia fare,
ma fra i tralci non li vuole.
Sciò! sciò via! C’è terra al sole,
da beccare e da ruzzare.
III
Pier Gudrò scojò un agnello,
ne conciò la pelle in fretta
e ne trasse una berretta
con la coda e il riccio vello.
Gli vien giú fin su gli orecchi,
che son già curvi dal peso;
dalla concia hanno già preso
un color giallo i cernecchi.
E dal capo non si toglie
mai quel carico. Vuol fare,
(bene o mal) quel che gli pare;
e però non prese moglie.
Vive solo, di sé pago,
ed a quanto gli abbisogna
di sua man provvede; sogna
e il lavoro gli è di svago.
D’ogni frutto il campo abbonda,
vigna e ortaglie, e grano e biada;
ov’ei l’occhio volga, o vada,
verde e pace lo circonda.
Si conturba solo quando
qualche nuova della vita
gli perviene, eco smarrita.
Allor va fantasticando.
Si rintana. La man tarda
stira l’aspra barba bianca.
Dalla vecchia cassapanca
in silenzio il gatto guarda.
La republica di Francia
s’apparecchia la rovina.
Nuova guerra s’avvicina
se la Russia si sbilancia…
Che farà l’Italia? Ajuto
ai Tedeschi presterà?
Vinceranno! Libertà
per la Russia e lo statuto…
Ma i colombi, che già l’ora
senton scorsa del beccare,
ecco vengono a tubare
alla porta chiusa ancora.
Pier Gudrò due volte al giorno
ai colombi il pasto dà.
— «Curra! curra!» — Eccoli là:
gruga tutta l’aja intorno.
Sono cento, cento e piú,
fremon, gonfiansi nel terso
collo, guardan di traverso:
— Ehi, padrone, i chicchi, giú! —
IV
Su dai colli, ora, la tonda
luna spunta rosea, e bagna
del suo lume la campagna.
Non si crolla ad aura fronda.
Par che sia giorno e che l’aria,
al lunare albor piú rada,
schiari, pregna di rugiada,
la campagna solitaria.
A destar le smorte stelle,
dalle curve messi d’oro,
dai sognanti alberi, a coro,
strillan grilli e raganelle.
Col berretto su la nuca,
rabbuffato, desto ancora,
dalla sua rural dimora
Pier Gudrò, guardingo, sbuca.
Dove va? Non gli concesse
forse il sonno qualche nuova,
e la pace non gli giova
della vigna e della messe.
Fra sé parla, iroso. Là…
(neppur lui sa forse dove)
ebra folla si commove:
gli operaj della città.
«Morte ai ricchi! morte ai re!
Non han pane né lavoro.
Già si contano tra loro.
Chi li tien? Piú Dio non c’è.
Se la casa han peggio nuda
d’una squallida prigione,
per un giorno abbian ragione;
la prigione poi li chiuda.
La prigione? Ma no, guerra!
guerra! via, leggi! via, freni!
Non di patrie o aviti beni,
equa madre, sa la terra».
Pier Gudrò, di tanto in tanto.
come a un urto delle fronde
cupe, arrestasi; risponde
al suo fiero orgasmo il canto
fitto, stridulo, insistente,
che dai campi al cielo sale;
e s’accresce e, assiduo, uguale.
avviluppagli la mente,
gli stupisce già l’udito,
divien fervido concento,
d’un lontan commovimento
il clamore indefinito…
«Non di patrie o di confini…»
Ei col gesto l’interrompe;
va com’ebro; alfin prorompe:
— Pazza turba d’assassini!
Minacciar cosí la santa
patria, il sacro nostro re,
quel che fatto abbiam per te
noi, con tanto sangue e tanta
gloria nostra… — E già gridare
non può piú, dall’ira. Va
pure innanzi; alfin ristà:
gli si stende, sotto, il mare.
Calmo, tutto palpitante,
della Luna al dolce lume,
bacia con fervor di spume
la riviera sottostante.
Pier Gudrò dall’alto mira
l’ampia, inaspettata scena;
non però si rasserena:
torvo e incerto il guardo gira;
poi, l’angusta via che al lido
scende giú, ripida, toglie.
Ma chi ride giú? Lo accoglie
tra le ondate un alto grido.
Son le villanelle gaje
use a scendere, la sera,
per bagnarsi, alla riviera,
dopo tanta opra su l’aje.
Tra la spuma ignude, un’ombra
venir giú dal colle han visto;
e un sospetto, un timor tristo
loro il sen nascosto ingombra.
Spiano trepide… Ma via!
quegli è il nonno Pier Gudrò,
che non vuol certo ne può
far piú loro villania.
Nel lenzuol sul lido ognuna
si ravvolge; su la bionda
sabbia il molle corpo affonda,
ed a lui sotto la Luna
cerchio fan, cosí sdrajate:
«Pier Gudrò, non puoi scappare!
per castigo or dêi narrare
l’avventura tua col frate».
Pier Gudrò ride tra sé.
Zitte lì, con le avventure!
Per la patria eran congiure.
Si teneano qui, da me.
Ora un dí sbagliò la via,
certo, un frate francescano:
venne a me; tese la mano
per la questua. Questua? Spia!
Sí, fratello, — gli risposi.
Son anch’io di San Francesco
buon divoto. Segga al fresco;
vado e torno; si riposi. —
Andai sú di corsa; presi
una fune, e mani e piedi
gli legai; poscia gli diedi
l’elemosina: lo appesi.
Tre dí tenni il malaccorto
frate appeso ad un olivo;
nol lasciai morto né vivo;
mezzo vivo e mezzo morto. —
V
Per quel frate or certo il Papa,
giorno e notte, contro a lui
pensier cova truci e buj.
Ma a pensare invan si scapa.
Tenda insidie, ordisca trame:
dalla cintola non suole
toglier mai le due pistole
Pier Gudrò. Pur su lo strame,
ogni notte, se ne sta
con le due pistole ai fianchi;
non per nulla ha i peli bianchi;
molte cose ha visto e sa.
Sa la storia un giorno appresa
dai compagni di sventura
nell’esilio, e qual mai cura
abbia avuto ognor la Chiesa:
a stranieri offrir l’acquisto
dell’Italia. E a quanti re
come femmina si dié,
lei che sposa era di Cristo!
Queste ed altre cose ei narra
senza fine ai suoi villani.
Ma si sputan su le mani quelli,
e attendono alla marra.
— «C’era in mar come una festa,
per la Luna nuova. Piana
vi filava una tartana.
Dentro avevo, io, la tempesta.
Confiscati i beni, in bando
me n’andavo, ignaro e senza
guida. Eppure era clemenza,
questa, di re Ferdinando.
Buttar giú con una brava
scure il capo ed ogni idea
di rivolta mi potea.
Che male ora m’arrecava?
Niente. Mi strappava il cuore,
con quel bando, il re. Ma guasto
n’ebbe il sangue. Ai vermi in pasto,
vivo ancor, lo dié il Signore.
Me ne stavo lì, sdrajato
su la tolda. Mano a scotte
non si mise, quella notte.
Era il mare addormentato.
E la via parea sapesse
la tartana nera. Io solo
non sapea piú nulla. Al duolo
cupo il cuor, pure, mi resse.
Giunsi a Malta all’alba. Terra
nostra. Dio la benedica.
L’ha in poter però l’amica
fedelissima Inghilterra.
E Trieste, dunque? Trento?
di chi sono? e la Savoja?
Nizza, Corsica? S’annoja
tanto, adesso, a quel che sento
la moderna gioventù,
che non ha da fare… Orbene,
di’, ci hai sangue nelle vene?
Ti do io da fare! Su,
prendi l’armi! Ti ci vuole
una guerra: guarirai.
Butta i libri via! Che sai
tu? che sai? Niente. Parole.
Basta. Sceso a Malta, volo
a trovar gli altri emigrati.
— Come? E che? — dico, — Affamati?
— C’è il colera…
Mi consolo.
Quanti morti? —
— Uh, tanta gente…
E che fate qua? —
— Mah! stiamo
qua. Se il pesce abbocca all’amo,
noi mangiamo,. se no… niente! —
— Addio. cari! —
E per un tozzo
di pan duro, a tutto ormai
preparato, m’imbarcai
su una nave inglese. Mozzo.
Prima mozzo, poi fochista.
Io: sepolto lì, nel caldo
ventre strepitoso e saldo
d’una nave, senza vista,
né respiro, io che cresciuto
ero sotto il sole, all’aria
pura! E in una solitaria
rada, privo d’ogni ajuto,
sbarco, alfine, infermo. È un lido
d’Asia, presso Smirne (il nome
non ricordo piú). Là, come
un can perso, ai piè m’affido.
Rubo fichi e mangio. Cado
finalmente in man d’un lurco,
grosso e fier mercante turco,
che assoldava nel contado
cacciatori, gente brava
per la caccia nel deserto.
Egli, poi, nell’arte esperto,
fiere e uccelli imbalsamava.
Dice: “Sai sparare, amico?”
— Non so fare altro. —
« Benone!
pure a un’aquila? a un leone?» —
— Pure al Padreterno, — dico.
Ben munito, m’avventuro
nel deserto anch’io. M’infischio
del cammin lungo, del rischio…
Gambe sode, occhio sicuro.
Due leoni uccisi, io solo,
senza star tanto ai riguardi
di quegli altri; leopardi,
tigri, jene; aquile a volo.
C’era un alto monte, infido,
che di marmo parea tutto,
là, nel sol come costrutto.
Vi facean l’aquile il nido.
Di ritorno con la preda,
zitto e vigile da un canto,
a spiar mi sto, frattanto,
come il turco ora proceda
con sue droghe e spezie rare.
L’arte apprendo, in men d’un mese.
E la preda del paese
per mio conto passa il mare.
Vivo lì dieci anni. L’ora
del riscatto, finalmente,
suona, e Pier Gudrò la sente
da lontano, in tempo ancora
per combattere all’entrata
di Palermo, ed a Milazzo
e in Calabria… O prete pazzo
e l’Italia liberata
ora tu, come una nera
talpa, vuoi scavar soppiatta?
Talpa nera, talpa matta,
di te stessa prigioniera?” —
Pier Gudrò sogghigna. Sopra
le campagne l’ombra è scesa;
s’è nel cielo Espero accesa;
ecco, e già lasciano l’opra,
con le lor marre i villani.
Curvi, senza dare un fiato,
han del vecchio essi ascoltato
le avventure e i casi strani.
Malta… Fiere… Asia… La guerra…
preti… talpe… Vanità!
Non sanno essi altro che qua
zapperan sempre la terra.
Pier Gudrò, rimasto solo,
la villosa enorme testa
scuote, ancor della sua gesta
ebro; e guarda là del molo
la lanterna che s’accende
rossa, il fischio ode d’un treno
che lontano passa; e, pieno
di letizia, senza mende
vede l’opera compiuta
— Patria mia!…
La Luna è sorta.
Con la sua faccia di morta
schiara la campagna muta.
Di lontan borboglia il mare.
Via, sprazzando il baglior verde,
una lucciola si perde
nella bianca alba lunare.
Pier Gudrò rincasa. Al lume
della fumida lucerna,
ora trae da una giberna
vecchia, appesa tra due piume
di pavone al capezzale,
le medaglie sue. Son tre.
Se le lustra, e dice al re
in effigie lì: — Reale
Maestà, nulla ti ho chiesto;
son già vecchio, tutto bianco;
con te, dunque, parlar franco
posso, e voglio dirti questo:
Alla sedia, su cui tu,
ora, in Roma, altero siedi,
sai chi ha fatto i quattro piedi?
Noi, noi vecchi. E per virtù
nostra esiste, Maestà,
tutto quanto intorno splende,
quanto ricca e bella rende
questa nuova civiltà.
Posso chiudere domani
gli occhi, pago e soddisfatto.
La mia parte io te l’ho fatto,
figlio mio. Bacio le mani. —
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com