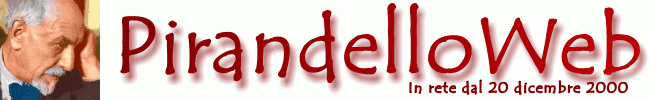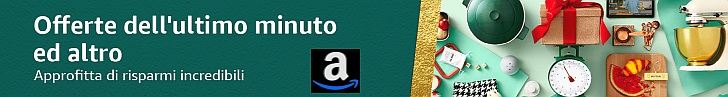Legge Giuseppe Tizza.
«Le viveva invece lì sul petto, stretta sotto il braccio, quella bambola meravigliosa; d’una vita incomprensibile però, quale le sbarbagliava ancora nella mente attraverso il chiacchierio fitto e volubile della padroncina malata.»
Prime pubblicazioni: Corriere della Sera, 30 luglio 1914, poi in E domani, lunedì, Treves, Milano 1917.

Servitù
Voce di Giuseppe Tizza
|
|
******
Due volte la mammina aveva sporto il capo dall’uscio a raccomandare alla Dolly di non parlar troppo, di non agitarsi tanto, che altrimenti la febbre le sarebbe cresciuta.
– Parli sempre tu… giuochi tu sola…
La Dolly, sostenuta da una pila di guanciali, sedeva sul lettino in compagnia di tutte le sue bambole belle. E due volte, scotendo la testina per cacciar via dagli occhi i riccioli d’oro scappati nel calore del giuoco di sotto la cuffietta di raso celeste, aveva risposto alla mamma:
– No, io sola; giuoca anche Nenè… Nenè era la figliuola della nurse.
Ma finora, per dir la verità, Nenè non aveva mai aperto bocca. Tutt’e due le volte, invece, aveva guardato quasi atterrita la signora che sporgeva il capo dall’uscio; e il cricchio della maniglia, il cigolio dell’uscio schiuso, lo sporgersi di quel capo, la voce della mamma di Dolly, erano stati per lei un fracasso, un crollo, uno scompiglio. Perché era come in un sogno Nenè da due ore, sospesa, quasi angosciata nel dubbio che non fosse vero ciò che pur si vedeva attorno e toccava.
L’abituccio color cece, di due anni fa, le segava il collo, le segava le ascelle, le opprimeva le spallucce; il nastrino di seta color di rosa, un po’ stinto, attorno al capo le s’allentava a mano a mano e cedeva al goffo rizzarsi ispido e compatto dei capelli neri ancor zuppi d’acqua (poiché era stata lavata tutta con insolita cura): non sentiva nulla, non avvertiva nulla, incantata, abbagliata dal lusso di quella cameretta di bimba, imbottita di raso azzurro. E lievemente, senza saperlo, con la manina tozza, gonfia per la manica troppo stretta e corta che le serrava il braccio come un salsicciotto, palpava la coperta così liscia, così morbida del lettino, mentre tutta occhi e con la boccuccia aperta seguiva il chiacchierio fitto, volubile della padroncina malata.
Sentiva bene la Dolly che il giuoco realmente lo faceva Nenè, quantunque finora non avesse aperto bocca. Con la sua maraviglia intenta e muta dava un’anima nuova a quelle sette bambole sedute sul lettino come damine in visita, e un nuovo piacere, a lei, nel farle muovere e parlare. Da tanto tempo, infatti, quelle sette bambole per Dolly quasi non vivevano più: erano pezzi di legno, testine di cera o di porcellana, occhi di vetro, capelli di stoppa. Ma ora riavevano anima, un’anima nuova, e rivivevano una nuova vita maravigliosa anche per lei, quale ella non avrebbe mai immaginato di dar loro, un’anima, una vita che prendevano qualità appunto dalla maraviglia di Nenè, ch’era maraviglia di servetta. Le faceva perciò parlare come signorone del gran mondo, piene di capricci e di moine, press’a poco come parlavano le amiche di mammà.
Ecco: questa era la contessina Lulù che guidava da sé la sua auto, fumava sigarette col bocchino dorato e gridava sempre, agitando in aria un dito minacciosamente:
– Moringhi, Moringhi, se scappi ti raggiungo!
Chi era Moringhi? Un mago? Chi sa! Forse un amico di mammà anche lui, un amico di tutte le amiche di mammà; ma il nome, a quel grido, si rappresentava a Nenè come quello d’un mago, poiché la Dolly diceva che era amico specialmente di quell’altra bambola lì, di Mistress Betsy.
– Ali right, thank you!
No, no, senza ridere! Parlava sempre inglese, Mistress Betsy. Con mammà, con tutti. E andava sempre a cavallo – op! op! – mica a sedere però: con le gambe aperte, così… come i maschiacci, brutta scostumata! E spesso cadeva; e una volta, alla caccia della volpe, s’era ferita qua allo zigomo, ecco. Oh, le stava bene, brutta americanaccia! Mostrava a tutti le sue ferite di cavallerizza, al petto, alle spalle, anche alle gambe; e quando stringeva la mano faceva male.
– Ali right! Thank you!
E quest’altra? Ah quest’altra qui, che ridere! Roba, roba proprio da morir dal ridere! Donna Mariù, questa. Sempre malata. – Oh Dio qua, oh Dio là… – La mia povera testa! il mio povero cuore! – Vi prego, Moringhi, siate buono! Moringhi, non mi fate male: non posso più ridere, Moringhi! La mia povera testa! il mio povero cuore! – Ma mica un cuore così… Un cuore col q e staccato: qu-ore. Moringhi diceva così. Roba da morir dal ridere, un cuore col q.
Nenè non capiva nulla.
Poteva esser vero per lei che quella bambola lì fumasse e quell’altra andasse a cavallo. Davvero allo zigomo, quello sgraffietto… Ma se avevano finanche le mutandine coi merletti e i fiocchettini di seta e anche le calze di seta con le giarrettiere di velluto e le fibbie dorate e le scarpine di coppale, potevano anche veramente andare a cavallo, fumare, parlare quel linguaggio incomprensibile. Qualunque prodigio poteva esser vero in quella cameretta lì, anche i cavallini veri, cavallini vivi, piccoli piccoli, potevano sbucar fuori da un momento all’altro e mettersi a caracollare su per le campagne lontane lontane di quel tappeto azzurro vellutato, con quelle damine in groppa dai veli svolazzanti.
Affascinata da quella visione, Nenè stentava a credere, o veramente non riusciva ancora a capire che, stanca alla fine del giuoco, la Dolly stesse ora per regalarle una di quelle bambole e non sapesse ancor quale.
– No, questa no, – diceva la Dolly. – Questa ha il braccìno malato e deve stare a letto con me. Ecco… ti do… ti do quest’altra, invece, Mistress Betsy… Ma no, neanche… Ti scappa via, Mistress Betsy: tanto cattiva è! Scostumata… E poi, parla sempre in inglese, e non la capiresti. Ti do quest’altra allora. Si chiama Mimi. Ma tu devi chiamarla sempre signora Marchesina. Marchesina è, sai? La marchesina Mimi. Esigente… ah, esigente! Bisogna che trovi il bagno pronto ogni mattina, e poi la colazione di cioccolato e biscottini, e poi… e poi… non mangia niente, sai? non mangia altro che palline d’argento… quelle che si comprano dove le compra mammà, dal farmacista Baker di fronte al Grand Hotel. Ti do Mimi, sì. Ecco, prendila. Per davvero te la do, sì… per sempre… prendila, ti dico… Aspetta, che le do un bacio… Ecco, te la puoi portar via.
Nenè guardava sbalordita e più che mai sospesa e angosciata. S’era levata in piedi alle insistenze di Dolly; ma restava lì, senza poter alzare la mano, quasi sul punto di piangere.
Entrò nella cameretta la signora, seguita dalla nurse, ch’era rimasta dopo il baliatico a servire in quella casa di signori. Anche la mamma, vestita così bene, da nurse, con la cuffietta in capo e il grembiule bianco ricamato, accanto alla signora, apparve in quel punto a Nenè come trasfigurata nel lume di quella casa, come infusa nell’azzurro d’una meravigliosa lontananza.
Che diceva? Diceva di no a Dolly, che non doveva darle la bambola. Non doveva dargliela prima di tutto perché troppo bella, troppo ben vestita, anche calzata e coi guanti e col cappello, ma figurarsi! una bambola così fina a Nenè! E poi, che se ne farebbe Nenè? E mammina di casa, Nenè: deve attendere a servire il babbo, e non ha tempo di giocare, che guaj se il babbo non trova tutto pronto, la sera.
Il babbo? dove? Le sembrava tanto lontano ormai, a Nenè, quel suo babbo cattivo, che rincasava sempre ubriaco e scontento, e per nulla la batteva e l’afferrava pei capelli o le scaraventava addosso ciò che gli capitava prima sotto mano, gridandole:
– E non potevi morir tu, invece?
Lei, già, invece del fratellino che la madre aveva lasciato poppante per andare a balia. Una vicina s’era incaricata d’allevarlo per poche lire al mese; e lei, Nenè, avrebbe dovuto fargli da mammina. Ma il fatto è che il fratellino, un giorno, era morto in braccio a lei: morto; e lei che non lo sapeva, aveva per un pezzo seguitato a portarselo in braccio: freddo freddo, bianco bianco, e zitto e duro… Da allora il babbo era diventato cattivo, così cattivo che la mamma non aveva voluto più star con lui ed era rimasta a servire in quella casa, o piuttosto, a farvi la signora, come diceva il babbo e come ora veramente pareva anche a Nenè. Certo, la mamma parlava ora e guardava e sorrideva e gestiva come una signora, come la mamma di Dolly appunto, e a lei non pareva più la sua mamma.
– Ma, no, via, signorina! Ma le pare? Ma neanche per sogno! Una bambola così bella a questa mia povera Nenè!
Ma ecco, la signora le prendeva un braccìno, poi le posava sul petto la bambola, quella Marchesina Mimi, e poi sulla bambola le ripiegava il braccìno perché la reggesse forte.
– Grulla, e non si ringrazia nemmeno? Su, come si dice?
Nulla. Non poteva dir nulla, Nenè. E non osava nemmeno guardare quella bambola marchesina contro il suo petto, sotto il suo braccìno.
Se n’andò via come intronata, gli occhi sbarrati senza sguardo, la boccuccia aperta, e coi capelli che le si rizzavano sotto il nastro color di rosa, quanto più la madre cercava d’assettarglieli sul capo. Scese le scale, attraversò tante vie e si ridusse alla catapecchia, ove abitava col padre, senza veder nulla, senza sentir nulla, quasi alienata d’ogni senso di vita.
Le viveva invece lì sul petto, stretta sotto il braccio, quella bambola meravigliosa; d’una vita incomprensibile però, quale le sbarbagliava ancora nella mente attraverso il chiacchierio fitto e volubile della padroncina malata. Oh Dio, se quella bambola parlava col linguaggio che le aveva messo in bocca la Dolly, come avrebbe fatto lei a comprenderla?
– Moringhi, Moringhi, se scappi ti raggiungo!
Ah, Moringhi, certo, non sarebbe venuto lì nella catapecchia a trovare la marchesina Mimi, e nessuna delle amiche sarebbe venuta. E le sigarette col bocchino dorato? e le palline d’argento profumate? e i cavallini veri, i cavallini vivi, piccoli piccoli?
Non le s’affacciava neppur per ombra alla mente che avrebbe potuto giocarci, con quella bambola. Servirla, sì, avrebbe potuto servirla; ma come, se non sapeva nemmeno parlarle? se non capiva nulla della vita a cui la bambola era avvezza?
Entrata nel bugigattolino ov’era la sua cuccia con una seggiola spagliata e una panchetta che le serviva da tavolino per far le aste e le vocali quand’ancora andava a scuola, si guardò attorno smarrita, avvilita, non per sé ma perla damina che portava in braccio. Non osava ancora guardarla.
Certo, per sé, la marchesina Mimi, aveva gli occhi di vetro e non vedeva. Ma vedeva lei, Nenè, ora, la miseria brutta di quel suo bugigattolino con gli occhi della marchesina Mimi abituati al lusso della cameretta da cui veniva. Finché lei non la guardava, la marchesina Mimi, ancora stretta sotto il suo braccio, non vedeva nulla. Avrebbe veduto però, appena lei si fosse risolta a guardarla. Ebbene, bisognava che vedesse fin da principio il meno peggio possibile.
Pensò che nella cassetta dei panni sotto la cuccia c’era un grembiulino azzurro, smesso dalla Dolly e regalato dalla signora alla balia per lei: era stato lavato, rilavato tante volte; s’era stinto; aveva più d’uno strappo, ma veniva di là; era stato della Dolly, e forse la marchesina Mimi lo avrebbe riconosciuto.
Senza posarla, senza guardarla, Nenè si chinò; trasse da quella cassetta il grembiulino e lo stese su la panca come un tappeto, badando che gli strappi, almeno i più grossi, non venissero in mostra sul piano. Ecco, per il momento poteva metterla a sedere lì, sul pulito di quel grembiule vecchio, ma fino.
La pose a sedere pian piano, con mani tremanti per paura di farle male e di sciuparle l’abito; e finalmente osò guardarla. Un sentimento misto di pietà e d’adorazione espressero le manine rimaste innanzi al petto aperte, in un gesto d’incertezza angustiosa. E a poco a poco si piegò su le ginocchia, guardando negli occhi la bambola. Ahimè, la vita maravigliosa, di cui la Dolly nella sua cameretta la aveva fatta vivere, qua – s’era come spenta. La bambola le stava davanti, come se non vedesse nulla, in attesa ch’ella facesse qualche cosa per lei, per ridarle vita, la sua vita perduta, di gran signora. Ma come? che cosa? Le mancava tutto. La Dolly le aveva detto ch’erano avvezze a cambiarsi d’abito più volte al giorno le sue bambole, e che quella marchesina Mimi poi aveva anche tante vestaglie una più bella dell’altra, rosse, gialle, viola, a fiorellini, a ombrellini giapponesi… Possibile che ora stesse vestita sempre così, sempre con quel cappellino in capo, con quelle scarpine ai piedi, con quei braccialettini al polso, e quella catenella al collo da cui pendeva il ventaglino? Ah, com’era bello quel ventaglino di piume, ventaglino vero, che faceva un po’ di vento davvero, poco poco, quanto poteva bastare a quella piccola marchesina Mimi…
Ah, là, sì, in casa di Dolly, con tutte le cose adatte, il lettuccio di legno bianco e gli altri mobiletti e il ricco corredo, là sì sarebbe stata felice lei di servire quella bambola marchesina. Ma qua? Come non aveva pensato la Dolly che avrebbe dovuto anche darle almeno almeno il lettuccio e un po’ di corredo, non per far più ricco e compiuto il dono, ma perché la bambola non avesse a soffrire, e perché lei, Nenè, avesse modo di servirla? Come poteva così, senza nulla? Al più al più, col fiato e col dito, o con la punta d’una pezzuola, avrebbe potuto ripulirle le scarpettine di coppale. Nient’altro.
Quasi quasi era meglio ritornare da Dolly, con la bambola, e dirle:
«Oh mi dai da farla vivere com’è avvezza, o te la tieni».
Chi sa! Forse Dolly le avrebbe dato tutto…
Un lungo, grosso grosso sospiro sollevò il petto di Nenè accosciata lì davanti alla panchetta. Volse il capo, e in un momento, di nuovo abbagliata, vide in un angolo lercio del bugigattolino la cameretta della marchesina Mimi: Cameretta? un gran camerone, col tappeto azzurro vellutato, lì per terra, e il lettino di legno bianco, col parato a padiglione di seta celeste, e di là l’armadietto a specchio, le sedioline dorate, la specchiera; e vide sé, vestita bene come la mamma, tutta intenta a servire quella sua padroncina esigente e capricciosa; a prevenirne tutti i desiderii, per non farsi sgridare, che certo, per quanto ella facesse, la marchesina Mimi, lì sola con lei, benché circondata da tutti i suoi agi, da tutto il suo lusso, sarebbe stata a malincuore, senza più visite d’amiche, né di Moringhi, né passeggiate a cavallo. E, per sfogarsi, certo l’avrebbe comandata a bacchetta.
– Pronto il bagno?
– Ecco, un momentino, signora Marchesina…
– Ma il mio bagno dev’esser pronto subito, appena mi alzo! Che fate? Datemi adesso il mio cioccolato e i biscottini! La mia vestaglia, subito!
– Quale, signora Marchesina? Quella rossa? quella gialla? quella con gli ombrellini giapponesi?
– No, quella viola! Non lo sapete?
– Subito, signora Marchesina, eccola qua.
Vedeva, con gli occhi sbarrati, quel suo sogno là in quell’angolo incantato, Nenè, e parlava sola così da un pezzo, forte e imperiosa per conto della marchesina Mimi, umile e inchinevole per sé, da servetta amorosa che compatisce i capricci della padroncina tiranna; allorché, tutt’a un tratto, con un brivido di terrore alla schiena, vide una manaccia scabra, enorme, allungarsi sul suo capo e ghermire la bambola su la panchetta.
Insaccò la testa; poi, allibita, arrischiò di su la spalluccia, con la coda dell’occhio, uno sguardo.
Suo padre, dietro a lei, con un ghigno su le labbra ispide, guatava la bambola fragile in quella sua manaccia scabra e scrollava il capo, ripetendo:
– Ah, sì? ah, sì?
Con l’anima oppressa d’angoscia, gli vide levare l’altra mano, afferrare con due dita la falda del cappellino alla bambola, dare uno strappo violento.
Soffocò un gemito involontario.
Insieme col cappellino se n’era venuta la testa. E quella testa col cappellino e il busto decapitato, due strazii orribili, informi, volarono via per la finestra presso il tetto, accompagnati da un calcio e da una esclamazione rabbiosa:
– Su, in piedi! Non voglio signore, io, per casa!
Servitù – Audio lettura 1 – Legge Gaetano Marino
Servitù – Audio lettura 2 – Legge Enrica Giampieretti
Servitù – Audio lettura 3 – Legge Valter Zanardi
Servitù – Audio lettura 4 – Legge Giuseppe Tizza
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com