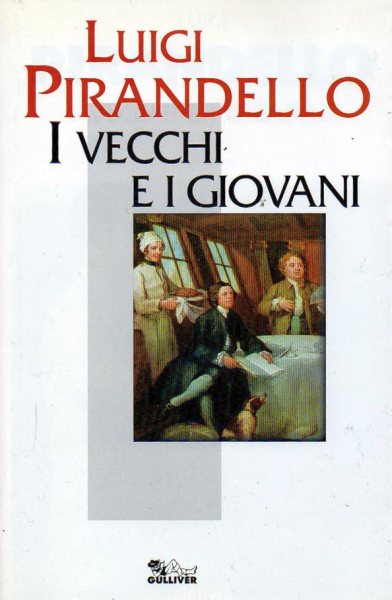««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «I Vecchi e i giovani» su Amazon
V.
Appena il primo albore filtrò lieve attraverso le foglie coriacee del caprifico in fondo alla vigna, Mauro Mortara, che vi stava sotto, con le spalle appoggiate al tronco, aggrottò le ciglia, ritirò le braccia e stirò la schiena rugliando; poi s’allargò tutto in un lungo sbadiglio e si rilassò richiudendo gli occhi come a cercar di nuovo il tepido bujo del sonno; ma udì un gallo cantare da un’aja lontana, un altro da più lontano rispondere; udì un frullo d’ali vicino, e si riscosse. I tre mastini, accucciati sotto l’albero intorno a lui, lo guardavano con occhi umidi, intenti, salutandolo amorosamente con la coda. Ma il padrone li guatò, seccato che lo avessero veduto dormire; poi si guatò le gambe distese aperte, rigide, su la terra cretosa della vigna; si scrollò dalle spalle il cappotto d’albagio; si stropicciò gli occhi acquosi col dorso delle mani; cavò infine dalla sacca, pendula da un ramo, tre tozzi di pan secco e li buttò in bocca alle bestie; si tirò sù sù in piedi e, appeso il cappotto all’albero, lo schioppo alla spalla, si mosse ancor mezzo trasognato per la vigna.
Non gli riusciva più vegliar tutta la notte: guardingo, a una cert’ora, come se qualcuno se ne potesse accorgere, andava a rintanarsi sotto quel caprifico; per poco, diceva a se stesso; ma stentava a destarsi di giorno in giorno vieppiù. Le gambe non eran più quelle d’una volta; anche la forza del polso non era più quella.
Ah, la sua bella vigna! Forse il vino di quell’anno lo avrebbe ancora bevuto; ma quello dell’anno venturo? Diede una spallata, come per dire: «Oh, alla fin fine…», e tornò a sbadigliare a quella prima luce del giorno che pareva provasse pena a ridestare la terra alle fatiche; guardò la distesa vasta dei campi, da cui tardava a diradarsi l’ultimo velo d’ombra della notte; poi si voltò a guardare il mare, laggiù, d’un turchino fosco, vaporoso, di tra le agavi ispide epingui ceppi glauchi dei fichidindia, che sorgevano e si storcevano in quella scialba caligine. La luna calante, sorta tardi nella notte, era rimasta a mezzo cielo, sorpresa dal giorno, e già smoriva nella crudezza della prima luce. Qua e là nella campagna entro quel velo lieve di nebbiolina bianchiccia fumigavano i fornelli dove si bruciava il mallo delle mandorle, e quel fumichìo, nell’immobilità dell’aria, saliva dritto al cielo.
Tuttavia, da due giorni, Mauro Mortara era meno aggrondato. Guardava ancora in cagnesco la villa; ma poi, pensando che Flaminio Salvo ogni mattina, a quell’ora, se ne partiva in carrozza o per Girgenti o per Porto Empedocle, e che non vi ritornava se non a tarda sera, tirava un respiro di sollievo, come se la vista del cascinone gli diventasse più lieve, sapendo che colui non c’era. Vi rimanevano, sì, coi servi, la moglie e la figliuola; ma quella, una povera pazza, tranquilla e innocua; e questa… – pareva impossibile! – questa, quantunque figlia di quel «malo cristiano», non era cattiva, no, anzi…
E Mauro, senza volerlo, volse in giro uno sguardo per vedere se donna Dianella fosse già per la vigna.
In pochi giorni, da che era a Valsanìa, s’era rimessa quasi del tutto; si levava per tempo, ogni mattina; aspettava che il padre partisse con la carrozza, e veniva a raggiunger lui là per la vigna, e gli domandava tante cose della campagna: degli olivi, come si governano; dei gelsi, che a marzo colgono sangue di nuovo è, quando sono in amore, per gettare, son molli come una pasta; poi si fermava sotto l’ombrellone del pino solitario laggiù dove l’altipiano strapiomba sul mare, per assistere alla levata del sole dalle alture della Crocea, in fondo in fondo all’orizzonte, livide prima, poi man mano cerulee, aeree e quasi fragili. Il primo a indorarsi al sole, ogni mattina, era quel pino là, che si stagliava maestoso su l’azzurro aspro e denso del mare, su l’azzurro tenue e vano del cielo.
In pochi giorni Dianella aveva fatto il miracolo: l’orso era domato. L’aria del volto, la nobiltà gentile e pure altera del portamento, la dolcezza mesta dello sguardo e del sorriso, la soavità della voce avevano fatto il miracolo, pianamente, naturalmente, andando incontro e vincendo la ruvidezza ombrosa del vecchio selvaggio.
Parlando, a volte, ella aveva nella voce e negli sguardi certe improvvise opacità, come se, di tratto in tratto, l’anima le si partisse dietro qualche parola e le andasse lontano lontano, chi sa dove; smarrita, se tardava a ritornarle, domandava: – Che dicevamo? – e sorrideva, perché lei stessa non sapeva spiegarsi ciò che le era avvenuto. Spesso anche, a ogni minimo tocco rude della realtà, provava quasi un improvviso sgomento, o, piuttosto, l’impressione di un’ombra fredda che le si serrasse attorno, e aggrottava un po’ le ciglia. Subito però cancellava con un altro dolce sorriso il gesto ombroso involontario, sgranando e ilarando gli occhi, rinfrancata.
«Perché mi si dovrebbe far male?», pareva dicesse a se stessa. «Non vado innanzi alla vita, fiduciosa e serena?»
La fiducia le raggiava da ogni atto, da ogni sguardo, e avvinceva. Anche quei tre mastini feroci del Mortara bisognava vedere che festa le facevano ogni volta! Si voltavano anch’essi, or l’uno or l’altro, a guardare verso la villa, come se l’aspettassero. E Mauro, per non allontanarsi troppo, s’indugiava a esaminare ora questo ora quel tralcio, i cui grappoli, tesori gelosamente custoditi, aveva già mostrati quasi a uno a uno a Dianella, gongolando accigliato alle lodi ch’ella gli profondeva tra vivaci esclamazioni di meraviglia:
– Uh, quanti qua!
– Carica, eh? E questo tralcio, guardate…
– Un albero… pare un albero!
– E qua, qua…
– Oh, più uva che pampini! E può sostenerla tant’uva, questa vite?
– Se non avrà male dal tempo…
– Che peccato sarebbe! E questa? – domandava, vedendo qualche vite atterrata. – È stato il vento? Ah, dev’essere ancora legata…
Oppure, più là:
– E questi? Vitigni selvaggi? Innesti nuovi, ho capito. Evviva, evviva… Ah, c’è pure compensi nella vita!
E nella voce pareva avesse la gioja dell’aria pura e del sole, quella stessa gioja che tremava nella gola delle allodole.
Per quel giorno Mauro le aveva promesso una visita al «camerone» del Generale: al «santuario della libertà». Ma i cani, a un tratto, drizzarono le orecchie; poi l’uno dopo l’altro s’avventarono senza abbajare verso il sentieruolo sotto la vigna, sul ciglio del burrone.
– Don Ma’! Don Ma’! – chiamò poco dopo, di lì, una voce affannata.
Mauro la riconobbe per quella di Leonardo Costa, l’amico di Porto Empedocle; e chiamò a sé i cani.
– Te’, Scampirro! Te’, Nèula! Qua, Turco!
Ma i cani avevano riconosciuto anch’essi il Costa e s’erano fermati al limite della vigna, scodinzolandogli dall’alto.
Sopravvenne Mauro.
– Il principale? È partito? – gli domandò subito Leonardo Costa, trafelato, ansante.
Era un omaccione dalla barba e dai capelli rossi, crespi, la faccia cotta dal sole e gli occhi bruciati dalla polvere dello zolfo. Portava agli orecchi due cerchietti d’oro; in capo, un cappellaccio bianco tutto impolverato e macchiato di sudore. Veniva di corsa da Porto Empedocle, per la spiaggia, lungo la linea ferroviaria.
– Non so, – gli rispose Mauro, fosco.
– Per favore, date una voce di costà, che aspetti; debbo parlargli di cosa grave.
Mauro scosse il capo.
– Correte, farete a tempo… Che vi è avvenuto?
Leonardo Costa, riprendendo la corsa, gli gridò:
– Guaj! guaj grossi alle zolfare!
«Maledetto lui e l’e zolfare!», brontolò Mauro tra sé.
Flaminio Salvo scendeva la scala della villa per montar su la vettura già pronta, quando Leonardo. Costa sbucò dal sentieruolo a ponente, di tra gli olivi, gridando:
– Ferma! Ferma!
– Chi è? Cos’è? – domandò il Salvo, con un soprassalto.
– Bacio le mani a Vossignoria, – disse il Costa, togliendosi il cappellaccio e accostandosi senza più fiato e tutto grondante di sudore. – Non ne posso più… Volevo venire stanotte… ma poi…
– Ma poi? Che cos’è? che hai? – lo interruppe, brusco, il Salvo.
– Ad Aragona, a Comi tini, tutti i solfaraj, sciopero! – annunziò il Costa.
Flaminio Salvo lo guardò con freddo cipiglio, lisciandosi le lunghe basette grige che, insieme con le lenti d’oro, gli davano una certa aria diplomatica, e disse, sprezzante:
– Questo lo sapevo.
– Sissignore. Ma jersera, sul tardi, – riprese il Costa, – è arrivata a Porto Empedocle gente da Aragona e ha raccontato che tutto jeri hanno fatto l’ira di Dio nel paese…
– I solfaraj?
– Sissignore: picconieri, carusi, calcheronaj, carrettieri, pesatori: tutti! Hanno finanche rotto il filo telegrafico. Dice che hanno assaltato la casa di mio figlio, e che Aurelio ha tenuto testa, come meglio ha potuto…
Flaminio Salvo, a questo punto, si voltò a spiare acutamente gli occhi di Dianella che s’era accostata alla vettura. Quello sguardo strano, rivolto alla figlia a mezzo del discorso, frastornò il Costa, il quale si voltò anche lui a guardare la «signorinella», com’egli la chiamava. Questa di pallida si fece vermiglia, poi subito pallida di nuovo.
– Dunque? – gridò Flaminio Salvo, con ira.
– Dunque, sissignore, – riprese il Costa, sconcertato. – Guajo grosso, non c’è soldati; il paese, nelle loro mani. Due carabinieri soli, il maresciallo e il delegato… Che possono fare?
– E che posso fare io di qua, me lo dici? – gridò il Salvo su le furie. – Tuo figlio Aurelio che cos’è? il signor ingegnere direttore, venuto dall’École des Mines di Parigi, che cos’è? Marionetta? Ha bisogno che gli tiri io il filo di qua, per farlo muovere?
– Ma nossignore, – disse Leonardo Costa, ritraendosi d’un passo, come se il Salvo lo avesse sferzato in faccia. – Può star sicuro Vossignoria che mio figlio Aurelio sa quello che deve fare. Testa e coraggio… non tocca a dirlo a me… ma di fronte a duemila uomini, tra solfaraj e carrettieri, mi dica Vossignoria… Del resto, il guajo è un altro, fuori del paese. Aurelio ha mandato ad avvertirmi jeri sera che quelli hanno catturato per lo stradone gli otto carri di carbone che andavano alle zolfare di Monte Diesi.
– Ah, sì? – fece il Salvo, sghignando.
– Vossignoria sa, – seguitò il Costa – che il carbone lassù per le pompe dei cantieri è come il pane pei poverelli, e anche più necessario. Vossignoria va a Girgenti? Vada subito dal prefetto perché mandi soldati alla stazione d’Aragona, quanti più può, per fare scorta al carbone fino alle zolfare. Ci son sette vagoni pieni per rinnovare il deposito; i carrettieri sono in isciopero anch’essi; ma il carbone si potrà caricare su i muli e su gli asini, scortati dalla forza: ci metteranno più tempo, ma almeno si potrà scongiurare il pericolo che la zolfara grande, laCace, Dio liberi, s’allaghi…
– E s’allaghi! s’allaghi! s’allaghi! – scattò, furente, Flaminio Salvo, levando le braccia. – Vada tutto alla malora! Non m’importa più di niente! Io chiudo, sai! e mando tutti a spasso, te, tuo figlio, tutti, dal primo all’ultimo, tutti! Caccia via! Andiamo! – ordinò al cocchiere.
La carrozza si mosse, e Flaminio Salvo partì senza neppur voltarsi a salutare la figlia.
Alla sfuriata insolita, don Cosmo s’era affacciato a una finestra della villa e donna Sara Alàimo s’era fatta sul pianerottolo della scala. L’uno e l’altra, e giù Dianella e il Costa rimasero come intronati. Il Costa alla fine si scosse, alzò il capo verso la finestra e salutò amaramente:
– Bacio le mani, si-don Cosmo! Ha ragione, lui: è il padrone! Ma per quel Dio messo in croce, creda pure, si-don Cosmo mio, creda, Signorinella: non sono prepotenze! La fame è fame, e quando non si può soddisfare…
Donna Sara dal pianerottolo scrollò il capo incuffiato, con gli occhi al cielo.
– Mangia il Governo, – seguitò il Costa, – mangia la Provincia; mangia il Comune e il capo e il sottocapo e il direttore e l’ingegnere e il sorvegliante… Che può avanzare per chi sta sotto terra e sotto di tutti e deve portar tutti sulle spalle e resta schiacciato?… Ah Dio! Sono un miserabile, un ignorante sono; e va bene: mi pesti pure sotto i piedi finché vuole. Ma mio figlio, no! mio figlio non me lo deve toccare! Gli dobbiamo tutto, è vero; ma anche lui, se è ancora lì, padrone mio riverito, che mi può anche schiaffeggiare, ché da lui mi piglio tutto e gli bacio anzi le mani; se ancora è lì che comanda e si gode le sue belle ricchezze, lo deve pure a mio figlio, lo deve: lei lo sa, Signorinella, e fors’anche lei, si-don Cosmo… siamo giusti!
– Già, già, – sospirò il Laurentano dalla finestra, – l’affare delle zucche…
– Che zucche? – domandò, incuriosita, donna Sara Alàimo.
– Ma! – fece il Costa. – Ve lo farete raccontare qualche volta dalla Signorinella qua, che conosce bene mio figlio, perché son cresciuti insieme, anche con quell’altro ragazzo, suo fratellino, che il Signore volle per sé e fu una rovina per tutti. La povera signora, là, che me la ricordo io, bella, un occhio di sole! ci perdette la ragione; e lui, povero galantuomo… chi ha figli lo compatisce…
Dianella, col cuore gonfio per la durezza del padre, a questo ricordo non potè più reggere e, per nascondere il turbamento, prese il sentieruolo per cui il Costa era venuto, e sparve tra gli olivi.
Subito donna Sara, poi anche don Cosmo invitarono il Costa ad andar sù, per farlo rimettere un po’ dalla corsa e non lasciarlo così sudato alla brezza del mattino. Donna Sara avrebbe voluto far di più: offrirgli una tazzina di caffè; ma per non perdere una parola del discorso fitto fitto che il Costa aveva attaccato subito con don Cosmo sul Salvo, ora che la figliuola non poteva più sentirlo, finse di non pensarci.
– Ci conosciamo, santo Dio, ci conosciamo, si-don Co’ ! Che era lui, alla fin fine? Io, sì, coi piedi scalzi, ho portato in collo, lo dico e me ne vanto; in collolo zolfo e il carbone, dalla spiaggia alle spigonare. Il latino come dice? Necessitas non abita legge. Sissignore; e sono stato stivatore, e me ne vanto, misero staderante agl’imbarchi per la dogana, e me ne vanto. Lui, però, che cos’era? Di nobile casato, sissignore; ma un sensaluccio era, che veniva da Girgenti a Porto Empedocle, tutto impolverato per lo stradone della Spinasanta, perché non aveva neanche da pagarsi la carrozza o d’affittarsi un asinelio, allora che la ferrovia non c’era. E i primi piccioli, come li fece? Lo sa Dio e tanti lo sanno, tra i morti e i morti. Poi prese l’appalto delle prime ferrovie, insieme col cognato che ora sta a Roma, signor ingegnere, banchiere, commendatore, don Francesco Velia, che conosciamo anche lui…
– Ah, – fece donna Sara, – ha un’altra sorella, lui?
– Come no? – rispose il Costa, sospendendo gli inchini con cui aveva accompagnato ogni titolo del Velia, – donna Rosa, maggiore di tutti, moglie del – (e s’inchinò ancora una volta) – commendatore Francesco Velia, pezzo grosso dell’Amministrazione delle ferrovie adesso. La linea qua, da Girgenti a Porto Empedocle, non la fece lui? Balla comare, che fortuna suona! Centinaja di migliaja di lire, sorella mia; denari a cappellate, come fossero stati rena… Due ponti e quattro gallerie… Allunga là un gomito; taglia qua a scarpa… Poi altre imprese di linee… Tutta la ricchezza gli è venuta di là, dico bene, si-don Co’? Ci conosciamo!
– E le zucche? le zucche? – tornò a domandare donna Sara.
Bisognò che il Costa gliela narrasse per minuto, quella famosa storia delle zucche; e donna Sara lo compensò con le più vivaci esclamazioni di stupore, di raccapriccio, d’ammirazione del vocabolario paesano, battendo di tratto in tratto le mani, per scuotere don Cosmo, il quale, conoscendo la storia, era ricaduto nel suo solito letargo filosofico. Si scosse alla fine, ma senza aprir gli occhi; pose una mano avanti, disse:
– Però…
– Ah, sì! – riattaccò subito con enfasi il Costa, battendosi le due manacce sul petto. – In coscienza, un’anima sola abbiamo, davanti a Dio, e debbo dire la verità. Ma mio figlio, oh, si-don Cosmo – (e il Costa levò una mano con l’indice e il pollice giunti, in atto di pensare) – tutti i figli saranno figli, ma quello! cima! diritto come una bandiera! in tutte le scuole, il primo! Appena laureato, subito il concorso per la borsa di studio all’estero… Erano, sorella mia, più di quattrocento giovani ingegneri d’ogni parte d’Italia: tutti sotto, tutti sotto se li mise! E mi stette fuori quattr’anni, a Parigi, a Londra, nel Belgio, in Austria. Appena tornato a Roma, senza neanche farlo fiatare, il Governo gli diede il posto nel Corpo degli ingegneri minerarii, e lo mandò in Sardegna, a Iglesias, dove ci fece un lavoro tutto colorato su una montagna… Sarrubbas… non so… ah, Sarrabus, già, dico bene, Sarrabus (parlano turco, in Sardegna), un lavoro che fa restare, sorella mia, allocchiti. Ci stette poco, un anno, poco più, perché la Società francese, di quelle che… i marenghi, a sacchi… vedendo quella carta, rimase a bocca aperta. Non lo dico perché è figlio mio; ma quanti ingegneri c’è, qua e fuorivia? se li mette in tasca tutti! Basta. Questa Società francese, dice, qua c’è la cassa, figlio mio, tutto quello che volete. Aurelio, tra il sì e il no, d’accettare, venne qua in permesso – saranno sei o sette mesi – per consigliarsi con me e col principale, suo benefattore, ch’egli rispetta come suo secondo padre e fa bene! Il principale stesso gli sconsigliò d’accettare, perchélo volle per sé, capite? per badare alle sue zolfare d’Aragona e Comi tini. Noi diciamo: il poco mi basta, l’assai mi soverchia… Accettò, ma ci scàpita, parola d’onore! E con tutto questo, ora… ora è marionetta, l’avete inteso?… Cristo sacrato!
Leonardo Costa levò un braccio, si alzò, sbuffò per il naso, scrollando il capo, e prese dalla sedia il cappellaccio bianco. Doveva andar via subito; ma ogni qual volta si metteva a parlare di quel suo figliuolo, lustro, colonna d’oro della sua casa, non la smetteva più.
– Bacio le mani, si-don Cosmo, mi lasci scappare. Donna Sara, servo vostro umilissimo.
– Oh, e aspettate! – esclamò questa, fingendo di ricordarsi, ora che il discorso era finito. – Un sorsellino di caffè…
– No no, grazie – si schermì il Costa. – Ho tanta fretta!
– Cinque minuti! – fece donna Sara, levando le mani a un gesto che voleva dire: «Non casca il mondo!».
E s’avviò. Ma il Costa, sedendo di nuovo, sospirò, rivolto a don Cosmo:
– C’è una mala femmina, si-don Co’, una mala femmina che da qualche tempo a questa parte mette male tra mio figlio e don Flaminio; io lo so!
E donna Sara non potè più varcare la soglia: si volto, strizzò gli occhi, arricciò il naso e chiese con una mossettina del capo: – Chi è?
– Non mi fate sparlare ancora, donna Sara mia! – sbuffò il Costa. – Ho parlato già troppo!
Ma, tanto, donna Sara Alàimo aveva già compreso di quale mala femmina egli intendesse parlare, e uscì, esclamando con le mani per aria:
– Che mondo! che mondo!
Dianella non s’affrettò quella mattina a raggiungere Mauro alla vigna. Quello sguardo duro del padre nell’ira, mentre il Costa parlava del pericolo da cui il figlio era minacciato in Aragona, le aveva in un baleno richiamato alla memoria un altro sguardo di lui, di tanti anni addietro, quando il fratellino era morto e la madre impazzita.
Aveva undici anni, lei, allora.
E più della morte del fratello, più della sciagura orrenda della madre le era rimasta indelebile nell’anima l’impressione di quello sguardo d’odio che a lei – ragazzetta ancor quasi ignara, incerta e smarrita tra i giuochi e la pena – aveva lanciato il padre, nel cordoglio rabbioso:
«Non potevi morir tu invece?», le aveva detto chiaramente quello sguardo.
Così. Proprio così. E Dianella comprendeva bene adesso perché il padre non avrebbe esitato un momento a dar la vita di lei in cambio di quella del fratello.
Tutte le cure e l’affetto e le carezze e i doni, di cui egli l’aveva poi colmata, non erano più valsi a scioglierle dal fondo dell’anima il gelo, in cui quello sguardo s’era quasi rappreso e indurito. Spesso se n’adontava con se stessa, sentendo che il calore dell’affetto paterno non riusciva più a penetrare in lei, quasi respinto istintivamente da quel gelo.
Per qual ragione seguitava egli ormai a lavorare con tanto accanimento? ad accumulare tanta ricchezza? Non per lei, certamente; sì per un bisogno spontaneo, prepotente, della sua stessa natura; per dominare su tutti; per esser temuto e rispettato; o fors’anche per stordirsi negli affari o per prendersi a suo modo una rivincita su la sorte che lo aveva colpito. Ma in certi momenti d’ira (come dianzi), o di stanchezza o di sfiducia, lasciava pur vedere apertamente che tutte le sue imprese e i suoi sforzi e la sua vita stessa non avevano più scopo per lui, perduto l’erede del nome, colui che sarebbe stato il continuatore della sua potenza e della sua fortuna.
Da un pezzo, convinta di questo, Dianella, pur non sapendo neanche immaginare la propria vita priva di tutto quel fasto che la circondava, aveva cominciato a sentire un segreto dispetto per quella ricchezza del padre, di cui un giorno (il più lontano possibile!) ella sarebbe stata l’unica erede, per forza e senza alcuna soddisfazione per lei. Quante volte, nel vederlo stanco e irato, non avrebbe voluto gridargli: «Basta! Lascia! Perché la accresci ancora, se dev’esser poi questa la fine?». E altro ancora, ben altro avrebbe voluto gridargli, se con l’anima avesse potuto arrivare all’anima del padre, senza che le labbra si movessero e udissero gli orecchi.
Da quanto aveva potuto intendere col finissimo intuito e penetrare con quegli occhi silenziosamente vigili e da certi discorsi colti a volo senza volerlo, aveva già coscienza che la ricchezza del padre, se non al tutto male acquistata, aveva pur fatto molte vittime in paese. Crudele con lui la sorte, crudele la rivincita che si prendeva su essa. Voleva tutto per sé, tutto in suo pugno: zolfare e terre e opificii, il commercio e l’industria dell’intera provincia. Ora perché gravare su le esili spalle di lei – figlia… sì, amata, ma non prediletta, quantunque rimasta sola – il fardello di tutte quelle ricchezze, che molti forse maledicevano in segreto e che certo non le avrebbero portato fortuna? Eppure s’era illusa, fino a poco tempo fa, che il padre l’avrebbe lasciata libera nella scelta; che anzi egli stesso la avesse ajutata a scegliere, beneficiando colui che, da ragazzo, gli aveva salvato la vita. Bruno, come fuso nel bronzo, coi capelli ricci, neri, e gli occhi fermi e serii, Aurelio Costa le era apparso la prima volta, a tredici anni; era stato poi per tanto tempo suo compagno di giuoco, suo e del fratellino. Tutt’e tre, ragazzi, non capivano allora che differenza fosse tra loro. Alla morte del fratellino però, Aurelio era man mano divenuto con lei sempre più timido e circospetto; non aveva più voluto giocare come prima; era cresciuto tanto; gli s’era àlterata la voce; s’era messo a studiare, a studiare; e lei, che allora non aveva più di dodici anni, s’era contentata d’assistere zitta zitta al suo studio, fingendo di studiare anche lei; ogni tanto, in punta di piedi, andava a tiragli un ricciolo sulla nuca. A diciott’anni Aurelio era poi partito per iscriversi all’Università di Palermo nella facoltà d’ingegneria. Senza più lui, la casa per tanti mesi era rimasta per lei come vuota; aveva l’impressione di quella sua prima solitudine, come se avesse passato tutto un inverno interminabile con la fronte appoggiata ai vetri d’una finestra su cui le gocce della pioggia scorrevano come lagrime, su cui qualche mosca superstite, morta di freddo, rimaneva attaccata e lei con un dito, toccandola appena, la faceva cadere. Forse da allora la sua fronte, per il contatto di quei vetri gelati, le era rimasta così come fasciata di gelo. Ma che esultanza poi al ritorno di lui, finito l’anno scolastico! Era stata così vivace e piena di giubilo quella festa, che il padre, appena andato via Aurelio, se l’era chiamata in disparte e pian piano, con garbo, carezzandole i capelli, le aveva lasciato intendere che sarebbe stato bene frenarsi, perché era ormai un giovanotto quel suo antico compagno di giuoco, a cui non bisognava più dare del tu. Senza saperne bene il perché s’era fatta di bragia: oh Dio, e come allora, del lei? non era più lo stesso Aurelio? No, non era più lo stesso Aurelio, neanche per lei; e se n’era accorta sempre di più di anno in anno ai ritorni di lui, finché all’ultimo, presa la laurea, egli aveva manifestato l’intenzione di concorrere a una borsa di studio all’estero. Lui, proprio lui non era più lo stesso; perché lei, invece… sì, con la bocca, signor Aurelio, ma con gli occhi seguitava a dargli del tu. Prima di partire per Parigi, era venuto a ringraziare il suo benefattore, a giurargli eterna gratitudine; a lei non aveva saputo quasi dir nulla, quasi non aveva osato guardarla, fors’anche non s’era accorto né del pallore del volto né del tremito della mano di lei. E tuttavia non s’era perduta; aveva fatto anzi tanto più certo in sé il suo sentimento, quanto più incerta era rimasta sul conto di lui. Era sicura, superstiziosamente, ch’egli le fosse destinato. Dopo la partenza, più volte aveva sentito il padre parlare del valore eccezionale di quel giovine e dello splendido avvenire che avrebbe avuto, e lodarsi di quanto aveva fatto per lui, di averlo trattato come un figliuolo. Naturalmente questi discorsi le avevano ravvivato sempre più nel cuore il fuoco segreto e sempre più acceso la speranza che il padre, avendo perduto l’unico figliuolo, e avendo quasi creato lui quest’altro al quale pur doveva la vita, avrebbe preferito che a lui, anziché a un altro più estraneo, andassero un giorno le ricchezze e la figlia. S’era maggiormente raffermata in questa speranza pochi mesi fa, quando Aurelio, ritornato dalla Sardegna, era stato assunto dal padre alla direzione delle zolfare. Non lo aveva più riveduto dal giorno della partenza per Parigi. Oppressa, tra il vano fasto, dalla vita meschina di Girgenti, vecchia città, non zotica veramente, ma attediata nel vuoto desolato dei lunghi giorni tutti uguali, sempre con quel giro di visite delle tre o quattro famiglie conoscenti che gareggiavano d’affetto e di confidenza verso di lei, ch’era come la reginetta del paese, fra le spiritosaggini solite dei soliti giovanotti eleganti, anneghittiti, immelensiti nella povera e ristretta vita provinciale, s’era riscossa alla vista di lui così maschio e padrone di sé. La gioja di rivederlo le s’era però d’un subito offuscata al sopravvenire di Nicoletta Spoto, da un anno appena moglie del Capolino. Aveva notato uno strano imbarazzo, un vivo turbamento tanto in costei quanto in Aurelio, allorché questi, introdotto nel salone, s’era inchinato a salutare. Poi, appena il padre aveva condotto via con sé nello studio Aurelio, la Capolino, rifiatando, aveva narrato con focosa vivacità a lei e alla zia Adelaide, che quel poveretto lì, tutto impacciato, aveva nientemeno osato di mandare a chiederla in isposa, subito dopo ottenuto il posto d’ingegnere governativo in Sardegna, ricordandosi forse di qualche occhiatina scambiata tanti e tanti anni addietro, quand’egli era ancora studentello all’istituto. Figurarsi che orrore aveva provato lei, Lellè Spoto, a una tal richiesta, e come s’era affrettata a rifiutare, tanto più che già erano avviate le prime pratiche per il matrimonio con Ignazio Capolino. S’era sentita voltare il cuore in petto a questa notizia inattesa; s’era fatta certo di mille colori e certo s’era tradita con quella donna, di cui già conosceva la relazione segreta e illecita col padre. Non le aveva detto nulla; ma quando Aurelio, dopo la lunga udienza, era ritornato in salone, lei, tutta accesa in volto lo aveva accolto apposta con premure esagerate, ricordandogli i giorni passati insieme, i giuochi, le confidenze. E più volte, con gioja, aveva veduto colei mordersi il labbro e impallidire. Dianella sperava che Aurelio, almeno quella volta, avesse compreso. Lo aveva subito scusato in cuor suo del tradimento, di cui non poteva aver coscienza, non credendo di poter ardire di alzar gli occhi fino a lei; ma… intanto, ah! proprio a quella donna lì, sotto ogni riguardo indegna di lui, era andato a pensare! E il rifiuto di quella donna le era sembrato quasi un’offesa diretta anche a lei. Però, ecco, egli era stato a Parigi; la vivacità, la capricciosa disinvoltura di Nicoletta Spoto avevano forse acquistato allora un gran pregio agli occhi di lui, ricordandogli probabilmente le donne conosciute e ammirate colà. D’umilissimi natali, aveva creduto forse di fare un gran salto imparentandosi con una famiglia come quella della Spoto, molto ricca un giorno, ora decaduta, ma tuttavia tra le più cospicue del paese. Costei ora, certo, avvalendosi del potere che aveva sul padre, si vendicava dell’affronto patito quella volta. Anche lei, Dianella, aveva notato che da qualche tempo il padre non si mostrava più contento di Aurelio; e che da alcune sere lì, nella villa, parlando con don Cosmo Laurentano, insisteva su certe domande che le davano da pensare. Segretamente, lei disapprovava quelle nozze strane della zia col principe don Ippolito, ne aveva quasi onta, sospettando nel padre un pensiero nascosto: che cioè si volesse servire di quelle nozze non certo onorevoli per introdursi nella casa dei Laurentano e attrarre a sé a poco a poco anche le sostanze di questa. Da alcune sere, a cena, il discorso di don Cosmo cadeva, insistente, sul figlio del principe, su Lando Laurentano, che viveva a Roma. Perché? Assorta in questi pensieri, Dianella s’era seduta sotto un olivo sul ciglio del profondo burrone e guardava la dirupata costa dirimpetto, dove pascolava una greggiola di capre scesa dalle terre di Platanìa. Il giorno dopo l’arrivo in quella campagna, s’era sentita quasi rinascere. L’aria di selvatica rustichezza, che la vecchia villa aveva preso nell’abbandono; la malinconia profonda che da quell’abbandono pareva si fosse diffusa tutt’intorno, nei viali, nei sentieri solinghi, quasi scomparsi sotto le borracine e le tignàmiche, ove l’aria – fresca dell’ombra degli olivi e dei mandorli o delle alte spalliere di fichidindia – era satura di fragranze, amare di prugnole, dense e acute di mentastri e di salvie; e quell’ampio burrone precipite; e la chiara e gaja vicinanza del mare; e quegli alberi antichi, non curati, irti di «polloni selvaggi, sognanti nel silenzio della solitudine immensa, si accordavano soavemente con l’animo in cui ella si trovava. Ora, invece, quei discorsi del padre… l’ira contro Aurelio… e quello sciopero di solfaraj ad Aragona… le minacce… E lei, lì sola, senza nessuno veramente con cui votarsi il cuore… Aver la madre e non potersi rivolgere a lei, e vedersela davanti, peggio che morta – viva e vana… Lustreggiava per un tratto, tra i culmi radi delle canne in fondo al burrone un ruscelletto che a un certo punto era stato tagliato dai lavori di presa per la linea ferroviaria. Vi fissò gli occhi e le sorse allora spontanea l’immagine che lei fosse rimasta appunto come un ruscello a cui una mano ignota per malvagio capriccio avesse traviato la vena presso la fonte con irti e gravi sassi; e l’acqua di là si fosse sparsa stagnante, e di qua il ruscello si fosse raddensato in rena e in ciottoli. Ah, che sete inestinguibile le era rimasta dell’amore materno! Ma s’appressava alla madre, e questa non la riconosceva per figlia. Il dolore di lei così vicino e urgente non si ripercoteva per nulla in quella coscienza spenta.
– Vittoria Vivona d’Alessandria della Rocca, – diceva la madre di se stessa, con voce che pareva arrivasse di lontano. – Bella fig!ia! bella figlia! Aveva una treccia di capelli che non finiva mai; tre donne gliela pettinavano… Cantava e sonava. Sonava anche l’organo in chiesa, a Santa Maria dell’Udienza, e gli angioletti stavano a sentirla, in ginocchio e a mani giunte, così… Doveva sposare un riccone di Girgenti; le venne un mal di capo, e morì…
Dianella non potè più frenare le lagrime e si mise a piangere silenziosamente, con amara voluttà in quella solitudine. Ma il silenzio attorno era così attonito, e così intenso e immemore il trasognamento della terra e di tutte le cose, che a poco a poco se ne sentì attratta e affascinata. Le parvero allora gravati da una tristezza infinita e rassegnata quegli alberi assorti nel loro sogno perenne, da cui invano il vento cercava di scuoterli. Percepì, in quella intimità misteriosa con la natura, il brulichìo delle foglie, il ronzìo degli insetti; e non sentì più di vivere per sé; visse per un istante quasi incosciente, con la terra, come se l’anima le si fosse diffusa e confusa in tutte le cose della campagna. Ah, che freschezza d’infanzia nell’erbetta che le sorgeva accanto! e come appariva rosea la sua mano sul tenero verde di quelle foglie! oh, ecco un maggiolino sperduto, fuor di stagione, che le scorreva su la mano… Com’era bello! piccolo e lucido più d’una gemma! E poteva dunque la terra, tra tante cose brutte e tristi, produrne pure di così gentili e graziose?
Trascorse, quasi in risposta, su quelle foglie, su la sua mano come un lieve e fresco alito di gioja. Dianella trasse un sospiro e aspettò con la mano su l’erba che l’insetto ritrovasse la sua via tra le foglie, poi si scosse di soprassalto all’arrivo festoso improvviso dei tre mastini che le si fecero attorno, anzi sopra, impazienti, scostandosi l’un l’altro, per aver sul capo la carezza delle sue mani. E non la lasciavano alzare. Alla fine sopraggiunse Mauro Mortara.
– Vi siete sentita male? – le domandò, cupo, senza guardarla.
– No… niente… – gli rispose, schermendosi con le braccia dalle piote e dalle linguate dei cani, e sorridendo mestamente. – Un po’ stanca…
– Qua! – gridò forte Mauro ai tre mastini, perché la lasciassero in pace.
E subito quelli restarono, come impietriti dal grido. Dianella sorse in piedi e si chinò a carezzarli di nuovo, in compenso della sgridata.
– Poverini… poverini…
– Se volete venire… – propose Mauro.
– Eccomi. A veder la stanza del Generale? Ho tanta curiosità…
Era impacciata nel parlargli, non sapendo ancor bene se dargli del voi o del tu.
– Vostro padre è partito?
– Sì, sì, – s’affrettò a rispondergli; e subito si pentì della fretta che poteva dimostrare in lei quel sollievo stesso che provavano tutti quando il padre era assente. – Ad Aragona, – disse – si sono ribellati i solfaraj. Bisognerà mandarci soldati e carabinieri.
– Piombo! piombo! – approvò Mauro subito, scotendo energicamente il capo. – Sbirro, vi giuro, andrei a farmi, vecchio come sono!
– Forse… – si provò a dire Dianella.
Ma il Mortara la interruppe con una sua abituale esclamazione.
– Oh Marasantissima, lasciatevi servire!
Non ammetteva repliche, Mauro Mortara. Nelle sue perpetue ruminazioni vagabonde tra la solitudine della campagna, s’era a modo suo sistemato il mondo, e ci camminava dentro, sicuro, da padreterno, lisciandosi la lunga barba bianca e sorridendo con gli occhi alle spiegazioni soddisfacenti che aveva saputo darsi d’ogni cosa. Tutto ciò che accadeva, doveva rientrar nelle regole di quel suo mondo. Se qualche cosa non poteva entrarci, egli la tagliava fuori, senz’altro, o fingeva di non accorgersene. Guai a contraddirlo!
– Oh Marasantissima, lasciatevi servire! Che pretendono? Voglio sapere che pretendono! Dobbiamo tutti ubbidire, dal primo all’ultimo, tutti, e ognuno stare al suo posto, e guardare alla comunità! Perché questi pezzi di galera, figli di cane ingrati e sconoscenti, debbono guastare a noi vecchi la soddisfazione di vedere questa comunità, l’Italia, divenuta per opera nostra quella che è? Che ne sanno, di cos’era prima l’Italia? Hanno trovato la tavola apparecchiata, la pappa scodellata, e ora ci sputano sopra, capite? Intanto, guardate: Tunisi è là!
Si voltò verso il mare e col braccio teso indicò, fosco, un punto nell’orizzonte lontano. Dianella si volse a guardare, senza comprendere come c’entrasse Tunisi. Ella lo lasciava dire e non l’interrompeva mai, se non per approvare tutti quegli sproloquii patriottici eh egli le faceva.
– È là! – ripetè Mauro fieramente. – E ci sono i Francesi là, che ce l’hanno presa a tradimento! E domani possiamo averli qua, in casa nostra, capite? Vi giuro che non ci dormo, certe notti, e mi mordo le mani dalla rabbia! E invece d’impensierirsi di questo, quei mascalzoni là pensano a fare scioperi, ad azzuffarsi tra loro! Tutta opera dei preti, sapete? Cima di birbanti! schiuma d’ogni vizio! abissi di malizia! Soffiano nel fuoco, sotto sotto, per smembrare di nuovo l’Italia… I Sanfedisti! i Sanfedisti! Io debbo guardarmi davanti e dietro, perché me l’hanno giurata e mi contano i passi. Ma con me le spese ci perdono… Guardate qua!
E mostrò a Dianella i due pistoloni napoletani che gli pendevano dalla cintola.
Quella visita alla famosa stanza del Generale, detta per antonomasia il Camerone, era una grazia veramente particolare concessa a Dianella. Mauro Mortara, che ne teneva la chiave, non vi lasciava entrar mai nessuno. E non l’uscio soltanto, ma anche le persiane dei due terrazzini e della finestra stavano sempre chiuse, quasi che l’aria e la luce, entrandovi apertamente, potessero fugare i ricordi raccolti e custoditi con tanta gelosa venerazione.
Certo, dopo la partenza del vecchio principe per l’esilio, uscio e finestre erano stati spalancati chi sa quante volte; ma il Mortara, da che era ritornato a Valsanìa, aveva tenute almeno le persiane sempre chiuse così, e aveva l’illusione che così appunto fossero rimaste da allora, sempre, e che però quelle pareti serbassero ancora il respiro del Generale, l’aria di quel tempo.
Questa illusione era sostenuta dalla vista della suppellettile rimasta intatta, tranne la lettiera d’ottone a baldacchino, che non aveva più né materasse, né tavole, né l’ampio parato a padiglione.
Quella penombra era così propizia alla rievocazione dei lontani ricordi!
Mauro, ogni volta, girava un po’ per la stanza; si fermava innanzi a questo o a quel mobile decrepito, dall’impiallacciatura gonfia e crepacchiata qua e là;poi andava a sedere sul divano imbottito d’una stoffa verde, ora ingiallita, con due rulli alla base di ciascuna testata, e lì, con gli occhi socchiusi, lisciandosi con la piccola mano tozza e vigorosa la lunga barba bianca, pensava, e più spesso ricordava, assorto, come in chiesa un divoto nella preghiera.
Non lo disturbavano neppure i topi che facevano talvolta una gazzarra indiavolata sul terrazzo di sopra, il cui piano, per impedire che il soffitto del camerone rovinasse, s’era dovuto ricoprire di lastre di bandone. Il rimedio era giovato poco e per poco tempo; le lastre di bandone s’erano staccate e accartocciate al sole, con molta soddisfazione dei topi che, rincorrendosi, vi s’appiattavano; e il soffitto già s’era aggobbato, gocciava d’inverno per due o tre stillicidi!, e le pareti serbavano, anche d’estate, due larghe chiose d’umido, grommose di muffa. Don Cosmo non se ne dava pensiero: non entrava quasi mai nel camerone; Mauro non voleva che si riattasse: poco più gli restava da vivere e voleva che tutto lì rimanesse com’era; sapeva che, morto lui, nessuno si sarebbe preso più cura di custodire quel «santuario della libertà»; e il soffitto allora poteva anche crollare o essere riattato. Intanto, ogni anno, al sopravvenire dell’autunno, egli si recava sul terrazzo a rassettare e fissar le lastre di bandone con grosse pietre, e sul pavimento del camerone collocava concole e concoline sotto gli stillicidii. Le gocce vi piombavan sonore, ad una ad una; e quel tin-tan cadenzato pareva gli conciliasse il raccoglimento.
Dianella, entrando, ebbe subito come un urto dalla vista inattesa d’una belva imbalsamata che, nella penombra, pareva viva, là, nella parete di fronte, presso l’angolo, con la coda bassa e la testa volta da un lato, felinamente.
– Che paura! – esclamò, levando le mani verso il volto e sorridendo d’un riso nervoso. – Non me l’aspettavo… Che è?
– Leopardo.
– Bello!
E Dianella abbassò una mano a carezzare quel pelame variegato; ma subito la ritrasse tutta impolverata, e notò che alla belva mancava uno degli occhi di vetro, il sinistro.
– Un altro, compagno a questo, – riprese Mauro – l’ho regalato al Museo dell’istituto, a Girgenti. Non l’avete mai veduto? C’è una vetrina mia, nel Museo. Accanto al leopardo, una jena, bella grossa, e, sopra, un’aquila imperiale. Su la vetrina sta scritto: Cacciati, imbalsamati e donati da Mauro Mortara. Gnorsì. Ma venite qua, prima. Voglio farvi vedere un’altra cosa.
La condusse davanti al vecchio divano sgangherato.
Appese alla parete, sopra il divano, eran quattro medaglie, due d’argento, due di bronzo, fisse in una targhetta di velluto rosso ragnato e scolorito. Sopra la targhetta era una lettera, chiusa in cornice, scritta di minutissimo carattere in un foglietto cilestrino, sbiadito.
– Ah, le medaglie! – esclamò Dianella.
– No, – disse Mauro, turbato, con gli occhi chiusi. – La lettera. Leggete la lettera.
Dianella s’accostò di più al divano e lesse prima la firma: GERLANDO LAURENTANO.
– Del Generale?
Mauro, ancora con gli occhi chiusi, accennò di sì col capo, gravemente.
E Dianella lesse:
Amici,
Le notizie di Francia, il colpo di Stato di Luigi Napoleone recheranno certamente una grave e lunga sosta al movimento per la nostra santa causa e ritarderanno, chi sa fino a quando, il nostro ritorno in Sicilia.
Vecchio come sono, non so né posso più sopportare il peso di questa vita d’esilio.
Penso che non sarò più in grado di prestare il mio braccio alla Patria, quand’essa, meglio maturati li eventi, ne avrà bisogno. Viene meno pertanto la ragione di trascinare così un’esistenza incresciosa a me, dannosa a’ miei figli.
Voi, più giovani, questa ragione avete ancora, epperò vivete per essa e ricordatevi qualche volta con affetto del vostro
Gerlando Laurentano
Dianella si volse a guardare il Mortara che, tutto ristretto in sé, con gli occhi ora strizzati, il volto contratto e una mano su la bocca, si sforzava di soffocare nel barbone abbatuffolato i singhiozzi irrompenti.
– Non la rileggevo più da anni, – mormorò quando potè parlare.
Tentennò a lungo la testa, poi prese a dire:
– Mi fece questo tradimento. Scrisse la lettera e si vestì di tutto punto, come dovesse andare a una festa da ballo. Ero in cucina; mi chiamò. «Questa lettera a Mariano Gioèni, a La Vailetta.» C’erano a La Valletta gli altri esiliati siciliani, eh’erano stati tutti qua, in questa camera, prima del Quarantotto, al tempo della cospirazione. Mi pare di vederli ancora: don Giovanni Ricci-Gramitto, il poeta; don Mariano Gioèni e suo fratello don Francesco; don Francesco De Luca; don Gerlando Bianchini; don Vincenzo Barresi: tutti qua; e io sotto a far la guardia. Basta! Portai la lettera… Come avrei potuto supporre? Quando ritornai a Burmula, lo trovai morto.
– S’era ucciso? – domandò, intimidita, Dianella.
– Col veleno, – rispose Mauro. – Non aveva fatto neanche in tempo a tirare sul letto l’altra gamba. Come era bello! Conoscete don Ippolito? Più bello. Diritto, con un pajo d’occhi che fulminavano: un San Giorgio! Anche da vecchio, innamorava le donne.
Richiuse gli occhi e a bassa voce recitò la chiusa della lettera, che sapeva a memoria:
– Voi, più giovani, questa ragione avete ancora, epperò vivete per essa e ricordatevi qualche volta con affetto del vostro Gerlando Laurentano. Vedete? E vissi io, come lui volle. È qua, sotto la lettera, che mi feci restituire da don Mariano Gioèni, ho voluto appendere, come in risposta, le mie medaglie. Ma prima di guadagnarmele! Sedete, qua; non vi stancate…
Dianella sedette sul vecchio divano. In quel punto, donna Sara Alàimo, sentendo parlare nel camerone e vedendo insolitamente l’uscio socchiuso, sporse il capo incuffiato a guardare.
– Che volete voi qua? – saltò su Mauro Mortara, come avrebbe fatto, se vivo, quel leopardo. – Qua non c’è nulla per voi!
– Puh! – fece donna Sara, ritraendo subito il capo. – E chi vi tocca?
Mauro corse a sprangar l’uscio.
– La strozzerei! Non la posso soffrire, non la posso vedere, questa spi’accia dei preti! S’arrischia anche a ficcare il naso qua dentro, ora? Non l’aveva mai fatto! La tengono qua i preti, sapete? approfittandosi di quel babbeo di don Cosmo. I Sanfedisti, i Sanfedisti…
– Ma ci sono ancora davvero codesti Sanfedisti? – domandò Dianella con un benevolo sorriso.
– Oh Marasantissima, lasciatevi servire! – tornò ad esclamare il Mortara. – Se ci sono! Forse ora si fanno chiamare d’un’altra maniera; ma sono sempre quelli. Setta infernale, sparsa per tutto il mondo! Spie dappertutto: ne trovai una finanche in Turchia, figuratevi! a Costantinopoli.
– Siete stato fin là? – domandò Dianella.
– Fin là? Ma più lontano ancora! – rispose Mauro con un sorriso di soddisfazione. – Dove non sono stato e che cosa non ho fatto io? Contiamo; ma non bastano le dita delle mani; pecorajo, contadino, servitore, mozzo di nave, scaricatore di bordo, stivatore, fochista, cuoco, bagnino, cacciatore di bestie feroci, poi volontario garibaldino, attendente di Bixio; poi, dopo la Rivoluzione, capo-carcerario: trecento galeotti ho tenuto in un pugno a Santo Vito, che volevano scappare; e alla fine, qua, campagnuolo di nuovo. La mia vita? Non parrebbe vera, se qualcuno la volesse raccontare.
Stette un pezzo a lisciarsi la barba, mentre gli occhi verdastri gli ridevano lucidi, al fremito interno dei ricordi.
– Tagliate un tronco d’albero, – disse, – e buttatelo a mare, lontano dalla spiaggia. Dove andrà a finire? Ero come un tronco d’albero, nato e cresciuto qua, a Valsanìa. Venne la bufera e mi schiantò. Prima partì il Generale coi compagni; io partii due giorni dopo, di notte, sopra un bastimento a vela, com’usava a quei tempi: una barcaccia di quelle che chiamano tartane. Ora rido. Sapeste però che spavento, quella notte, sul mare!
– La prima volta?
– Chi c’era mai stato! Nero, tutto nero, cielo e mare. Solo la vela, stesa, biancheggiava. Le stelle, fitte fitte, alte, parevano polvere. Il mare si rompeva urtando contro i fianchi della tartana, e l’albero cigolava. Poi spuntò la luna, e il bestione si abbonacciò. I marinai, a prua, fumavano a pipa e chiacchieravano tra loro; io, buttato là, tra le balle e il cordame incatramato, vedevo il fuoco delle loro pipe; piangevo, con gli occhi spalancati, senz’accorgermene. Le lagrime mi cadevano su le mani. Ero come una creatura di cinque anni; e ne avevo trentatré! Addio, Sicilia; addio, Valsanìa; Girgenti che si vede da lontano, lassù, alta; addio, campane di San Gerlando, di cui nel silenzio della campagna m’arrivava il ronzìo; addio, alberi che conoscevo a uno a uno… Voi non vi potete immaginare, come da lontano vi s’avvistino le cose care che lasciate e vi afferrino e vi strappino l’anima! Io vedevo certi luoghi, qua, di Valsanìa, proprio come se vi fossi; meglio, anzi; notavo certe cose, che prima non avevo mai notato; come tremavano i fili d’erba alla brezza grecalina, un sasso caduto dal murello, un albero un po’ storto a pendìo, che si sarebbe potuto raddrizzare, e di cui potevo contare le foglie, a una a una… Basta! All’alba; giunsi a Malta. Prima si tocca l’isola di Gozzo… Malta, capite? tutta come un golfo, abbraccia il mare. Qua e là, tante insenature. In una di queste è Burmula, dove il Generale aveva preso stanza. Grossi porti, selve di navi; e gente d’ogni razza, d’ogni nazione: Arabi, Turchi, Beduini, Marocchini; e poi Inglesi, Francesi, Spagnuoli. Cento lingue. Nel Cinquanta, ci scoppiò il colera, portato dagli Ebrei di Susa, che avevano con loro belle femmine, belle! ma, sapete? ragazzette fresche, di sedici e diciott’anni come voi…
– Oh, ne ho di più io! – sorrise Dianella.
– Di più? Non pare. Si dipingevano. Senza bisogno, – seguitò Mauro, – come se fossero state vecchie. Peccato! Belle femmine! Portarono il colera, vi dicevo: un’epidemia terribile! Figuratevi che a Burmula, paesettuccio, in una sola giornata, ottocento morti. Come le mosche si moriva. Ma la morte a un disgraziato che paura può fare? Io mangiavo, come niente, petronciani e pomodori: lo facevo apposta. Avevo imparato una canzonetta maltese e la cantavo giorno e notte, a cavalcioni d’una finestra. Perché ero innamorato…
– Ah sì? Là? – domandò Dianella, sorpresa.
– Non là, – rispose Mauro. – Avevo lasciato qua, a Valsanìa, una villanella con cui facevo all’amore: Serafina… Si maritò con un altro, dopo un anno appena. E io cantavo… Volete sentire la canzonetta? Me la ricordo ancora.
Socchiuse gli occhi, buttò indietro il capo e si mise a canticchiare in falsetto, pronunciando a suo modo le parole di quella canzonetta popolare:
Ahi me kalbi, kentu giani…
Dianella lo guardava, ammirata, con un intenerimento e una dolcezza accorata, che spirava anche dal mesto ritmo di quell’arietta d’un tempo e d’un paese lontano, la quale affiorava su le labbra di quel vecchio, fievole eco della remota, avventurosa gioventù. Non sospettava minimamente sotto la ruvida scorza del Mortara la tenerezza di tali ricordi.
– Com’è bella! – disse. – Ricantatela.
Mauro, commosso, fe’ cenno di no, con un dito.
– Non posso; non ho voce… Sapete che vogliono dire le prime parole? Ahimè, il cuore, come mi duole. Il senso delle altre non lo ricordo più. Piaceva tanto al Generale, questa canzonetta. Me la faceva cantare sempre. Eh, avevo buona voce, allora… Voi guardate il leopardo? Ora vi racconto.
E seguitò a raccontarle come, dopo la morte del Generale, rimasto solo a Burmula, non volendo ritornare in Sicilia, dove s’era già compromesso, si fosse recato a La Valletta. Qua, gli esiliati siciliani avrebbero voluto ajutarlo; ma egli, sapendo in che misere condizioni si trovassero, aveva rifiutato ogni soccorso e s’era messo a lavorare nel porto, come mozzo, come scaricatore, come stivatore. Mancavano le braccia, decimata la popolazione dal colera. Poi s’era imbarcato su un piroscafo inglese da fochista. Per più di sei mesi era stato sepolto lì, nel saldo ventre strepitoso della nave, ad arrostirsi al fuoco alimentato notte e giorno, senza inai sapere dove s’andasse. I macchinisti inglesi lo guardavano e ridevano – chi sa perché – e un giorno, per forza, avevano voluto presentarlo, così tutto affumicato com’era, al capitano – pezzo d’omone sanguigno, con una barbaccia fulva che gli arrivava fin quasi ai ginocchi – e il capitano gli aveva più volte battuto la spalla, lodandolo forse perlo zelo. Egli, difatti, in tutti quei mesi, non s’era dato un momento di requie, neanche per prendere un boccone; aveva perduto l’appetito: beveva soltanto, per temprar l’arsura del corpo che, là sotto, smaniava il respiro, un po’ d’aria! Unico svago, quando si approdava in qualche porto, un vecchio libro di cucina, tutto squinternato, sul quale aveva imparato a compitare con l’ajuto del cuoco di bordo, anch’esso italiano, da lungo tempo spatriato a Malta.
Svago e tesoro, per lui, quel libro! Perché, un giorno, il cuoco, ammalatosi gravemente, era stato sbarcato a Smirne e, in mancanza d’altri, alla prova di quest’altro fuoco era stato messo lui, erede del libro e della dottrina culinaria di quello. S’era dato con tutto l’impegno a questo nuovo ufficio e in breve aveva saputo contentar così bene il capitano, che questi poi, vedendolo lì lì per ammalarsi come quell’altro cuoco, spontaneamente lo aveva allogato quale sguattero in una famiglia inglese, ricchissima, domiciliata a Costantinopoli. Ma la malattia contratta a bordo non lo aveva lasciato lungo tempo a quel posto, per un tristo accidente capitatogli uno di quei giorni. Un droghieruccio d’Alcamo, stabilito da molti anni là a Costantinopoli, dal quale egli si recava qualche volta per sentir parlare il dialetto nativo, aveva voluto avvelenarlo. Sì! Invece d’una pozione d’olio di mandorle dolci, gli aveva dato forse olio di mandorle amare. Spia dei preti, dei Sanfedisti, anche quello! Sbaglio involontario? Ma che! Ricordava bene che una volta colui aveva osato rimproverarlo acerbamente per l’avventura del francescano appeso, ch’egli, così per ridere, gli aveva narrata. Ah, ma rimessosi per miracolo, dopo circa tre mesi, dall’avvelenamento, gli aveva fatto pagar caro il delitto. Con un pugno (e Mauro mostrò sorridendo il pugno) lo aveva steso là, nella bottega. Aveva al dito un grosso anello di ferro, come un chiodo ritorto, comperato a Smirne, e con esso – senza volerlo, veh! – gli aveva sfracellato la tempia. Ripresosi dal pauroso sbalordimento nel vederselo cascare giù tutto in un fascio sotto gli occhi, insanguinato, s’era dato alla fuga e poche ore dopo era partito con una nave che si recava a un piccolo porto dell’Asia Minore. Non ricordava più il nome del paesello di mare in cui era disceso: era d’estate e aveva trovato subito da allogarsi come bagnino.
– Avete sentito nominare Orazio Antinori? – domandò a questo punto il Mortara.
– L’esploratore? Sì, – disse Dianella.
– Venne là, ai bagni, un giorno, – seguitò Mauro, – con un altro italiano. Li sentii parlare e m’accostai. L’Antinori assoldava cacciatori per la caccia delle fiere, nel deserto di Libia. Gli piacqui, mi prese con sé. Noi andavamo; gli mandavamo le fiere uccise; egli le imbalsamava e poi lei spediva ai musei, a Londra, a Vienna… Quando ritornavo dalle cacce, siccome lui mi voleva bene sapendomi fidato, lo ajutavo a preparar le droghe, e intanto, zitto zitto, gli rubavo l’arte. Così imparai a imbalsamare; e quando lui andò via, seguitai per conto mio la caccia e la spedizione. Vi voglio raccontare una certa avventura. Un giorno, eravamo sperduti, io e lui, morti di fame e di sete. A un certo punto avvistammo alcuni alberi di fico e li prendemmo d’assalto, figuratevi! Ma i fichi migliori erano in alto e non potevamo prenderli. Allora io, contadino, che feci? m’allontanai e ritornai poco dopo, munito d’una canna bella lunga; la spaccai un po’ in cima e con essa mi misi a cogliere i fichi alti più maturi, con la lagrima di latte: un miele, vi dico! L’Antinori mi guardava e si rodeva dentro. Alla fine non potè più reggere e mi gridò: «Che fai? La smetti? Vuoi farmi ammazzare dai Turchi?». Capii l’antifona. Zitto, stesi il braccio e gli porsi la canna. Andai a prenderne un’altra, e tutti e due seguitammo a rubar fichi tranquillamente. Ah, l’Antinori… mi voleva bene, e m’ajutò tanto, anche da lontano. Stetti lì più di sei anni. Poi sentii che Garibaldi era sbarcato a Marsala; volai subito in Sicilia. Sbarco a Messina; raggiungo i volontarii a Milazzo. Don Stefano Auriti mi morì tra le braccia. Non poteva più parlare, mi raccomandava con gli occhi il figlio, don Roberto, il suo leonetto di dodici anni… Ci battemmo! A Reggio aprii il fuoco io, sapete? la prima fucilata fu la mia! Poi Bixio mi prese per attendente. Che giornata, quella del Volturno! Ma ora, dopo aver visto tante cose, dopo averne passate tante, sono soddisfatto, che volete! L’Italia è grande! L’Italia è alla testa delle nazioni! Detta legge nel mondo! E posso dire che anch’io, così da povero ignorante e meschino come sono, ho fatto qualche cosa, senza tante chiacchiere. Posso andare dal re e dirgli: «Maestà, alla sedia su cui voi sedete, se non una gamba o una traversa, un piccolo perno, qualche cavicchio, l’ho messo anch’io. La mia parte te l’ho fatta, figlio mio!». E sono contento. Cammino qua per Valsanìa, vedo i fili del telegrafo, sento ronzare il palo, come se ci fosse dentro un nido di calabroni, e il petto mi s’allarga; dico: «Frutto della Rivoluzione!». Vado più là, vedo la ferrovia, il treno che si caccia sottoterra, nel traforo sotto Valsanìa, che mi pare un sogno; e dico: «Frutto della Rivoluzione!». Vado sotto il pino, guardo il mare, vedo laggiù a ponente Porto Empedocle, che al tempo della mia partenza per Malta non aveva altro che la Torre, il Rastiglio, il Molo Vecchio e quattro casucce, e ora è diventato quasi una città; vedo le due lunghe scogliere del nuovo porto, che mi pajono due braccia tese a tutte le navi di tutti i paesi civili del mondo, come per dire: «Venite! venite! l’Italia è risorta, l’Italia abbraccia tutti, dà a tutti la ricchezza del suo zolfo, la ricchezza dei suoi giardini!». Frutto della Rivoluzione, anche questo, penso, e – vedete? – mi metto a piangere come un bambino, dalla gioja…
Cavò, così dicendo, dall’apertura della ruvida camicia d’albagio un grosso fazzoletto di cotone turchino, e si asciugò gli occhi, che gli s’erano veramente riempiti di lagrime.
Dianella sentì anche lei inumidirsi gli occhi. Quel vecchio che incuteva tanta paura, che aveva ucciso un uomo come niente e ne aveva fatto morire un altro per l’ombra d’un sospetto maniaco; che andava così armato, in procinto sempre di versare altro sangue, pronto com’era all’ira e irsuto e ombroso; quel vecchio, ecco, piangeva come un fanciullo per l’opera compiuta, ch’egli vedeva senza mende e gloriosa; piangeva esaltandosi nella sua gesta e nella grandezza della patria, per cui aveva tanto sofferto e combattuto, senza chieder mai nulla, generoso e feroce, fedele come un cane e coraggioso come un leone. Né i suoi colombi, né la pace dei campi, né il governo della vigna, né il canto delle allodole, riuscivano a rasserenargli lo spirito dopo tanto tempo: quel camerone era come la sua chiesa; e usciva di là com’ebbro, e s’aggirava per la campagna sotto i mandorli e gli olivi, parlando tra sé di battaglie e di congiure, guardando biecamente il mare dalla parte di Tunisi, donde immaginava un improvviso assalto dei Francesi…
Un rumore di sonaglioli e il rotolìo d’una vettura vennero a un tratto a scuotere Dianella da queste considerazioni e Mauro dal pianto.
– Vostro padre? – domandò questi, infoscandosi d’un subito e ricacciandosi nell’apertura della camicia il fazzoletto.
Dianella si levò, costernata, e corse alla finestra a guardare attraverso le stecche delle persiane. Restò. Dalla vettura, che s’era fermata davanti alla villa, scendevano il padre, di ritorno, e Aurelio Costa – lui! – in tenuta da campagna.
– Andate, andate, – le disse Mauro, quasi spingendola. – Chiudo e me ne scappo!
Dianella uscì sul corridojo e vide in fondo a esso il Costa e il padre, diretti alla camera di questo, nella quale si chiusero. Allora Mauro Mortara, come una bestia sorpresa nel giaccio, sgattajolò ranco ranco, senza dirle nulla.
Ella rimase perplessa, profondamente turbata, non sapendo che pensare di quell’improvviso insolito ritorno del padre. Evidentemente, tanto questo ritorno quanto la venuta d’Aurelio Costa si connettevano con le notizie dei tumulti d’Aragona. Qualcosa di molto grave doveva essere accaduto. Era fuggito Aurelio? No: Dianella non volle nemmeno supporlo. Forse il padre stesso aveva mandato a chiamarlo. Con quale animo?
Fu tentata di recarsi nella sua camera, attigua a quella del padre, se le riuscisse di cogliere qualche parola attraverso la parete; ma ricordò lo sguardo del padre, quella mattina, e se n’astenne; rimase tuttavia come tenuta tra due, nella sala d’ingresso.
– Suo papà, – le annunziò donna Sara Alàimo, sporgendo il capo dall’uscio della cucina.
Dianella le accennò di sì col capo.
– Con l’ingegnere, – aggiunse donna Sara, sottovoce.
Dianella le accennò di nuovo col capo che sapeva, e uscì sul pianerottolo della scala esterna. La vettura era lì ancora, in attesa, a piè della scala. Dunque il padre doveva ripartire subito? Forse era venuto per prendere qualche carta.
– Andrete a Porto Empedocle adesso? – domandò al cocchiere.
– Eccellenza, sì – rispose questi.
Ed ecco il padre e il Costa frettolosi. Flaminio Salvo non s’aspettava di trovar la figlia sul pianerottolo della scala, e, vedendola, si tirò un po’ indietro, senza fermarsi, le fece un sorriso e la salutò con la mano. Aurelio Costa, che gli veniva dietro, rimase un istante confuso, accennò di togliersi il berretto da viaggio; ma il Salvo gli gridò:
– Andiamo, andiamo…
Dianella, pallida, col fiato rattenuto, li vide montare su la vettura, partire senza volgere il capo, e li seguì con gli occhi finché non scomparvero tra gli alberi del viale.
Com’era cangiato Aurelio! Sconvolto… Pareva malato, invecchiato, con la barba non rifatta… Dianella pensò al giudizio che ne aveva dato Nicoletta Capolino. Avrebbe voluto vederlo più altero di fronte al padre; avrebbe voluto che, non ostante il richiamo imperioso di questo, egli si fosse fermato lì sul pianerottolo, almeno per salutarla. Invece subito aveva obbedito… Forse il momento… Chi sa che era accaduto alle zolfare!
Flaminio Salvo ritornò tardi, la sera, d’umor gajo, come ogni qual volta prendeva una grave decisione.
A cena, si scusò con don Cosmo della sfuriata della mattina; disse che n’aveva fino alla gola, delle innumerevoli seccature che gli erano diluviate da quelle zolfare d’Aragona, e che aveva deciso di chiuderle.
– Così sciopereranno un po’ per piacer mio, i signori solfaraj, e avranno più tempo d’assistere alle prediche dei loro sacerdoti umanitarii. Mangino prediche! Bello, il vangelo umanitario, don Cosmo, letto su una pagina sola! Se voltassero pagina… Ma se ne guardano bene! Hanno ragione; ma la loro ragione è qua!
E si toccò il ventre.
– Andate a far loro intendere che la politica doganale seguita dal governo italiano è stata tutta una cuccagna per l’industria e gl’industriali dell’alta Italia e una rovina spaventosa per il Mezzogiorno e per la nostra povera isola; che da anni e anni l’aumento delle tasse e di tutti i pesi è continuo e continuo il ribasso dei prodotti; che col prezzo a cui è disceso lo zolfo non solo è assolutamente impossibile trattarli meglio, ma è addirittura una follìa seguitar l’industria… Io non avevo chiuso le zolfare per loro, per dar loro almeno un tozzo di pane. Scioperano? Tante grazie! Vuol dire che possono fare a meno di lavorare. Tutti a spasso! Allegria!
– La vita! – sospirò don Cosmo, con gli angoli della bocca contratti in giù. – A pensarci bene… Lo zolfo, sicuro… le industrie… questa tovaglia qua, damascata, questo bicchiere arrotato… il lume di bronzo… tutte queste minchionerie sulla tavola… e per la casa… e per le strade… piroscafi sul mare, ferrovie, palloni per aria… Siamo pazzi, parola d’onore!… Sì, servono, servono per riempire in qualche modo questa minchioneria massima che chiamiamo vita, per darle una certa apparenza, una certa consistenza… Mah! Vi giuro che non so, in certi momenti, se sono più pazzo io che non ci capisco nulla o quelli che credono sul serio di capirci qualche cosa e parlano e si muovono, come se avessero veramente un qualche scopo davanti a loro, il quale poi, raggiunto, non dovesse a loro stessi apparir vano. Io comincerei, signor mio, dal rompere questo bicchiere. Poi butterei giù la casa… Ricominciando daccapo, chi sa!… Voi dite che quei disgraziati la ragione l’hanno qua? Beati loro, signor mio! E guaj se si saziano… Dove l’avete più voi, la ragione? Dove l’ho più io?
Poco dopo, Flaminio Salvo e Dianella erano affacciati alla finestra. La notte era scurissima. Le stelle profonde, che pungevano e allargavano il cielo, non arrivavano a far lume in terra. I grilli scampanellavano lontano ininterrottamente e, a quando a quando, dal fondo del vallone saliva il verso accorato d’un gufo, come un singulto. Il bujo, il silenzio intorno alla villa era qua e là a tratti punto e vibrante di rapidi stridi di nottole invisibili. Poi la luna emerse, paonazza, sù dall’ampia chiostra di Monserrato in fondo, e s’avvertì un lievissimo brulichìo di foglie per tutta la campagna. Un cane, lontano, abbajò.
– Tu non hai niente, Dianella, proprio niente da dire a tuo padre? – domandò il Salvo senza guardarla, con tono mesto, come se con l’anima vagasse lontano assai da quella finestra.
– Io? – fece Dianella, incerta e quasi sbigottita. – Niente… Che potrei dirti?
– Niente, dunque, – riprese il padre. – Nessun piccolo, piccolo segreto… niente, eh? Sono contento. Perché tu, povera figliuola mia, purtroppo hai soltanto me, preso da tante brighe… E oggi… che giornataccia!… Sai che manca a molti? Il senso dell’opportunità. Non dico che avrei risposto di sì, se la domanda mi fosse stata rivolta in altro giorno, in altro modo; ma avrei risposto di no, almeno con più garbo, ecco, dopo aver parlato con te.
Dianella temette, ascoltando queste parole calme e lente del padre, che questi potesse udire il violento martellare del cuore di lei, sospeso in un’aspettazione angosciosa, tra l’impetuoso ribollimento di tutto il sangue per le vene.
– Mi hanno chiesto… tu m’intendi, – seguitò il Salvo, voltandosi a spiarla negli occhi. – E io, certo che la mia buona figliuola, così savia, non poteva aver fissato neanche per un momento la propria attenzione su un giovane – oh, buono, sì; ma pure, per tante ragioni, non adatto né degno – preso in quel momento proprio inopportuno, ho rifiutato, senz’altro. Vediamo un po’, non indovini?
– No… – rispose, più col fiato che con la voce, Dianella.
– Non indovini proprio? – insistette il padre, sorridendo, come conscio della tortura che le infliggeva. – Sù, provati…
– Non… non saprei… – balbettò lei.
– E allora bisognerà che te lo dica, – concluse il padre, – perché tu sappia regolarti. Il De Vincentis…
– Ah! – esclamò Dianella, con uno scatto di riso irresistibile. – Quel povero Ninì?
– Quel povero Ninì, – ripetè il padre, scrollando il capo e sorridendo anche lui. – Dunque, te l’aspettavi?
– No, ti giuro, – s’affrettò a rispondergli Dianella, con vivacità. – M’ero accorta, sì…
– Ma t’aspettavi qualche altro? – tornò a domandare il padre, pronto, guardandola più acutamente.
Dianella allora s’impuntò e sostenne lo sguardo del padre con fredda fermezza.
– Ti ho detto di no.
Il sospetto che il padre con quel discorso avesse voluto tenderle un’insidia era divenuto certezza. Forse non era neanche vero che Ninì De Vincentis gli avesse fatto quella richiesta. E l’essersi il padre servito di lui, povero giovane troppo dabbene, quasi per metterlo in dileggio, le parve odioso, sapendo il De Vincentis anche per altro vittima del padre.
Questi non disse più nulla; rimase ancora un pezzo alla finestra, a guardar fuori, poi se ne ritrasse con un sospiro e salutò la figlia per andare a dormire.
– Buona notte – gli rispose Dianella, freddamente.
Appena sola, si nascose il volto tra le mani e pianse. Le parve che il padre si fosse divertito a straziarle il cuore, come un gatto col topo. Oh Dio, perché, perché così cattivo anche con la propria figlia, quando gli sarebbe stato così facile esser buono con tutti? Se veramente voleva ch’ella gli dicesse il suo segreto, ricordandole che non aveva più da confidarsi con altri se non con lui, perché, nello stesso momento che le poneva innanzi la sorte crudele che le aveva tolto il consiglio e l’amore della madre, le tendeva un’insidia? Dunque, no; era certo ormai: egli non voleva che lei amasse Aurelio. Aveva chiuso le zolfare; forse aveva posto a effetto la minaccia della mattina: «Caccio via tutti!». Anche Aurelio? Oh, Aurelio non aveva più bisogno di lui, adesso! Perduto quel posto, tanti altri, anche migliori, avrebbe potuto trovarne subito. E questo forse, ecco, faceva più dispetto al padre, aver dato a quel giovane il mezzo di non aver più bisogno di lui, e averglielo dato per un dovere che a lui lo legava. Voleva che tutti fossero docili strumenti nelle sue mani; e Aurelio invece avrebbe potuto levarglisi contro, dov’egli più temeva la ribellione: nel cuore di sua figlia. Sì, sì, perché sapeva bene che ella lo amava. Così lo avesse saputo Aurelio! Ma che sarebbe intanto avvenuto, se davvero il padre, chiuse le zolfare, lo aveva licenziato? Aurelio se ne sarebbe andato di nuovo lontano, sarebbe ritornato in Sardegna, senz’alcun sospetto dell’amore di lei, e forse, là…
Dianella tornò a nascondersi il volto tra le mani. Nel vuoto angoscioso, fissando l’udito, senza volerlo, nel fitto continuo scampanellìo dei grilli, le parve ch’esso nel silenzio diventasse di punto in punto più intenso e più sonoro; pensò ai tumulti d’Aragona e di Comitini; e quel fervido concento divenne allora per lei, a un tratto, il clamore lontano, indefinito d’un popolo in rivolta, di cui Aurelio, ribelle, andava a farsi duce e vendicatore. E lei? e lei?
Scoprì il volto: come un sogno le apparve allora la pace smemorata della campagna, lì presente, all’umido e blando albore lunare. E un fresco rivo inatteso di tenerezza le scaturì dal cuore; e altre lagrime le velarono gli occhi.
Ah, era pur bello lo spettacolo di quella profonda notte lunare su la campagna, con quegli alberi antichi, immobili nel loro triste sogno perenne, sorgente col fusto dal grembo della terra, con quei monti laggiù che chiudevano, cupi contro il cielo, il mistero degli evi più remoti, con quel tremulo limpido assiduo canto dei grilli che, sparsi tra le erbe dei piani, pareva persuadessero all’oblio d’ogni cosa.
Tra quei grilli e quegli alberi e quella luna e quei monti non era forse un concerto misterioso, a cui gli uomini restavano estranei? Tanta bellezza non era fatta per gli uomini, che chiudevano stanchi, a quell’ora, gli occhi al sonno; sarebbe durata tutta la notte non veduta più da nessuno, nella solitudine della campagna, quando anche lei avrebbe chiuso la finestra. Forse voleva questo la nottola invisibile che strideva svolando lì innanzi, offesa e attratta dal lume: voleva ch’ella non disturbasse più oltre con la sua veglia il notturno misterioso concerto della natura solitaria?
E Dianella chiuse la finestra: lasciò aperto appena appena uno scuro e, attraverso quello spiraglio, con le mani congiunte innanzi alla bocca, pregò silenziosamente per tutta quella bellezza rimasta fuori, animata a un tratto agli occhi di lei dallo spirito di Dio che gli uomini offendono con le loro torbide e tristi passioni. Volgendo un ultimo sguardo al viale innanzi alla villa, scorse un’ombra che vi passeggiava, un cranio lucido sotto la luna. Don Cosmo? Lui.
Ah, immerso là nello spirito di Dio, egli forse non lo sentiva! Andava a quell’ora sù e giù per il viale, con le mani dietro la schiena, assorto tuttavia, certo, nelle sue buje e vane meditazioni.
| I vecchi e i giovani – Indice Introduzione |
|
| Parte I
Capitolo 1 |
Parte II
Capitolo 1 |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com