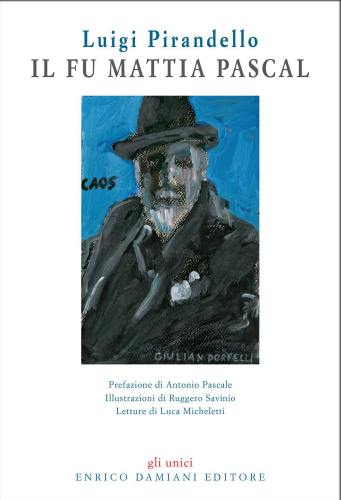««« Capitolo 11 Capitolo 13 »»»
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «Il fu Mattia Pascal» su Amazon
Capitolo 12 – L’occhio e Papiano
– La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. – Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis.
– La tragedia d’Oreste?
– Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po, che bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei.
– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle.
– Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo.
– E perché?
– Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.
E se ne andò, ciabattando.
Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così, come valanghe, i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l’opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, dimodoché difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa.
L’immagine della marionetta d’Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. A un certo punto: «Beate le marionette,» sospirai, «su le cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi! Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà: nulla! E possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato.
«E il prototipo di queste marionette, caro signor Anselmo,» seguitai a pensare, «voi l’avete in casa, ed è il vostro indegno genero, Papiano. Chi più di lui pago del cielo di cartapesta, basso basso, che gli sta sopra, comoda e tranquilla dimora di quel Dio proverbiale, di maniche larghe, pronto a chiuder gli occhi e ad alzare in remissione la mano; di quel Dio che ripete sonnacchioso a ogni marachella: – Ajutati, ch’io t’ajuto –? E s’ajuta in tutti i modi il vostro Papiano. La vita per lui è quasi un gioco d’abilità. E come gode a cacciarsi in ogni intrigo: alacre, intraprendente, chiacchierone!»
Aveva circa quarant’anni, Papiano, ed era alto di statura e robusto di membra: un po’ calvo, con un grosso pajo di baffi brizzolati appena appena sotto il naso, un bel nasone dalle narici frementi; occhi grigi, acuti e irrequieti come le mani. Vedeva tutto e toccava tutto. Mentre, per esempio, stava a parlar con me, s’accorgeva – non so come – che Adriana, dietro a lui, stentava a pulire e a rimettere a posto qualche oggetto nella camera, e subito, assaettandosi:
– Pardon!
Correva a lei, le toglieva l’oggetto dalle mani:
– No, figliuola mia, guarda: si fa cosi!
E lo ripuliva lui, lo rimetteva a posto lui, e tornava a me. Oppure s’accorgeva che il fratello, il quale soffriva di convulsioni epilettiche, «s’incantava», e correva a dargli schiaffetti su le guance, biscottini sul naso:
– Scipione! Scipione!
O gli soffiava in faccia, fino a farlo rinvenire.
Chi sa quanto mi ci sarei divertito, se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia!
Certo egli se ne accorse fin dai primi giorni, o – per lo meno – me la intravide. Cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie, ch’eran tutte uncini per tirarmi a parlare. Mi pareva che ogni sua parola, ogni sua domanda, fosse pur la più ovvia, nascondesse un’insidia. Non avrei voluto intanto mostrar diffidenza per non accrescere i suoi sospetti; ma l’irritazione ch’egli mi cagionava con quel suo tratto da vessatore servizievole m’impediva di dissimularla bene.
L’irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete. Una era questa: ch’io, senza aver commesso cattive azioni, senz’aver fatto male a nessuno, dovevo guardarmi così, davanti e dietro, umoroso e sospettoso, come se avessi perduto il diritto d’esser lasciato in pace. L’altra, non avrei voluto confessarla a me stesso, e appunto perciò m’irritava più fortemente, sotto sotto. Avevo un bel dirmi:
«Stupido! vattene via, levati dai piedi codesto seccatore!»
Non me ne andavo: non potevo più andarmene.
La lotta che facevo contro me stesso, per non assumer coscienza di ciò che sentivo per Adriana, m’impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d’esistenza rispetto a questo sentimento. E restavo lì, perplesso, smanioso nella mal contentezza di me, anzi in orgasmo continuo, eppur sorridente di fuori.
Di ciò che m’era occorso di scoprire quella sera, nascosto dietro la persiana, non ero ancor venuto in chiaro. Pareva che la cattiva impressione che Papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina Caporale, si fosse cancellata subito alla presentazione. Egli mi tormentava, è vero, ma come se non potesse farne a meno; non certo col disegno segreto di farmi andar via; anzi, al contrario! Che macchinava? Adriana, dopo il ritorno di lui, era diventata triste e schiva, come nei primi giorni. La signorina Silvia Caporale dava del lei a Papiano, almeno in presenza degli altri, ma quell’arcifanfano dava del tu a lei, apertamente; arrivava finanche a chiamarla Rea Silvia; e io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche. Certo quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita, ma neanche d’esser trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità.
Una sera (c’era la luna piena, e pareva giorno), dalla mia finestra la vidi, sola e triste, là, nel terrazzino, dove ora ci riunivamo raramente, e non più col piacere di prima, poiché v’interveniva anche Papiano che parlava per tutti. Spinto dalla curiosità, pensai d’andarla a sorprendere in quel momento d’abbandono.
Trovai, al solito, nel corridojo, presso all’uscio della mia camera, asserpolato sul baule, il fratello di Papiano, nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta. Aveva eletto domicilio lassù, o faceva la sentinella a me per ordine del fratello?
La signorina Caporale, nel terrazzino, piangeva. Non volle dirmi nulla, dapprima; si lamentò soltanto d’un fierissimo mal di capo. Poi, come prendendo una risoluzione improvvisa, si voltò a guardarmi in faccia, mi porse una mano e mi domandò:
– È mio amico lei?
– Se vuol concedermi quest’onore… – le risposi, inchinandomi.
– Grazie. Non mi faccia complimenti, per carità! Se sapesse che bisogno ho io d’un amico, d’un vero amico, in questo momento! Lei dovrebbe comprenderlo, lei che è solo al mondo, come me… Ma lei è uomo! Se sapesse… se sapesse…
Addentò il fazzolettino che teneva in mano, per impedirsi di piangere; non riuscendovi, lo strappò a più riprese, rabbiosamente.
– Donna, brutta e vecchia, – esclamò: – tre disgrazie, a cui non c’è rimedio! Perché vivo io?
– Si calmi, via, – la pregai, addolorato. – Perché dice cosi, signorina?
Non mi riuscì dir altro.
– Perché… – proruppe lei, ma s’arrestò d’un tratto.
– Dica, – la incitai. – Se ha bisogno d’un amico…
Ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato, e…
– Io avrei piuttosto bisogno di morire! – gemette con accoramento così profondo e intenso, che mi sentii subito un nodo d’angoscia alla gola.
Non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole, né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri.
– Ma neanche la morte mi vuole, – riprese. – Niente… scusi, signor Meis! Che ajuto potrebbe darmi lei? Nessuno. Tutt’al più, di parole… si, un po’ di compassione. Sono orfana, e debbo star qua, trattata come… forse lei se ne sarà accorto. E non ne avrebbero il diritto, sa! Perché non mi fanno mica l’elemosina…
E qui la signorina Caporale mi parlò delle sei mila lire scroccatele da Papiano, a cui io ho già accennato altrove.
Per quanto il cordoglio di quell’infelice m’interessasse, non era certo quello che volevo saper da lei. Approfittandomi (lo confesso) dell’eccitazione in cui ella si trovava, fors’anche per aver bevuto qualche bicchierino di più, m’arrischiai a domandarle:
– Ma, scusi, signorina, perché lei glielo ha dato, quel danaro?
– Perché? – e strinse le pugna. – Due perfidie, una più nera dell’altra! Gliel’ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me. Ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui…
– Ho capito.
– Si figuri, – riprese con foga. – La povera Rita…
– La moglie?
– Sì Rita, la sorella d’Adriana… Due anni malata, tra la vita e la morte… Si figuri, se io… Ma già, qua lo sanno, com’io mi comportai; lo sa Adriana, e perciò mi vuol bene; lei sì, poverina. Ma come son rimasta io ora? Guardi: per lui, ho dovuto anche dar via il pianoforte, ch’era per me… tutto, capirà! non per la mia professione soltanto: io parlavo col mio pianoforte! Da ragazza, all’Accademia, componevo; ho composto anche dopo, diplomata; poi ho lasciato andare. Ma quando avevo il pianoforte, io componevo ancora, per me sola, all’improvviso; mi sfogavo… m’inebriavo fino a cader per terra, creda, svenuta, in certi momenti. Non so io stessa che cosa m’uscisse dall’anima: diventavo una cosa sola col mio strumento, e le mie dita non vibravano più su una tastiera: io facevo piangere e gridare l’anima mia. Posso dirle questo soltanto, che una sera (stavamo, io e la mamma, in un mezzanino) si raccolse gente, giù in istrada, che m’applaudi alla fine, a lungo. E io ne ebbi quasi paura.
– Scusi, signorina, – le proposi allora, per confortarla in qualche modo. – E non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte? Mi piacerebbe tanto, tanto, sentirla sonare; e se lei…
– No, – m’interruppe, – che vuole che suoni io più! È finita per me. Strimpello canzoncine sguajate. Basta. È finita…
– Ma il signor Terenzio Papiano, – m’arrischiai di nuovo a domandare, – le ha promesso forse la restituzione di quel denaro?
– Lui? – fece subito, con un fremito d’ira, la signorina Caporale. – E chi gliel’ha mai chiesto! Ma sì, me lo promette adesso, se io lo ajuto… Già! Vuol essere ajutato da me, proprio da me; ha avuto la sfrontatezza di propormelo, cosi, tranquillamente…
– Ajutarlo? In che cosa?
– In una nuova perfidia! Comprende? Io vedo che lei ha compreso.
– Adri… la… la signorina Adriana? – balbettai.
– Appunto. Dovrei persuaderla io! lo, capisce?
– A sposar lui?
– S’intende. Sa perché? Ha, o piuttosto, dovrebbe avere quattordici o quindici mila lire di dote quella povera disgraziata: la dote della sorella, che egli doveva subito restituire al signor Anselmo, poiché Rita è morta senza lasciar figliuoli. Non so che imbrogli abbia fatto. Ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione. Ora spera che… Zitto… ecco Adriana!
Chiusa in sé e più schiva del solito, Adriana s’appressò a noi: cinse con un braccio la vita della signorina Caporale e accennò a me un lieve saluto col capo. Provai, dopo quelle confidenze, una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell’odiosa tirannia di quel cagliostro. Poco dopo però, comparve nel terrazzino, come un’ombra, il fratello di Papiano.
– Eccolo, – disse piano la Caporale ad Adriana.
Questa socchiuse gli occhi, sorrise amaramente, scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino, dicendomi:
– Scusi, signor Meis. Buona sera.
– La spia, – mi susurrò la signorina Caporale, ammiccando.
– Ma di che teme la signorina Adriana? – mi scappò detto, nella cresciuta irritazione. – Non capisce che, facendo così, dà più ansa a colui da insuperbire e da far peggio il tiranno? Senta, signorina, io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prender gusto e interessarsi alla vita, e li ammiro. Tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume, sia pure con la prepotenza, quella del padrone, la mia simpatia è per quest’ultimo.
La Caporale notò l’animazione con cui avevo parlato e, con aria di sfida, mi disse:
– E perché allora non prova a ribellarsi lei per primo ?
– Io?
– Lei, lei, – affermò ella, guardandomi negli occhi, aizzosa.
– Ma che c’entro io? – risposi. – Io potrei ribellarmi in una sola maniera: andandomene.
– Ebbene, – concluse maliziosamente la signorina Caporale, – forse questo appunto non vuole Adriana.
– Ch’io me ne vada?
Quella fece girar per aria il fazzolettino sbrendolato e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando:
– Chi sa!
Scrollai le spalle.
– A cena! a cena! – esclamai; e la lasciai lì in asso, nel terrazzino.
Per cominciare da quella sera stessa, passando per il corridojo, mi fermai innanzi al baule, su cui Scipione Papiano era tornato ad accoccolarsi, e:
– Scusi, – gli dissi, – non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente? Qua lei m’impiccia.
Quegli mi guardò balordo, con gli occhi languenti, senza scomporsi.
– Ha capito? – incalzai, scotendolo per un braccio.
Ma come se parlassi al muro! Si schiuse allora l’uscio in fondo al corridojo, ed apparve Adriana.
– La prego, signorina, – le dissi, – veda un po’ di fare intender lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove.
– È malato, – cercò di scusarlo Adriana.
– E però che è malato! – ribattei io. – Qua non sta bene: gli manca l’aria… e poi, seduto su un baule… Vuole che lo dica io al fratello?
– No no, – s’affrettò a rispondermi lei. – Glielo dirò io, non dubiti.
– Capirà, – soggiunsi. – Non sono ancora re, da avere una sentinella alla porta.
Perdetti, da quella sera in poi, il dominio di me stesso; cominciai a sforzare apertamente la timidezza di Adriana; chiusi gli occhi e m’abbandonai, senza più riflettere, al mio sentimento.
Povera cara mammina! Ella si mostrò dapprincipio come tenuta tra due, tra la paura e la speranza. Non sapeva affidarsi a questa, indovinando che il dispetto mi spingeva; ma sentivo d’altra parte che la paura in lei era pur cagionata dalla speranza fino a quel momento segreta e quasi incosciente di non perdermi; e perciò, dando io ora a questa sua speranza alimento co’ miei nuovi modi risoluti, non sapeva neanche cedere del tutto alla paura.
Questa sua delicata perplessità, questo riserbo onesto m’impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con Papiano.
M’aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. Invece, no. Tolse il fratello dal posto di guardia, lì sul baule, come io volevo, e arrivò finanche a celiar su l’aria impacciata e smarrita d’Adriana in mia presenza.
– La compatisca, signor Meis: è vergognosa come una monacella la mia cognatina!
Questa inattesa remissione, tanta disinvoltura m’impensierirono. Dove voleva andar a parare?
Una sera me lo vidi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento, come se, tenendo i piedi entro un pajo di scarpe di panno che non facevan rumore, volesse sentire così, battendo il bastone, ch’egli camminava.
– Dôva ca l’è stô me car parent? – si mise a gridare con stretto accento torinese, senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate, calcato fin su gli occhi a sportello, appannati dal vino, né la pipetta dalla bocca, con cui pareva stesse a cuocersi il naso più rosso di quello della signorina Caporale. – Dôva ca l’è stô me car parent?
– Eccolo, – disse Papiano, indicandomi; poi rivolto a me: – Signor Adriano, una grata sorpresa! Il signor Francesco Meis, di Torino, suo parente.
– Mio parente? – esclamai, trasecolando.
Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa, aspettando che io gliela stringessi.
Lo lasciai lì, in quell’atteggiamento, per contemplarlo un pezzo; poi:
– Che farsa è codesta? – domandai.
– No, scusi, perché? – fece Terenzio Papiano. – Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo…
– Cusin, – appoggiò quegli, senza aprir gli occhi.
– Tut i Meis i sôma parent.
– Ma io non ho il bene di conoscerla! – protestai.
– Oh ma côsta ca l’è bela! – esclamò colui. – L’è propi për lon che mi’t sôn vnù a trôvè.
– Meis? di Torino? – domandai io, fingendo di cercar nella memoria. – Ma io non son di Torino!
– Come! Scusi, – interloquì Papiano. – Non mi ha detto che fino a dieci anni lei stette a Torino?
– Ma si! – riprese quegli allora, seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. – Cusin, cusin! Questo signore qua… come si chiama?
– Terenzio Papiano, a servirla.
– Terenziano: a l’à dime che to pare a l’è andàit an America: cosa ch’a veul di’ lon? a veul di’ che ti t’ ses fieul ’d barba Antôni ca l’è andàit ’ntla America. E nui sôma cusin.
– Ma se mio padre si chiamava Paolo…
– Antôni!
– Paolo, Paolo, Paolo. Vuol saperlo meglio di me?
Colui si strinse nelle spalle e stirò in sù la bocca:
– A m’smiava Antôni, – disse stropicciandosi il mento ispido d’una barba di quattro giorni almeno, quasi tutta grigia.
– ’I veui nen côtradite: sarà prô Paôlo. I ricordo nen ben, perché mi’ i l’hai nen conôssulo.
Pover’uomo! Era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in America; eppure si rimise, perché a ogni costo volle esser mio parente. Mi disse che suo padre, il quale si chiamava Francesco come lui, ed era fratello di Antonio… cioè di Paolo, mio padre, era andato via da Torino, quand’egli era ancor masnà, di sette anni, e che – povero impiegato – aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia, un po’ qua, un po’ là. Sapeva poco, dunque, dei parenti, sia paterni, sia materni: tuttavia, era certo, certissimo d’esser mio cugino.
Ma il nonno, almeno, il nonno, lo aveva conosciuto? Volli domandarglielo. Ebbene, sì: lo aveva conosciuto, non ricordava con precisione se a Pavia o a Piacenza.
– Ah si? proprio conosciuto? e com’era?
Era… non se ne ricordava lui, franc nen.
– A sôn passà trant’ani…
Non pareva affatto in mala fede; pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino, per non sentir troppo il peso della noja e della miseria. Chinava il capo, con gli occhi chiusi, approvando tutto ciò ch’io dicevo per pigliarmelo a godere; son sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo. Non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi cioè fossimo cugini: su questo non poteva transigere: era ormai stabilito, ci s’era fissato, e dunque basta.
A un certo punto, però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare. Licenziai quel pover’uomo mezzo ubriaco, salutandolo : – Caro parente! – e domandai a Papiano, con gli occhi fissi negli occhi, per fargli intender bene che non ero pane pe’ suoi denti:
– Mi dica adesso dov’è andato a scovare quel bel tomo.
– Scusi tanto, signor Adriano ! – premise quell’imbroglione, a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità. – Mi accorgo di non essere stato felice…
– Ma lei è felicissimo, sempre! – esclamai io.
– No, intendo: di non averle fatto piacere. Ma creda pure che è stata una combinazione. Ecco qua: son dovuto andare questa mattina all’Agenzia delle imposte, per conto del marchese, mio principale. Mentr’ero là, ho sentito chiamar forte: «Signor Meis! Signor Meis!». Mi volto subito, credendo che vi sia anche lei, per qualche affare, chi sa avesse, dico, bisogno di me, sempre pronto a servirla. Ma che! chiamavano a questo bel tomo, come lei ha detto giustamente; e allora, così… per curiosità, mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis e di che paese fosse, poiché io avevo l’onore e il piacere d’ospitare in casa un signor Meis… Ecco com’è andata! Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente, ed è voluto venire a conoscerla…
– All’Agenzia dell’imposte?
– Sissignore, è impiegato là: ajuto-agente.
Dovevo crederci? Volli accertarmene. Ed era vero, sì; ma era vero del pari che Papiano, insospettito, mentre io volevo prenderlo di fronte, là, per contrastare nel presente a’ suoi segreti armeggii, mi sfuggiva, mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi a le spalle. Conoscendolo bene, avevo pur troppo ragione di temere che egli, con quel fiuto nel naso, fosse bracco da non andare a lungo a vento: guaj se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia: l’avrebbe certo seguitata fino al molino della Stìa.
Figurarsi dunque il mio spavento, quando, ivi a pochi giorni, mentre me ne stavo in camera a leggere, mi giunse dal corridojo, come dall’altro mondo, una voce, una voce ancor viva nella mia memoria.
– Agradecio Dio, ántes che me la son levada de sobre!
Lo Spagnuolo? quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di Montecarlo? colui che voleva giocar con me e col quale m’ero bisticciato a Nizza?… Ah, perdio! Ecco la traccia! Era riuscito a scoprirla Papiano!
Balzai in piedi, reggendomi al tavolino per non cadere, nell’improvviso smarrimento angoscioso: stupefatto, quasi atterrito, tesi l’orecchio, con l’idea di fuggire non appena quei due – Papiano e lo Spagnuolo (era lui, non c’era dubbio: lo avevo veduto nella sua voce) – avessero attraversato il corridojo. Fuggire? E se Papiano, entrando, aveva domandato alla serva s’io fossi in casa? Che avrebbe pensato della mia fuga? Ma d’altra parte, se già sapeva ch’io non ero Adriano Meis? Piano! Che notizia poteva aver di me quello Spagnuolo? Mi aveva veduto a Montecarlo. Gli avevo io detto, allora, che mi chiamavo Mattia Pascal? Forse! Non ricordavo…
Mi trovai, senza saperlo, davanti allo specchio, come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai. Ah quell’occhio maledetto ! Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto. Ma come mai, come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura di Montecarlo? Questo più d’ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Niente. Aspettar lì che ciò che doveva avvenire avvenisse.
Non avvenne nulla. E pur non di meno la paura non mi passò, neppure la sera di quello stesso giorno, allorché Papiano, spiegandomi il mistero per me insolubile e terribile di quella visita, mi dimostrò ch’egli non era affatto su la traccia del mio passato, e che solo il caso, di cui da un pezzo godevo i favori, aveva voluto farmene un altro, rimettendomi tra i piedi quello Spagnuolo, che forse non si ricordava più di me né punto né poco.
Secondo le notizie che Papiano mi diede di lui, io, andando a Montecarlo, non potevo non incontrarvelo, poich’egli era un giocatore di professione. Strano era che lo incontrassi ora a Roma, o piuttosto, che io, venendo a Roma, mi fossi intoppato in una casa, ove anch’egli poteva entrare. Certo, s’io non avessi avuto da temere, questo caso non mi sarebbe parso tanto strano: quante volte infatti non ci avviene d’imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione? Del resto, egli aveva o credeva d’avere le sue buone ragioni per venire a Roma e in casa di Papiano. Il torto era mio, o del caso che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome.
Circa vent’anni addietro, il marchese Giglio d’Auletta, di cui Papiano era il segretario, aveva sposato l’unica sua figliuola a don Antonio Pantogada, addetto all’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Poco dopo il matrimonio, il Pantogada, scoperto una notte dalla polizia in una bisca insieme con altri dell’aristocrazia romana, era stato richiamato a Madrid. Là aveva fatto il resto, e forse qualcos’altro di peggio, per cui era stato costretto a lasciar la diplomazia. D’allora in poi, il marchese d’Auletta non aveva avuto più pace, forzato continuamente a mandar danaro per pagare i debiti di giuoco del genero incorreggibile. Quattr’anni fa, la moglie del Pantogada era morta, lasciando una giovinetta di circa sedici anni, che il marchese aveva voluto prendere con sé, conoscendo pur troppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta. Il Pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare; ma poi, costretto da una impellente necessità di denaro, aveva ceduto. Ora egli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia, e quel giorno appunto era venuto a Roma con questo intento, per scroccare cioè altro danaro al povero marchese, sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote Pepita.
Aveva parole di fuoco, lui, Papiano, per bollare questo indegno ricatto del Pantogada. Ed era veramente sincera quella sua collera generosa. E mentre egli parlava, io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza che, pur potendo indignarsi così, realmente, delle altrui nequizie, gli permetteva poi di farne delle simili o quasi, tranquillissimamente, a danno di quel buon uomo del Paleari, suo suocero.
Intanto il marchese Giglio quella volta voleva tener duro. Ne seguiva che il Pantogada sarebbe rimasto a Roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa Terenzio Papiano, col quale doveva intendersi a meraviglia. Un incontro dunque fra me e quello Spagnuolo sarebbe stato forse inevitabile, da un giorno all’altro. Che fare?
Non potendo con altri, mi consigliai di nuovo con lo specchio. In quella lastra l’immagine del fu Mattia Pascal, venendo a galla come dal fondo della gora, con quell’occhio che solamente m’era rimasto di lui, mi parlò così:
«In che brutto impiccio ti sei cacciato, Adriano Meis! Tu hai paura di Papiano, confessalo! e vorresti dar la colpa a me, ancora a me, solo perché io a Nizza mi bisticciai con lo Spagnuolo. Eppure ne avevo ragione, tu lo sai. Ti pare che possa bastare per il momento il cancellarti dalla faccia l’ultima traccia di me? Ebbene, segui il consiglio della signorina Caporale e chiama il dottor Ambrosini, che ti rimetta l’occhio a posto. Poi… vedrai!»
««« Capitolo 11 Capitolo 13 »»»
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com