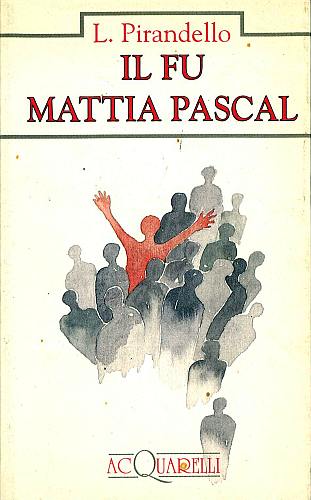Il fu Mattia Pascal – Capitolo 13 – Il lanternino
««« Capitolo 12 Capitolo 14 »»»
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «Il fu Mattia Pascal» su Amazon
Capitolo 13 – Il lanternino
Quaranta giorni al bujo.
Riuscita, oh, riuscita benissimo l’operazione. Solo che l’occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino pochino più grosso dell’altro. Pazienza! E intanto, sì, al bujo quaranta giorni, in camera mia.
Potei sperimentare che l’uomo, quando soffre, si fa una particolare idea del bene e del male, e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende, come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso; e del male che egli può fare a gli altri, come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa e di tutto il male ch’egli fa quasi per diritto, facilmente si scusa.
Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio, il bisogno d’esser confortato in qualche modo crebbe fino all’esasperazione. Sapevo, si, di trovarmi in una casa estranea; e che perciò dovevo anzi ringraziare i miei ospiti delle cure delicatissime che avevano per me. Ma non mi bastavano più, quelle cure; m’irritavano anzi, come se mi fossero usate per dispetto. Sicuro! Perché indovinavo da chi mi venivano. Adriana mi dimostrava per mezzo di esse, ch’ella era col pensiero quasi tutto il giorno Lì con me, in camera mia; e grazie della consolazione! Che mi valeva, se io intanto, col mio, la inseguivo di qua e di là per casa, tutto il giorno, smaniando? Lei sola poteva confortarmi: doveva; lei che più degli altri era in grado d’intendere come e quanto dovesse pesarmi la noja, rodermi il desiderio di vederla o di sentirmela almeno vicina.
E la smania e la noja erano accresciute anche dalla rabbia che mi aveva suscitato la notizia della subitanea partenza da Roma del Pantogada. Mi sarei forse rintanato lì per quaranta giorni al bujo, se avessi saputo ch’egli doveva andar via cosi presto?
Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il bujo era immaginario.
– Immaginario? Questo? – gli gridai.
– Abbia pazienza mi spiego.
E mi svolse (fors’anche perché fossi preparato a gli esperimenti spiritici, che si sarebbero fatti questa volta in camera mia, per procurarmi un divertimento) mi svolse, dico, una sua concezione filosofica, speciosissima, che si potrebbe forse chiamare lanterninosofia.
Di tratto in tratto, il brav’uomo s’interrompeva per domandarmi:
– Dorme, signor Meis?
E io ero tentato di rispondergli:
– Sì, grazie, dormo, signor Anselmo.
Ma poiché l’intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare.
E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non siamo come l’albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l’aria, la pioggia, il vento, non sembra che sieno cose ch’esso non sia: cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna.
E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione?
– Dorme, signor Meis?
– Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino.
– Ah, bene… Ma poiché lei ha l’occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d’inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io… E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d’un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell’improvviso bujo, allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe? Ricordo una bella poesia di Niccolò Tommaseo:
La piccola mia lampa
Non, come sol, risplende,
Né, come incendio, fuma;
Non stride e non consuma,
Ma con la cima tende
Al ciel che me la diè. Starà su me, sepolto,
Viva; né pioggia o Vento,
Né in lei le età potranno;
E quei che passeranno
Erranti, a lume spento,
Lo accenderan da me.
Ma come, signor Meis, se alla lampa nostra manca l’olio sacro che alimentava quella del Poeta? Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell’alimento necessario le loro lanternucce. Sono, per lo più, poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita, e che vanno innanzi, nel bujo dell’esistenza, con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, ché duri almeno accesa fin là, fino all’orlo fatale, al quale s’affrettano, tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo: «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita intorno, che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede…» perché lo vedono loro, non solamente in sé, ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio, alla fine. Il fioco, ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi; a certi altri, invece, che si credono armati, come tanti Giove, del fulmine domato dalla scienza, e, in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto questo bujo, quest’enorme mistero, nel quale indarno i filosofi dapprima specularono, e che ora, pur rinunziando all’indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non si colora? Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente, per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè, di cui le ho finora parlato? Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto, non l’estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d’ombra fittizia, oltre il breve àmbito dello scarso lume, che noi, povere lucciole sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d’esilio che ci angoscia? Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità: nella realtà della natura non esiste. Noi, – non so se questo possa farle piacere – noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l’universo; anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell’universo, ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com’esso è in realtà! Ma nossignore: ce lo colora a modo suo, e ci fa vedere certe cose, che noi dobbiamo veramente lamentare, perbacco, che forse in un’altra forma d’esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane, stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno, della paura che c’ispirò!
Oh perché dunque il signor Anselmo Paleari, pur dicendo, e con ragione, tanto male del lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, ne voleva accendere ora un altro col vetro rosso, là in camera mia, pe’ suoi esperimenti spiritici? Non era già di troppo quell’uno?
Volli domandarglielo.
– Correttivo! – mi rispose. – Un lanternino contro l’altro! Del resto a un certo punto questo si spegne, sa!
– E le sembra che sia il miglior mezzo, codesto, per vedere qualche cosa? – m’arrischiai a osservare.
– Ma la così detta luce, scusi, – ribatté pronto il signor Anselmo, – può servire per farci vedere ingannevolmente qua, nella così detta vita; per farci vedere di là da questa, non serve affatto, creda, anzi nuoce. Sono stupide pretensioni di certi scienziati di cuor meschino e di più meschino intelletto, i quali vogliono credere per loro comodità che con questi esperimenti si faccia oltraggio alla scienza o alla natura. Ma nossignore! Noi vogliamo scoprire altre leggi, altre forse, altra vita nella natura, sempre nella natura, perbacco! oltre la scarsissima esperienza normale; noi vogliamo sforzare l’angusta comprensione, che i nostri sensi limitati ce ne dànno abitualmente. Ora, scusi, non pretendono gli scienziati per i primi ambiente e condizioni adatti per la buona riuscita dei loro esperimenti? Si può fare a meno della camera oscura nella fotografia? E dunque? Ci sono poi tanti mezzi di controllo!
Il signor Anselmo però, come potei vedere poche sere dopo, non ne usava alcuno. Ma erano esperimenti in famiglia! Poteva mai sospettare che la signorina Caporale e Papiano si prendessero il gusto d’ingannarlo? e perché, poi? che gusto? Egli era più che convinto e non aveva affatto bisogno di quegli esperimenti per rafforzar la sua fede. Come uomo dabbenissimo che era, non arrivava a supporre che potessero ingannarlo per altro fine. Quanto alla meschinità affliggente e puerile dei resultati, la teosofia s’incaricava di dargliene una spiegazione plausibilissima. Gli esseri superiori del Piano Mentale, o di più sù, non potevano discendere a comunicare con noi per mezzo di un medium bisognava dunque contentarsi delle manifestazioni grossolane di anime di trapassati inferiori, del Piano Astrale, cioè del più prossimo al nostro: ecco.
E chi poteva dirgli di no?1
1«Fede», scriveva Maestro Alberto Fiorentino, «è sustanzia di cose da sperare, e argomento e pruova di non appariscienti.» (Nota di Don Eligio Pellegrinotto)
Io sapevo che Adriana s’era sempre ricusata d’assistere a questi esperimenti. Dacché me ne stavo tappato in camera, al bujo, ella non era entrata se non raramente, e non mai sola, a domandarmi come stessi. Ogni volta quella domanda pareva ed era infatti rivolta per pura convenienza. Lo sapeva, lo sapeva bene come stavo! Mi pareva finanche di sentire un certo sapor d’ironia birichina nella voce di lei, perché già ella ignorava per qual ragione mi fossi così d’un tratto risoluto ad assoggettarmi all’operazione, e doveva perciò ritenere ch’io soffrissi per vanità, per farmi cioè più bello o meno brutto, con l’occhio accomodato secondo il consiglio della Caporale.
– Sto benone, signorina! – le rispondevo. – Non vedo niente…
– Eh, ma vedrà, vedrà meglio poi, – diceva allora Papiano.
Approfittandomi del bujo, alzavo un pugno, come per scaraventarglielo in faccia. Ma lo faceva apposta certamente, perch’io perdessi quel po’ di pazienza che mi restava ancora. Non era possibile ch’egli non s’accorgesse del fastidio che mi recava: glielo dimostravo in tutti i modi, sbadigliando, sbuffando; eppure, eccolo là: seguitava a entrare in camera mia quasi ogni sera (ah lui, sì) e vi si tratteneva per ore intere, chiacchierando senza fine. In quel bujo, la sua voce mi toglieva quasi il respiro, mi faceva torcere su la sedia, come su un aculeo, artigliar le dita: avrei voluto strozzarlo in certi momenti. Lo indovinava? lo sentiva? Proprio in quei momenti, ecco, la sua voce diventava più molle, quasi carezzevole.
Noi abbiamo bisogno d’incolpar sempre qualcuno dei nostri danni e delle nostre sciagure. Papiano, in fondo, faceva tutto per spingermi ad andar via da quella casa; e di questo, se la voce della ragione avesse potuto parlare in me, in quei giorni, io avrei dovuto ringraziarlo con tutto il cuore. Ma come potevo ascoltarla, questa benedetta voce della ragione, se essa mi parlava appunto per la bocca di lui, di Papiano, il quale per me aveva torto, torto evidente, torto sfacciato? Non voleva egli mandarmi via, infatti, per frodare il Paleari e rovinare Adriana? Questo soltanto io potevo allora comprendere da tutti que’ suoi discorsi. Oh possibile che la voce della ragione dovesse proprio scegliere la bocca di Papiano per farsi udire da me? Ma forse ero io che, per trovarmi una scusa, la mettevo in bocca a lui, perché mi paresse ingiusta, io che mi sentivo già preso nei lacci della vita e smaniavo, non per il bujo propriamente, né per il fastidio che Papiano, parlando, mi cagionava.
Di che mi parlava? Di Pepita Pantogada, sera per sera.
Benché io vivessi modestissimamente, s’era fitto in capo che fossi molto ricco. E ora, per deviare il mio pensiero da Adriana, forse vagheggiava l’idea di farmi innamorare di quella nipote del marchese Giglio d’Auletta, e me la descriveva come una fanciulla saggia e fiera, piena d’ingegno e di volontà, recisa nei modi, franca e vivace; bella, poi; uh, tanto bella! bruna, esile e formosa a un tempo; tutta fuoco, con un pajo d’occhi fulminanti e una bocca che strappava i baci. Non diceva nulla della dote: – Vistosissima! – tutta la sostanza del marchese d’Auletta, nientemeno. Il quale, senza dubbio, sarebbe stato felicissimo di darle presto marito, non solo per liberarsi del Pantogada che lo vessava, ma anche perché non andavano tanto d’accordo nonno e nipote: il marchese era debole di carattere, tutto chiuso in quel suo mondo morto; Pepita invece, forte, vibrante di vita.
Non comprendeva che più egli elogiava questa Pepita, più cresceva in me l’antipatia per lei, prima ancora di conoscerla? La avrei conosciuta – diceva – fra qualche sera, perché egli la avrebbe indotta a intervenire alle prossime sedute spiritiche. Anche il marchese Giglio d’Auletta avrei conosciuto, che lo desiderava tanto per tutto ciò che egli, Papiano, gli aveva detto di me. Ma il marchese non usciva più di casa, e poi non avrebbe mai preso parte a una seduta spiritica, per le sue idee religiose.
– E come? – domandai. – Lui, no; e intanto permette che vi prenda parte la nipote?
– Ma perché sa in quali mani l’affida! – esclamò alteramente Papiano.
Non volli saper altro. Perché Adriana si ricusava d’assistere a quegli esperimenti? Pe’ suoi scrupoli religiosi. Ora, se la nipote del marchese Giglio avrebbe preso parte a quelle sedute, col consenso del nonno clericale, non avrebbe potuto anch’ella parteciparvi? Forte di questo argomento, io cercai di persuaderla, la vigilia della prima seduta.
Era entrata in camera mia col padre, il quale udita la mia proposta:
– Ma siamo sempre lì, signor Meis! – sospirò. – La religione, di fronte a questo problema, drizza orecchie d’asino e adombra, come la scienza. Eppure i nostri esperimenti, l’ho già detto e spiegato tante volte a mia figlia, non sono affatto contrarii né all’una né all’altra. Anzi, per la religione segnatamente sono una prova delle verità che essa sostiene.
– E se io avessi paura? – obbiettò Adriana.
– Di che? – ribatté il padre. – Della prova?
– O del bujo? – aggiunsi io. – Siamo tutti qua, con lei, signorina! Vorrà mancare lei sola?
– Ma io… – rispose, impacciata, Adriana, – io non ci credo, ecco… non posso crederci, e… che so!
Non poté aggiunger altro. Dal tono della voce, dall’imbarazzo, io però compresi che non soltanto la religione vietava ad Adriana d’assistere a quegli esperimenti. La paura messa avanti da lei per iscusa poteva avere altre cause, che il signor Anselmo non sospettava. O le doleva forse d’assistere allo spettacolo miserevole del padre puerilmente ingannato da Papiano e dalla signorina Caporale?
Non ebbi animo d’insistere più oltre.
Ma ella, come se mi avesse letto in cuore il dispiacere che il suo rifiuto mi cagionava, si lasciò sfuggire nel bujo un: – Del resto… – ch’io colsi subito a volo:
– Ah brava! L’avremo dunque con noi?
– Per domani sera soltanto, – concesse ella, sorridendo.
Il giorno appresso, sul tardi, Papiano venne a preparare la camera: v’introdusse un tavolino rettangolare, d’abete, senza cassetto, senza vernice, dozzinale; sgombrò un angolo della stanza; vi appese a una funicella un lenzuolo; poi recò una chitarra, un collaretto da cane con molti sonaglioli, e altri oggetti. Questi preparativi furono fatti al lume del famoso lanternino dal vetro rosso. Preparando, non smise – s’intende! – un solo istante di parlare.
– Il lenzuolo serve, sa! serve… non saprei, da… da accumulatore, diciamo, di questa forza misteriosa: lei lo vedrà agitarsi, signor Meis, gonfiarsi come una vela, rischiararsi a volte d’un lume strano, quasi direi siderale. Sissignore! Non siamo ancora riusciti a ottenere «materializzazioni», ma luci sì: ne vedrà, se la signorina Silvia questa sera si troverà in buone disposizioni. Comunica con lo spirito di Un suo antico compagno d’Accademia, morto, Dio ne scampi, di tisi, a diciott’anni. Era di… non so, di Basilea, mi pare: ma stabilito a Roma da un pezzo, con la famiglia. Un genio, sa, per la musica: reciso dalla morte crudele prima che avesse potuto dare i suoi frutti. Così almeno dice la signorina Caporale. Anche prima che ella sapesse d’aver questa facoltà medianica, comunicava con lo spirito di Max. Sissignore: si chiamava così, Max… aspetti, Max Oliz, se non sbaglio. Sissignore! Invasata da questo spirito, improvvisava sul pianoforte, fino a cader per terra, svenuta, in certi momenti. Una sera si raccolse perfino gente, giù in istrada, che poi la applaudì…
– E la signorina Caporale ne ebbe quasi paura, – aggiunsi io, placidamente.
– Ah, lo sa? – fece Papiano, restando.
– Me l’ha detto lei stessa. Sicché dunque applaudirono la musica di Max sonata con le mani della signorina Caporale?
– Già, già! Peccato che non abbiamo in casa un pianoforte. Dobbiamo contentarci di qualche motivetto, di qualche spunto, accennato su la chitarra. Max s’arrabbia, sa! fino a strappar le corde, certe volte… Ma sentirà stasera. Mi pare che sia tutto in ordine, ormai.
– E dica un po’, signor Terenzio. Per curiosità, – volli domandargli, prima che andasse via, – lei ci crede? ci crede proprio?
– Ecco, – mi rispose subito, come se avesse preveduto la domanda. – Per dire la verità, non riesco a vederci chiaro.
– Eh sfido!
– Ah, ma non perché gli esperimenti si facciano al bujo, badiamo! I fenomeni, le manifestazioni sono reali, non c’è che dire: innegabili. Noi non possiamo mica diffidare di noi stessi…
– E perché no? Anzi!
– Come? Non capisco!
– C’inganniamo così facilmente! Massime quando ci piaccia di credere in qualche cosa…
– Ma a me, no, sa: non piace! – protestò Papiano. – Mio suocero, che è molto addentro in questi studii, ci crede. Io, fra l’altro, veda, non ho neanche il tempo di pensarci… se pure ne avessi voglia. Ho tanto da fare, tanto, con quei maledetti Borboni del marchese che mi tengono lì a chiodo! Perdo qui qualche serata. Dal canto mio, son d’avviso, che noi, finché per grazia di Dio siamo vivi, non potremo saper nulla della morte; e dunque, non le pare inutile pensarci? Ingegnamoci di vivere alla meglio, piuttosto, santo Dio! Ecco come io la penso, signor Meis. A rivederla, eh? Ora scappo a prendere in via dei Pontefici la signorina Pantogada.
Ritornò dopo circa mezz’ora, molto contrariato: insieme con la Pantogada e la governante era venuto un certo pittore spagnuolo, che mi fu presentato a denti stretti come amico di casa Giglio. Si chiamava Manuel Bernaldez e parlava correttamente l’italiano; non ci fu verso però di fargli pronunciare l’esse del mio cognome: pareva che ogni volta, nell’atto di proferirla, avesse paura che la lingua gliene restasse ferita.
– Adriano Mei, – diceva, come se tutt’a un tratto fossimo diventati amiconi.
– Adriano Tui, – mi veniva quasi di rispondergli.
Entrarono le donne: Pepita, la governante, la signorina Caporale, Adriana.
– Anche tu? Che novità? – le disse Papiano con mal garbo.
Non se l’aspettava quest’altro tiro. Io intanto, dal modo con cui era stato accolto il Bernaldez, avevo capito che il marchese Giglio non doveva saper nulla dell’intervento di lui alla seduta, e che doveva esserci sotto qualche intrighetto con la Pepita.
Ma il gran Terenzio non rinunziò al suo disegno. Disponendo intorno al tavolino la catena medianica, si fece sedere accanto Adriana e pose accanto a me la Pantogada.
Non ero contento? No. E Pepita neppure. Parlando tal quale come il padre, ella si ribellò subito:
– Gracie tanto, asì no puede ser! Ió voglio estar entre el segnor Paleari e la mia governante, caro segnor Terenzio!
La semioscurità rossastra permetteva appena di discernere i contorni; cosicché non potei vedere fino a qual punto rispondesse al vero il ritratto che della signorina Pantogada m’aveva abbozzato Papiano; il tratto però, la voce e quella sùbita ribellione s’accordavano perfettamente all’idea che m’ero fatta di lei, dopo quella descrizione.
Certo, rifiutando cosi sdegnosamente il posto che Papiano le aveva assegnato accanto a me, la signorina Pantogada m’offendeva; ma io non solo non me n’ebbi a male, ma anzi me ne rallegrai.
– Giustissimo! – esclamò Papiano. – E allora, si può far così: accanto al signor Meis segga la signora Candida; poi prenda posto lei, signorina. Mio suocero rimanga dov’è: e noi altri tre pure così, come stiamo. Va bene?
E no! non andava bene neanche così: né per me, né per la signorina Caporale, né per Adriana e né – come si vide poco dopo – per la Pepita, la quale stette molto meglio in una nuova catena disposta proprio dal genialissimo spirito di Max.
Per il momento, io mi vidi accanto quasi un fantasima di donna, con una specie di collinetta in capo (era cappello? era cuffia? parrucca? che diavolo era?). Di sotto quel carico enorme uscivan di tratto in tratto certi sospiri terminati da un breve gemito. Nessuno aveva pensato a presentarmi a quella signora Candida : ora, per far la catena, dovevamo tenerci per mano; e lei sospirava. Non le pareva ben fatto, ecco. Dio, che mano fredda!
Con l’altra mano tenevo la sinistra della signorina Caporale seduta a capo del tavolino, con le spalle contro il lenzuolo appeso all’angolo; Papiano le teneva la destra. Accanto ad Adriana, dall’altra parte, sedeva il pittore; il signor Anselmo stava all’altro capo del tavolino, dirimpetto alla Caporale.
Papiano disse:
– Bisognerebbe spiegare innanzi tutto al signor Meis e alla signorina Pantogada il linguaggio… come si chiama?
– Tiptologico, – suggerì il signor Anselmo.
– Prego, anche a me, – si rinzelò la signora Candida, agitandosi su la seggiola.
– Giustissimo! Anche alla signora Candida, si sa!
– Ecco, – prese a spiegare il signor Anselmo. – Due colpi vogliono dir sì…
– Colpi? – interruppe Pepita. – Che colpi?
– Colpi, – rispose Papiano, – o battuti sul tavolino o su le seggiole o altrove o anche fatti percepire per via di toccamenti.
– Ah no-no-no-no-nó!! – esclamò allora quella a precipizio, balzando in piedi. – Ió non ne amo, tocamenti. De chi?
– Ma dello spirito di Max, signorina, – le spiegò Papiano. – Gliel’ho accennato, venendo: non fanno mica male, si rassicuri.
– Tittologichi, – aggiunse con aria di commiserazione, da donna superiore, la signora Candida.
– E dunque, – riprese il signor Anselmo, – due colpi, sì; tre colpi, no; quattro, bujo; cinque, parlate; sei, luce. Basterà così. E ora concentriamoci, signori miei.
Si fece silenzio. Ci concentrammo.
««« Capitolo 12 Capitolo 14 »»»
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com