««« Libro Terzo Libro Quinto »»»
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
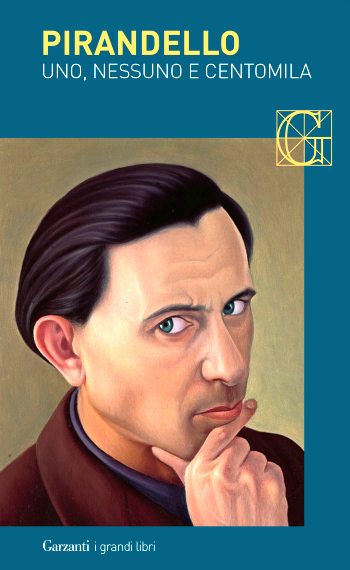 Acquista «Uno, nessuno e centomila» su Amazon
Acquista «Uno, nessuno e centomila» su Amazon
I. Com’erano per me Marco di Dio e sua moglie Diamante
Dico «erano»; ma forse sono in vita ancora. Dove? Qua ancora, forse, che potrei vederli domani. Ma qua, dove? Non ho più mondo per me; nulla posso sapere del loro, dov’essi si fingono d’essere. So di certo che vanno per via, se domani li incontro per via. Potrei domandare a lui:
– Tu sei Marco di Dio?
E lui mi risponderebbe:
– Sì. Marco di Dio.
– E cammini per questa via?
– Sì. Per questa via.
– E codesta è tua moglie Diamante?
– Sì. Mia moglie Diamante.
– E questa via si chiama così e così?
– Così e così. E ha tante case, tante traverse, tanti lampioni, ecc. ecc.
Come in una grammatica d’Orlendorf.
Ebbene, questo mi bastava allora, come adesso a voi, per stabilire la realtà di Marco di Dio e di sua moglie Diamante e della via per cui potrei ancora incontrarli, come allora li incontravo. Quando? Oh, non molti anni fa. Che bella precisione di spazio e di tempo! La via, cinque anni fa.
L’eternità s’è sprofondata per me, non tra questi cinque anni solamente, ma tra un minuto e l’altro. E il mondo in cui vivevo allora mi pare più lontano della più lontana stella del cielo.
Marco di Dio e sua moglie Diamante mi sembravano due sciagurati, a cui però la miseria, se da un canto pareva avesse persuaso essere inutile ormai che si lavassero la faccia ogni mattina, certo dall’altro poi persuadeva ancora di non lasciare nessun mezzo intentato, non già per guadagnare quel poco ogni giorno che bastasse almeno a sfamarli, ma per diventare dall’oggi al domani milionarii: mi-lio-na-ri-i come diceva lui, sillabando, con gli occhi truci, sbarrati.
Ridevo allora, e tutti con me ridevano nel sentirgli dire così. Ora ne provo raccapriccio, considerando che potevo riderne solo perché non m’era ancora avvenuto di dubitare di quella corroborante provvidenzialissima cosa che si chiama la regolarità delle esperienze; per cui potevo stimare un sogno buffo che si potesse diventare milionarii dall’oggi al domani. Ma se questo, ch’è statò già dimostrato un sottilissimo filo, voglio dire della regolarità delle esperienze, si fosse spezzato in me? se per il ripetersi di due o tre volte avesse acquistato invece regolarità per me questo sogno buffo? Anche a me allora sarebbe riuscito impossibile dubitare che realmente si possa da un giorno all’altro diventare milionarii. Quanti conservano la beata regolarità delle esperienze non possono immaginare quali cose possono essere reali o verosimili per chi viva fuori d’ogni regola, come appunto quell’uomo lì.
Si credeva inventore.
E un inventore, signori miei, un bel giorno, apre gli occhi, inventa una cosa, e là: diventa milionario!
Tanti ancora lo ricordano come un selvaggio, appena venuto dalla campagna a Richieri. Ricordano che fu accolto allora nello studio d’uno dei nostri più reputati artisti, ora morto; e che in poco tempo vi aveva imparato a lavorare con molta perizia il marmo. Se non che il maestro, un giorno, volle prenderlo a modello per un suo gruppo che, esposto in gesso in una mostra d’arte, divenne famoso sotto il titolo Satiro e fanciullo.
Aveva potuto l’artista tradurre senza danno nella creta una visione fantastica, non certo castigata ma bellissima, e compiacersene e averne lode.
Il delitto era nella creta.
Non sospettò il maestro che in quel suo scolaro potesse sorgere la tentazione di tradurre a sua volta quella visione fantastica, dalla creta ov’era lodevolmente fissata per sempre, in un movimento momentaneo e non più lodevole, mentre, oppresso dall’afa d’un pomeriggio estivo, sudava nello studio a sbozzare nel marmo quel gruppo.
Il fanciullo vero non volle avere la sorridente docilità che il finto dava a vedere nella creta; gridò ajuto; accorse gente; e Marco di Dio fu sorpreso in un atto ch’era della bestia sorta in lui d’improvviso in quel momento d’afa.
Ora, siamo giusti: bestia, sì, schifosissima, in quell’atto; ma per tanti altri atti onestamente attestati, non era più forse Marco di Dio anche quel buon giovine che il suo maestro dichiarò d’aver sempre conosciuto nel suo sbozzatore?
So che offendo con questa domanda la vostra moralità. Difatti mi rispondete che se in Marco di Dio poté sorgere una tale tentazione è segno evidente ch’egli non era quel buon giovine che il suo maestro diceva. Potrei farvi osservare intanto, che di simili tentazioni (e anche di più turpi) sono pur piene le vite dei santi. I santi le attribuivano alle demonia e, con l’ajuto di Dio, potevano vincerle. Così anche i freni che abitualmente imponete a voi stessi impediscono di solito a quelle tentazioni di nascere in voi, o che in voi scappi fuori all’improvviso il ladro o l’assassino. L’oppressione dell’afa d’un pomeriggio estivo non è mai riuscita a liquefare la crosta della vostra abituale probità né ad accendere in voi momentaneamente la bestia originaria. Potete condannare.
Ma se io ora mi metto a parlarvi di Giulio Cesare, la cui gloria imperiale vi riempie di tanta ammirazione?
– Volgarità! – esclamate. – Non era più, allora, Giulio Cesare. Lo ammiriamo là dove Giulio Cesare era veramente lui.
Benissimo. Lui. Ma vedete? Se Giulio Cesare era lui soltanto là dove voi l’ammirate, quando non era più là, dov’era? chi era? nessuno? uno qualunque? e chi?
Bisognerà domandarlo a Calpurnia sua moglie, o a Nicomede re di Bitinia.
Batti e batti, alla fine v’è entrato in mente anche questo: che Giulio Cesare, uno, non esisteva. Esisteva, sì, un Giulio Cesare qual egli, in tanta parte della sua vita, si rappresentava; e questo aveva senza dubbio un valore incomparabilmente più grande degli altri; non però quanto a realtà, vi prego di credere, perché non meno reale di questo Giulio Cesare imperiale era quel lezioso fastidioso tutto raso e discinto e infedelissimo di sua moglie Calpurnia: o quello impudicissimo di Nicomede re di Bitinia.
Il guajo è questo, sempre, signori: che dovevano tutti quanti esser chiamati con quel nome solo di Giulio Cesare, e che in un solo corpo di sesso maschile dovevano coabitare tanti e anche una femmina; la quale, volendo esser femmina e non trovandone il modo in quel corpo maschile, dove e come poté, innaturalmente lo fu, e impudicissima e anche più volte recidiva.
Il satiro in quel povero Marco di Dio scappò fuori, a buon conto, una volta sola e tentato da quel gruppo del suo maestro. Sorpreso in quell’atto d’un momento, fu condannato per sempre. Non trovò nessuno che volesse avere considerazione di lui; e, uscito dal carcere, si diede ad almanaccare i più bislacchi disegni per sollevarsi dall’ignominiosa miseria in cui era caduto, a braccetto con una donna, la quale un bel giorno era venuta a lui, nessuno sapeva come né da che parte.
Diceva da una decina d’anni che sarebbe partito per l’Inghilterra la settimana ventura. Ma erano forse passati per lui questi dieci anni? Erano passati per coloro che glielo sentivano dire. Egli era sempre deciso a partire per l’Inghilterra la settimana ventura. E studiava l’inglese. O almeno, da anni teneva sotto il braccio una grammatica inglese, aperta e ripiegata sempre allo stesso punto, sicché quelle due pagine dell’apertura con lo strusciare del braccio e il sudicio della giacca erano ridotte ormai illeggibili, mentre le seguenti erano rimaste incredibilmente pulite. Ma fin dove era il sudicio egli sapeva. E di tratto in tratto, andando per via, rivolgeva di sorpresa, aggrondato, qualche domanda alla moglie, come a saggiarne la prontezza e la maturità:
– Is Jane a happy child?
E la moglie rispondeva pronta e seria:
– Yes, Jane is a happy child.
Perché anche la moglie la settimana ventura sarebbe partita per l’Inghilterra con lui.
Era uno sgomento, e insieme una pietà, questo spettacolo d’una donna, com’egli fosse riuscito ad attirarla, e farla vivere da cagna fedele in quel suo sogno buffo, di diventar milionario dall’oggi al domani con un’invenzione; per esempio, di «cessi inodori per paesi senz’acqua nelle case». Ridete? La loro serietà era così truce per questo; dico, perché tutti ne ridevano. Era anzi feroce. E tanto più feroce diventava quanto più crescevano, attorno ad essa, le risa.
E ormai erano arrivati a tal punto, che se qualcuno per caso si fermava ad ascoltare i loro disegni senza riderne, essi, anziché compiacersene, gli lanciavano oblique occhiatacce, non pur di sospetto, anche d’odio. Perché la derisione degli altri era ormai l’aria in cui quel loro sogno respirava. Tolta la derisione, rischiavano di soffocare.
Mi spiego perciò come per loro il peggior nemico fosse stato mio padre.
Non si permetteva infatti solamente con me mio padre quel lusso di bontà di cui ho parlato più sù. Si compiaceva anche d’agevolare, con munificenza che non si stancava, e ridendo di quel suo particolar sorriso, le stolide illusioni di certuni che, come Marco di Dio, venivano a piangere davanti a lui la loro infelicità di non aver tanto da ridurre a effetto i loro disegni, il loro sogno: la ricchezza!
– Quanto? – domandava mio padre.
Oh, poco. Perché era sempre poco ciò che bastava a costoro per diventar ricchi: mi-lio-na-ri-i. E mio padre dava.
– Ma come! dicevi che ci voleva così poco…
– Già. Non avevo calcolato bene. Ma adesso, proprio…
– Quanto?
– Oh, poco!
E mio padre dava, dava. Ma poi, a un certo punto, basta. E quelli allora, com’è facile intendere, non gli restavano grati del non aver voluto godere beffardamente fin all’ultimo della loro totale disillusione e del potere attribuire a lui invece, senza rimorso, il fallimento, sul meglio, delle loro illusioni. E nessuno con più accanimento di costoro si vendicava chiamando mio padre usurajo.
Il più accanito di tutti, era stato questo Marco di Dio. Il quale ora, morto mio padre, rovesciava su me, e non senza ragione, il suo odio feroce. Non senza ragione, perché anch’io, quasi a mia insaputa, seguitavo a beneficarlo. Lo tenevo alloggiato in una catapecchia di mia proprietà, di cui né Firbo né Quantorzo gli avevano mai richiesto la pigione. Ora questa catapecchia appunto mi diede il mezzo di tentare su lui il mio primo esperimento.
II. Ma fu totale
Totale, perché bastò muovere in me appena appena, così per giuoco, la volontà di rappresentarmi diverso a uno dei centomila in cui vivevo, perché s’alterassero in centomila modi diversi tutte le altre mie realtà.
E per forza questo giuoco, se considerate bene, doveva fruttarmi la pazzia. O per dir meglio, quest’orrore: la coscienza della pazzia, fresca e chiara, signori, fresca e chiara come una mattinata d’aprile, e lucida e precisa come uno specchio.
Perché, incamminandomi verso quel primo esperimento, andavo a porre graziosamente la mia volontà fuori di me, come un fazzoletto che mi cavassi di tasca. Volevo compiere un atto che non doveva esser mio, ma di quell’ombra di me che viveva realtà in un altro; così solida e vera che avrei potuto togliermi il cappello e salutarla, se per dannata necessità non avessi dovuto incontrarla e salutarla viva, non propriamente in me, ma nel mio stesso corpo, il quale, non essendo per sé nessuno, poteva esser mio ed era mio in quanto rappresentava me a me stesso, ma poteva anche essere ed era di quell’ombra, di quelle centomila ombre che mi rappresentavano in centomila modi vivo e diverso ai centomila altri.
Difatti, non andavo forse incontro al signor Vitangelo Moscarda per giocargli un brutto tiro? Eh! signori, sì, un brutto tiro (scusatemi tutti questi ammiccamenti; ma ho bisogno di ammiccare, d’ammiccare così, perché, non potendo sapere come v’appajo in questo momento, tiro anche, con questi ammiccamenti, a indovinare) cioè, a fargli compiere un atto del tutto contrario a lui e incoerente: un atto che, distruggendo di colpo la logica della sua realtà, lo annientasse così agli occhi di Marco di Dio come di tanti altri?
Senza intendere, sciagurato! che la conseguenza d’un simile atto non poteva esser quella che m’immaginavo: di presentarmi cioè a domandare a tutti, dopo:
– Vedete adesso, signori, che non è vero niente che io sia quell’usurajo che voi volete vedere in me?
Ma quest’altra, invece: che tutti dovessero esclamare, sbigottiti:
– O oh! sapete? l’usurajo Moscarda è impazzito!
Perché l’usurajo Moscarda poteva sì impazzire, ma non si poteva distruggere così d’un colpo, con un atto contrario a lui e incoerente. Non era un’ombra da giocarci e da pigliare a gabbo, l’usurajo Moscarda: un signore era da trattare coi dovuti riguardi, alto un metro e sessantotto, rosso di pelo come papà, il fondatore della banca, con le sopracciglia, sì, ad accento circonflesso e quel naso che gli pendeva verso destra come a quel caro stupido Gengè di mia moglie Dida: un signore, insomma, che Dio liberi, impazzendo, rischiava di trascinarsi al manicomio con sé tutti gli altri Moscarda ch’io ero per gli altri e anche, oh Dio, quel povero innocuo Gengè di mia moglie Dida; e, se permettete, anche me che, leggero e sorridente, ci avevo giocato.
Rischiai, cioè, rischiammo tutti quanti, come vedrete, il manicomio, questa prima volta; e non ci bastò. Dovevamo anche rischiar la vita, perché io mi riprendessi e trovassi alla fine (uno, nessuno e centomila) la via della salute.
Ma non anticipiamo.
III. Atto notarile
Mi recai dapprima nello studio del notaro Stampa, in Via del Crocefisso, numero 24. Perché (eh, questi sono sicurissimi dati di fatto) a dì… dell’anno…, regnando Vittorio Emanuele m per grazia di Dio e volontà della nazione re d’Italia, nella nobile città di Richieri, in Via del Crocefisso, al numero civico 24, teneva studio di regio notaro il signor Stampa cav. Elpidio, d’anni 52 o 53.
– Ci sta ancora? Al numero 24? Lo conoscete tutti il notaro Stampa?
Oh, e allora possiamo essere sicuri di non sbagliare. Quel notaro Stampa là, che conosciamo tutti. Va bene? Ma io ero, entrando nello studio, in uno stato d’animo, che voi non vi potete immaginare. Come potreste immaginarvelo, scusate, se vi pare ancora la cosa più naturale del mondo entrare nello studio d’un notaro per stendere un atto qualsiasi, e se dite che lo conoscete tutti questo notaro Stampa?
Vi dico che io ci andavo, quel giorno, per il mio primo esperimento. E insomma, lo volete fare anche voi, sì o no, questo esperimento con me, una buona volta? dico, di penetrare lo scherzo spaventoso che sta sotto alla pacifica naturalezza delle relazioni quotidiane, di quelle che vi pajono le più consuete e normali, e sotto la quieta apparenza della così detta realtà delle cose? Lo scherzo, santo Dio, per cui pure v’accade d’arrabbiarvi ogni cinque minuti e di gridare all’amico che vi sta accanto:
– Ma scusa! ma come non vedi questo? sei cieco?
E quello no, non lo vede, perché vede un’altra cosa lui, quando voi credete che debba vedere la vostra, come pare a voi. La vede invece come pare a lui, e per lui dunque il cieco siete voi.
Questo scherzo, io dico; com’io già lo avevo penetrato.
Ora entravo in quello studio, carico di tutte le riflessioni e considerazioni covate così lungamente e me le sentivo come friggere dentro, insieme, in gran subbuglio; e mi volevo intanto tenere così, in una lucida fissità, in una quasi immobile frigidezza, mentre figuratevi in quale risata fragorosa mi veniva di prorompere nel vedermelo davanti serio serio, poverino, quel signor notaro Stampa, senza il minimo sospetto ch’io potessi per me non essere quale mi vedeva lui, e sicurissimo d’esser lui per me quello stesso che ogni giorno nell’annodarsi la cravattina nera davanti allo specchio si vedeva, con tutte le sue cose attorno.
Capite, adesso? Mi veniva d’ammiccare, d’ammiccare anche a lui, per significargli furbescamente «Bada sotto! Bada sotto!». Mi veniva anche, Dio mio, di cacciar fuori all’improvviso la lingua, di smuovere il naso con una subitanea smusatina per alterargli a un tratto, così per gioco e senza malizia, quell’immagine di me ch’egli credeva vera. Ma serio eh? Serio, sù, serio. Dovevo far l’esperimento.
– Dunque, signor notaro, eccomi qua. Ma scusi, lei sta sempre sprofondato in questo silenzio?
Si voltò brusco a squadrarmi. Disse:
– Silenzio? Dove?
Per Via del Crocefisso era difatti in quel momento un continuo transito di gente e di vetture.
– Già; non nella via, certo. Ma ci sono qua tutte queste carte, signor notaro, dietro i vetri impolverati di questi scaffali. Non sente?
Tra turbato e stordito, tornò a squadrarmi; poi tese l’orecchio:
– Che sento?
– Ma questo raspìo! Ah, le zampine, scusi, le zampine lì del suo canarino; scusi scusi. Sono unghiute quelle zampine, e raspando su lo zinco della gabbia…
– Già. Sì. Ma che vuol dire?
– Oh, niente. Non le dà ai nervi, a lei, lo zinco, signor notaro?
– Lo zinco? Ma chi ci bada? Non l’avverto…
– Eppure, lo zinco, pensi! in una gabbia, sotto le gracili zampine d’un canarino, nello studio d’un notaro… Ci scommetto che non canta, questo canarino.
– Nossignore, non canta.
Cominciava a guardarmi in un certo modo il signor notaro, che stimai prudente lasciar lì il canarino per non compromettere l’esperimento; il quale, almeno in principio, e segnatamente lì, alla presenza del notaro, aveva bisogno che nessun dubbio sorgesse sulle mie facoltà mentali. E domandai al signor notaro se sapesse d’una certa casa, sita in via tale, numero tale, di pertinenza d’un certo tale signor Moscarda Vitangelo, figlio del fu Francesco Antonio Moscarda…
– E non è lei?
– Già, io sì. Sarei io…
Era così bello, peccato! in quello studio di notaro, tra tutti quegli incartamenti ingialliti in quei vecchi scaffali polverosi, parlare così, come a una distanza di secoli, d’una certa casa di pertinenza d’un certo tal Moscarda Vitangelo… Tanto più che, sì, ero io lì; presente e stipulante, in quello studio di notaro, ma chi sa come e dove se lo vedeva lui, il signor notaro, quel suo studio; che odore ci sentiva diverso da quello che ci sentivo io; e chi sa come e dov’era, nel mondo del signor notaro, quella certa casa di cui gli parlavo con voce lontana; e io, io, nel mondo del signor notaro, chi sa come curioso…
Ah, il piacere della storia, signori! Nulla più riposante della storia. Tutto nella vita vi cangia continuamente sotto gli occhi; nulla di certo; e quest’ansia senza requie di sapere come si determineranno i casi, di vedere come si stabiliranno i fatti che vi tengono in tanta ambascia e in tanta agitazione! Tutto determinato, tutto stabilito, all’incontro, nella storia: per quanto dolorose le vicende e tristi i casi, eccoli lì, ordinati, almeno, fissati in trenta, quaranta paginette di libro: quelli, e lì; che non cangeranno mai più almeno fino a tanto che un malvagio spirito critico non avrà la mala contentezza di buttare all’aria quella costruzione ideale, ove tutti gli elementi si tenevano a vicenda così bene congegnati, e voi vi riposavate ammirando come ogni effetto seguiva obbediente alla sua causa con perfetta logica e ogni avvenimento si svolgeva preciso e coerente in ogni suo particolare, col signor duca di Nevers, che il giorno tale, anno tale, ecc. ecc.
Per non guastare tutto, dovetti ricondurmi alla sospesa, temporanea e costernata realtà del signor notaro Stampa.
– Io, già, – m’affrettai a dirgli. – Sarei io, signor notaro. E la casa, lei non ha difficoltà, è vero? ad ammettere che è mia, come tutta l’eredità del fu Francesco Antonio Moscarda mio padre. Già! È che è sfitta adesso questa casa, signor notaro. Oh piccola, sa… Saranno cinque o sei stanze, con due corpi bassi – si dice così? – Belli, i corpi bassi… Sfitta dunque, signor notaro; da poterne disporre a piacer mio. Ora dunque, lei…
E qui mi chinai e a bassa voce, con molta serietà, confidai al signor notaro l’atto che intendevo fare e che qui, per ora, non posso riferire, perché – gli dissi:
– Deve restare tra me e lei, signor notaro, sotto il segreto professionale, fintanto che parrà a me. Siamo intesi?
Intesi. Ma il signor notaro mi avvertì che per fare quell’atto gli bisognavano alcuni dati e documenti per cui mi toccava andare al banco, da Quantorzo. Mi sentii contrariato; tuttavia m’alzai. Come mi mossi, una maledetta voglia mi sorse di domandare al signor notaro:
«Come cammino? Scusi: mi sappia dire almeno come mi vede camminare».
Mi trattenni a stento. Ma non potei fare a meno di voltarmi, nell’aprir l’uscio a vetri, e di dirgli con un sorriso di compassione:
– Già, col mio passo, grazie!
– Come dice? – domandò, stordito, il signor notaro.
– Ah, niente, dico che me ne vado col mio passo, signor notaro. Ma sa che una volta io ho veduto ridere un cavallo? Sissignore, mentre il cavallo camminava. Lei ora va a guardare il muso a un cavallo per vederlo ridere, e poi viene a dirmi che non l’ha visto ridere. Ma che muso! I cavalli non ridono mica col muso! Sa con che cosa ridono i cavalli, signor notaro? Con le natiche. Le assicuro che il cavallo camminando ride con le natiche, sì, alle volte, di certe cose che vede o che gli passano per il capo. Se lei vuol vederlo ridere il cavallo, gli guardi le natiche e si stia bene!
Capisco che non c’entrava dirgli così. Capisco tutto io. Ma se mi rimetto nelle condizioni d’animo in cui mi trovavo allora, che a vedermi addosso gli occhi della gente mi pareva di sottostare a un’orribile sopraffazione pensando che tutti quegli occhi mi davano un’immagine che non era certo quella che io mi conoscevo ma un’altra ch’io non potevo né conoscere né impedire; altro che dirle, mi veniva di farle, di farle, le pazzie, come rotolarmi per le strade o sorvolarle a passo di ballo, ammiccando di qua, cacciando fuori la lingua e facendo sberleffi di là… E invece andavo così serio, così serio, io, per via. E anche voi, che bellezza, andate tutti così serii…
IV. La strada maestra
Mi toccò dunque andare al banco per quelle carte della casa di cui aveva bisogno il signor notaro.
Erano mie quelle carte, senza dubbio, poiché mia era la casa, e potevo disporne. Ma se ci pensate bene, quelle carte, benché mie, non avrei potuto averle se non di furto o strappandole di mano con violenza pazzesca a un altro che agli occhi di tutti n’era il legittimo proprietario: voglio dire al signor usurajo Vitangelo Moscarda.
Per me, questo, era evidente, perché io lo vedevo bene fuori, vivo negli altri e non in me, quel signor usurajo Vitangelo Moscarda. Ma per gli altri che in me non vedevano invece se non quell’usurajo, per gli altri io, là al banco, andavo a rubarle a me stesso quelle carte o a strapparmele di mano pazzescamente.
Potevo dir forse che non ero io? o che io ero un altro? Né era in nessun modo da ragionare un atto che agli occhi di tutti voleva appunto apparire contrario a me stesso e incoerente.
Seguitavo a camminare, come vedete, con perfetta coscienza su la strada maestra della pazzia, ch’era la strada appunto della mia realtà, quale mi s’era ormai lucidissimamente aperta davanti, con tutte le immagini di me, vive, specchiate e procedenti meco.
Ma io ero pazzo perché ne avevo appunto questa precisa e specchiante coscienza; voi che pur camminate per questa medesima strada senza volervene accorgere, voi siete savii, e tanto più quanto più forte gridate a chi vi cammina accanto:
– Io, questo? io, così? Tu sei cieco! tu sei pazzo!
V. Sopraffazione
Il furto, intanto, non era possibile, almeno lì per lì. Non sapevo dove stessero quelle carte. L’ultimo dei subalterni di Quantorzo o di Firbo era in quella banca più padrone di me. Quando vi entravo, invitato per la firma, gl’impiegati non alzavano nemmeno gli occhi dai loro registri, e se qualcuno mi guardava, chiarissimamente con lo sguardo dimostrava di non tenermi in nessun conto.
Eppure lì lavoravano tutti con tanto zelo per me, per ribadire sempre più con quel loro assiduo lavoro il tristo concetto che in paese si aveva di me, ch’io fossi un usurajo. E a nessuno passava per il capo ch’io potessi di quel loro zelo, non che esser grato e disposto a compiacerli della mia lode, sentirmi offeso.
Ah che rigido e attediato squallore in quella banca! Tutti quei tramezzi vetrati che correvano lungo i tre stanzoni in fila, tramezzi di vetro diacciato, con cinque sportellini gialli in ciascuno, come gialla era la cornice e gialla l’intelajatura delle ampie lastre; e qua e là macchie d’inchiostro; qua e là qualche striscia di carta incollata sulla rottura d’una lastra; e il pavimento di vecchi mattoni di terracotta, strusciato in mezzo, lungo la fila dei tre stanzoni; strusciato davanti a ogni sportellino: triste corridojo, con quei vetri dei tramezzi di qua e i vetri delle due ampie finestre di là, per ogni stanzone, impolverati; e quelle filze di cifre nei muri, a penna, a lapis, sopra i tavolini sporchi d’inchiostro, tra una finestra e l’altra, sotto le cornici scrostate di certe telacce affumicate qua e là gonfie e polverose, appese lì; e un tanfo di vecchio da per tutto, misto con quello acre della carta dei registri e con quell’alido esalante da un forno giù a pianterreno. E la malinconia disperata di quelle poche seggiole d’antica foggia, presso i tavolini, su cui nessuno sedeva, che tutti scostavano e lasciavano lì, fuori di posto, dove e come per quelle povere seggiole inutili era certo un’offesa e una pena esser lasciate.
Tante volte, entrando, m’era venuto di far notare:
«Ma perché queste seggiole? Che condanna è la loro, di stare qua, se nessuno se ne serve?».
Me n’ero trattenuto, non già perché avessi avvertito a tempo che in un luogo come quello la pietà per le seggiole avrebbe fatto strabiliare tutti e rischiato fors’anche d’apparir cinica: me n’ero trattenuto, avvertendo invece che avrei fatto ridere di me per quel badare a una cosa che certamente sarebbe sembrata stravagante a chi sapeva quanto poco badassi agli affari.
Quel giorno, entrando, trovai i commessi affollati nell’ultimo stanzone, che si squaccheravano di tanto in tanto in risate assistendo a un diverbio tra Stefano Firbo e un certo Turolla, burlato da tutti anche per il modo con cui si vestiva.
Una giacca lunga, diceva quel povero Turolla, a lui così corto, lo avrebbe fatto sembrare più corto. E diceva bene. Ma non s’accorgeva intanto, così tracagnotto e serio serio, con quei mustacchioni da brigadiere, come gli stava ridicola di dietro la giacchettina accorciata, che gli scopriva le natiche sode.
Ora lì lì per piangere, avvilito, congestionato, frustato dalle risate dei colleghi, alzava un braccino e badava a dire a Firbo:
– Oh Dio, come le piglia lei le parole!
Firbo gli era sopra e gli gridava in faccia, scrollandolo furiosamente per quel braccio levato:
– Ma che conosci? che conosci? tu neanche l’o conosci; eppure ti somiglia!
Come venni a sapere che si trattava di un tale che aveva chiesto un prestito alla banca, presentato appunto dal Turolla che diceva di conoscerlo per un brav’uomo, mentre Firbo sosteneva il contrario, mi sentii stravolgere da un impeto di ribellione.
Ignorando la tortura segreta del mio spirito, nessuno potè intenderne la ragione, e tutti restarono quasi basiti quand’io, strappando indietro due o tre di quei commessi:
– E tu? – gridai a Firbo, – che conosci tu? con qual diritto vuoi importi così a un altro?
Firbo si voltò sbalordito a guardarmi e, quasi non credendo a se stesso nel vedermi così addosso, gridò:
– Sei pazzo?
Mi venne, non so come, di buttargli in faccia una risposta ingiuriosa, che agghiacciò tutti:
– Sì; come tua moglie, che ti conviene tener chiusa al manicomio!
Mi si parò davanti pallido e convulso:
– Com’hai detto? Mi conviene?
Diedi una spallata e seccato dello sgomento che teneva tutti e, nello stesso tempo, entro di me come improvvisamente assordito dalla coscienza dell’inopportunità di quella mia intromissione, gli risposi piano, per troncare:
– Ma sì, lo sai bene.
E non potei udire, come se dopo queste parole fossi diventato subito, non so, di pietra, ciò che Firbo mi gridò tra i denti prima di scappar via sulle furie. So che sorridevo mentre Quantorzo, sopravvenuto all’alterco, mi trascinava via con sé nella stanzetta della direzione. Sorridevo per dimostrare che di quella violenza non c’era più bisogno e che tutto era finito, quantunque sentissi bene in me, che in quel momento, pur mentre sorridevo, avrei potuto uccidere qualcuno, tanto la concitata severità di Quantorzo mi irritava. Nella stanzetta della direzione mi misi a guardare intorno, stupito io stesso che lo strano stordimento in cui ero così di colpo caduto non m’impedisse di percepire lucidamente e precisamente le cose, fin quasi ad avere la tentazione di riderne, uscendo apposta, tra quella fiera riprensione che Quantorzo mi dava, in qualche domanda di curiosità infantile su questo o quell’oggetto della stanza. E intanto, non so, quasi automaticamente pensavo che a Stefano Firbo, da piccolo, avevano dato i bottoni alla schiena e che sebbene la gobba non gli si vedesse, tutta la cassa del corpo era però da gobbo: eh sì, su quelle esili e lunghe zampe da uccello: ma elegante; sì sì: un falso gobbo elegante; ben riuscito.
E, così pensando, mi parve chiaro tutt’a un tratto ch’egli dovesse valersi della sua non comune intelligenza per vendicarsi contro tutti coloro che, da piccoli, non avevano avuto come lui i bottoni alla schiena.
Pensavo queste cose, ripeto, come se le pensasse un altro in me, quello che d’improvviso era diventato così stranamente freddo e svagato, non tanto per opporre a difesa, se occorresse, quella freddezza, quanto per rappresentare una parte, dietro la quale mi conveniva tenere ancora nascosto ciò che della spaventosa verità, che già mi s’era chiarita, m’avveniva sempre più di scoprire:
«Ma sì! è qui tutto», pensavo, «in questa sopraffazione. Ciascuno vuole imporre agli altri quel mondo che ha dentro, come se fosse fuori, e che tutti debbano vederlo a suo modo, e che gli altri non possano esservi se non come li vede lui».
Mi ritornavano davanti agli occhi le stupide facce di tutti quei commessi, e seguitavo a pensare:
«Ma sì! Ma sì! Che realtà può essere quella che la maggioranza degli uomini riesce a costituire in sé? Misera, labile, incerta. E i sopraffattori, ecco, ne approfittano! O piuttosto, s’illudono di poterne profittare, facendo subire o accettare quel senso e quel valore ch’essi dànno a se stessi, agli altri, alle cose, per modo che tutti vedano e sentano, pensino e parlino a modo loro».
Mi levai da sedere; m’avvicinai alla finestra con un gran refrigerio; poi mi voltai verso Quantorzo che, interrotto nel meglio del suo discorso, stava a guardarmi con tanto d’occhi; e, seguitando il pensiero che mi torturava, dissi:
– Ma che! ma che! s’illudono!
– Chi s’illude?
– Quelli che vogliono sopraffare! Il signor Firbo, per esempio! S’illudono perché in verità poi, caro mio, non riescono a imporre altro che parole. Parole, capisci? parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Eh, ma si formano pure così le così dette opinioni correnti! E guaj a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio: usurajo! Per esempio: pazzo! Ma di’ un po’: come si può star quieti a pensare che c’è uno che s’affanna a persuadere agli altri che tu sei come ti vede lui, e a fissarti nella stima degli altri secondo il giudizio che ha fatto di te e ad impedire che gli altri ti vedano e ti giudichino altrimenti?
Ebbi appena il tempo di notare lo sbalordimento di Quantorzo, che mi rividi davanti Stefano Firbo. Gli scorsi subito negli occhi che m’era diventato in pochi istanti nemico. E nemico subito anch’io, allora; nemico, perché non capiva che, se crude erano state le mie parole, il sentimento che poc’anzi aveva fatto impeto in me, non era contro di lui direttamente; tanto vero che di quelle parole ero pronto a chiedergli scusa. Già come ubriaco, feci di più. Com’egli, venendomi a petto, torbido e minaccioso, mi disse:
– Voglio che tu mi renda conto di ciò che hai detto per mia moglie!
M’inginocchiai.
– Ma sì! Guarda! – gli gridai, – così!
E toccai con la fronte il pavimento.
Ebbi subito orrore del mio atto, o meglio, ch’egli potesse credere con Quantorzo che mi fossi inginocchiato per lui. Li guardai ridendo, e tonfete, tonfete, ancora due volte a terra, la fronte.
– Tu, non io, capisci? davanti a tua moglie, capisci? dovresti star così! E io, e lui, e tutti quanti, davanti ai così detti pazzi, così!
Balzai in piedi, friggendo. I due si guardarono negli occhi, spaventati. L’uno domandò all’altro:
– Ma che dice?
– Parole nuove! – gridai. – Volete ascoltarle? Andate, andate là, dove li tenete chiusi: andate, andate a sentirli parlare! Li tenete chiusi perché così vi conviene!
Afferrai Firbo per il bavero della giacca e lo scrollai, ridendo:
– Capisci, Stefano? Non ce l’ho mica soltanto con te! Tu ti sei offeso. No, caro mio! Che diceva di te tua moglie? Che sei un libertino, un ladro, un falsario, un impostore, e che non fai altro che dire bugie! Non è vero. Nessuno può crederlo. Ma prima che tu la chiudessi, eh? stavamo tutti ad ascoltarla, spaventati. Vorrei sapere perché!
Firbo mi guardò appena, si voltò a Quantorzo come a chiedergli consiglio con scimunita angustia e disse:
– Oh bella! Ma appunto perché nessuno poteva crederlo!
– Ah no, caro! – gli gridai. – Guardami bene negli occhi!
– Che intendi dire?
– Guardami negli occhi! – gli ripetei. – Non dico che sia vero! Stai tranquillo.
Si sforzò a guardarmi, smorendo.
– Lo vedi? – gli gridai allora, – lo vedi? tu stesso! lo hai anche tu, ora, lo spavento negli òcchi!
– Ma perché mi stai sembrando pazzo! – mi urlò in faccia, esasperato.
Scoppiai a ridere, e risi a lungo, a lungo, senza potermi frenare, notando lapaura, lo scompiglio che quella mia risata cagionava a tutt’e due.
M’arrestai d’un tratto, spaventato a mia volta dagli occhi con cui mi guardavano. Quel che avevo fatto, quel che dicevo non aveva certo né ragione né senso per loro. Per ripigliarmi, dissi bruscamente:
– Alle corte. Ero venuto qua, oggi, per domandarvi conto d’un certo Marco di Dio. Vorrei sapere com’è che costui da anni non paga più la pigione, e ancora non gli si fanno gli atti per cacciarlo via.
Non m’aspettavo di vederli cascare, a questa domanda, in un più grande stupore. Si guardarono come per trovare ciascuno nella vista dell’altro un sostegno che li ajutasse a sorreggere l’impressione che ricevevano di me, o piuttosto, d’un essere sconosciuto che insospettatamente scoprivano in me all’improvviso.
– Ma che dici? che discorsi fai? – domandò Quantorzo.
– Non vi raccapezzate? Marco di Dio. Paga o non paga la pigione?
Seguitarono a guardarsi a bocca aperta. Scoppiai di nuovo a ridere; poi d’un tratto mi feci serio e dissi come a un altro che mi stésse di fronte, spuntato lì per lì davanti a loro:
– Quando mai tu ti sei occupato di codeste cose?
Più che mài stupiti, quasi atterriti, rivolsero gli occhi a cercare in me chi aveva proferito le parole ch’essi avevano pensato e che stavano per dirmi. Ma come! Le avevo dette io?
– Sì – seguitai, serio. – Tu sai bene che tuo padre lo lasciò lì per tanti anni senza molestarlo, questo Marco di Dio. Come t’è venuto in mente, adesso?
Posai una mano su la spalla di Quantorzo e con un’altr’aria, non meno seria, ma gravata d’un’angosciosa stanchezza, soggiunsi:
– T’avverto, caro mio, che non sono mio padre.
Poi mi voltai a Firbo e, posandogli l’altra mano su la spalla:
– Voglio che tu gli faccia subito gli atti. Lo sfratto immediato. Il padrone sono io, e comando io. Voglio poi l’elenco delle mie case con gl’incartamenti di ciascuna. Dove sono?
Parole chiare. Domande precise. Marco di Dio. Lo sfratto. L’elenco delle case. Gl’incartamenti. Ebbene, non mi capivano. Mi guardavano come due insensati. E dovetti ripetere più volte quel che volevo e farmi condurre allo scaffale dove si trovava l’incartamento di quella casa che bisognava al notaro Stampa. Quando fui nello stanzino ov’era quello scaffale, presi per le braccia Firbo e Quantorzo, che mi avevano condotto lì come due automi, e li misi fuori, richiudendo l’uscio alle loro spalle.
Sono sicuro che dietro quell’uscio rimasero ancora un pezzo a guardarsi negli occhi, istupiditi, e che poi uno disse all’altro:
– Dev’essersi impazzito!
VI. Il furto
Quello scaffale, appena fui solo, mi occupò subito, come un incubo. Proprio come viva per sé ne avvertii la presenza ingombrante, d’antico inviolato custode di tutti gli incartamenti di cui era gravido, così vecchio, pesante e tarlato.
Lo guardai, e subito mi guardai attorno, con gli occhi bassi.
La finestra; una vecchia seggiola impagliata; un tavolino ancora più vecchio, nudo, nero e coperto di polvere; non c’era altro lì dentro.
E la luce filtrava squallida dai vetri così intonacati di ruggine e polverosi, che lasciavano trasparire appena le sbarre dell’inferriata e i primi tegoli sanguigni d’un tetto, su cui la finestra guardava.
I tegoli di quel tetto, il legno verniciato di quelle imposte di finestra, quei vetri per quanto sudici: immobile calma delle cose inanimate.
E pensai all’improvviso che le mani di mio padre s’erano levate cariche d’anelli lì dentro a prendere gl’incartamenti dai palchetti di quello scaffale; e le vidi, come di cera, bianche, grasse, con tutti quegli anelli e i peli rossi sul dorso delle dita; e vidi gli occhi di lui, come di vetro, azzurri e maliziosi, intenti a cercare in quei fascicoli.
Allora, con raccapriccio, a cancellare lo spettro di quelle mani, emerse ai miei occhi e s’impose lì, solido, il volume del mio corpo vestito di nero; sentii il respiro affrettato di questo corpo entrato lì per rubare; e la vista delle mie mani che aprivano gli sportelli di quello scaffale mi diede un brivido alla schiena. Serrai i denti; mi scrollai; pensai con rabbia:
«Dove sarà, tra tanti incartamenti, quello che mi serve?».
E tanto per far subito qualche cosa, cominciai a tirar giù a bracciate i fascicoli e a buttarli sul tavolino. A un certo punto le braccia mi s’indolenzirono, e non seppi se dovessi piangerne o riderne. Non era uno scherzo quel rubare a me stesso?
Tornai a guardarmi intorno, perché improvvisamente non mi sentii più, là dentro, sicuro di me. Stavo per compiere un atto. Ma ero io? Mi riassalì l’idea che fossero entrati lì tutti gli estranei inseparabili da me, e che stéssi a commettere quel furto con mani non mie.
Me le guardai.
Sì: erano quelle che io mi conoscevo. Ma appartenevano forse soltanto a me?
Me le nascosi subito dietro la schiena; e poi, come se non bastasse, serrai gli occhi.
Mi sentii in quel bujo una volontà che si smarriva fuori d’ogni precisa consistenza; e n’ebbi un tale orrore, che fui per venir meno anche col corpo; protesi istintivamente una mano per sorreggermi al tavolino; sbarrai gli occhi:
– Ma sì! ma sì! – dissi. – Senza nessuna logica! senza nessuna logica! così!
E mi diedi a cercare tra quelle carte.
Quanto cercai? Non so. So che quella rabbia di nuovo cedette a un certo punto, e che una più disperata stanchezza mi vinse, ritrovandomi seduto sulla seggiola davanti a quel tavolino, tutto ormai ingombro di carte ammonticchiate, e con un’altra pila di carte io stesso qua sulle ginocchia, che mi schiacciava. Vi abbandonai la testa e desiderai, desiderai proprio di morire, se questa disperazione era entrata in me di non poter più lasciare di condurre a fine quell’impresa inaudita.
E ricordo che lì, con la testa appoggiata sulle carte, tenendo gli occhi chiusi forse a frenar le lagrime, udivo come da una infinita lontananza, nel vento che doveva essersi levato fuori, il lamentoso chioccolare d’una gallina che aveva fatto l’uovo, e che quel chioccolìo mi richiamò a una mia campagna, dove non ero più stato fin dall’infanzia; se non che, vicino, di tratto in tratto, m’irritava lo scricchiolìo dell’imposta della finestra urtata dal vento. Finché due picchi all’uscio, inattesi, non mi fecero sobbalzare. Gridai con furore:
– Non mi seccate!
E subito mi ridiedi a cercare accanitamente.
Quando alla fine trovai il fascicolo con tutti gl’incartamenti di quella casa, mi sentii come liberato; balzai in piedi esultante, ma subito dopo mi voltai a guardar l’uscio. Fu così rapido questo cangiamento dall’esultanza al sospetto, che mi vidi – e n’ebbi un brivido. Ladro! Rubavo. Rubavo veramente. Andavo a mettermi con le spalle contro quell’uscio; mi sbottonavo il panciotto; mi sbottonavo il petto della camicia e vi cacciavo dentro quel fascicolo ch’era abbastanza voluminoso.
Uno scarafaggio non ben sicuro sulle zampe sbucò in quel punto di sotto lo scaffale, diretto verso la finestra. Gli fui subito sopra col piede e lo schiacciai.
Col volto strizzato dallo schifo, rimisi alla rinfusa tutti gli altri incartamenti dentro lo scaffale, e uscii dallo stanzino.
Per fortuna Quantorzo, Firbo e tutti i commessi erano già andati via; c’era solo il vecchio custode, che non poteva sospettare di nulla.
Provai nondimeno il bisogno di dirgli qualche cosa:
– Pulite per terra là dentro: ho schiacciato uno scarafaggio.
E corsi in Via del Crocefisso, allo studio del notaro Stampa.
VII. Lo scoppio
Ho ancora negli orecchi lo scroscio dell’acqua che cade da una grondaja presso il fanale non ancora acceso, davanti alla catapecchia di Marco di Dio, nel vicolo già bujo prima del tramonto; e vedo lì ferma lungo i muri, per ripararsi dalla pioggia, la gente che assiste allo sfratto e altra gente che, sotto gli ombrelli, s’arresta per curiosità vedendo quella ressa e il mucchio delle misere suppellettili sgomberate a forza ed esposte alla pioggia lì davanti alla porta, tra le strida della signora Diamante che, di tratto in tratto, scarmigliata, viene anche alla finestra a scagliare certe sue strane imprecazioni accolte con fischi e altri rumori sguajati dai monellacci scalzi i quali, senza curarsi della pioggia, ballano attorno a quel mucchio di miseria, facendo schizzar l’acqua delle pozze addosso ai più curiosi, che ne bestemmiano. E i commenti:
– Più schifoso del padre!
– Sotto la pioggia, signori miei! Non ha voluto aspettare neanche domani!
– Accanirsi così contro un povero pazzo!
– Usurajo! usurajo!
Perché io sono lì, presente, apposta, allo sfratto, protetto da un delegato e da due guardie.
– Usurajo! usurajo!
E ne sorrido. Forse, sì, un po’ pallido. Ma pure con una voluttà che mi tiene sospese le viscere e mi solletica l’ugola e mi fa inghiottire. Solo che, di tanto in tanto, sento il bisogno d’attaccarmi con gli occhi a qualche cosa, e guardo quasi con indolenza smemorata l’architrave della porta di quella catapecchia, per isolarmi un po’ in quella vista, sicuro che a nessuno, in un momento come quello, potrebbe venire in mente d’alzar gli occhi per il piacere d’accertarsi che quello è un malinconico architrave, a cui non importa proprio nulla dei rumori della strada: grigio intonaco scrostato, con qualche sforacchiatura qua e là, che non prova come me il bisogno d’arrossire quasi per un’offesa al pudore per conto d’un vecchio orinale sgomberato con gli altri oggetti dalla catapecchia ed esposto lì alla vista di tutti, su un comodino, in mezzo alla via.
Ma per poco non mi costò caro questo piacere di alienarmi. Finito lo sgombero forzato, Marco di Dio, uscendo con sua moglie Diamante dalla catapecchia e scorgendomi nel vicolo tra il delegato e le due guardie, non potè tenersi, e mentre stavo a fissar quell’architrave, mi scagliò contro il suo vecchio mazzuolo di sbozzatore. M’avrebbe certo accoppato, se il delegato non fosse stato pronto a tirarmi a sé. Tra le grida e la confusione, le due guardie si lanciarono per trarre in arresto quello sciagurato messo in furore dalla mia vista; ma la folla cresciuta lo proteggeva e stava per rivoltarsi contro me, allorché un nero omiciattolo, malandato ma d’aspetto feroce, giovine di studio del notaro Stampa, montato su di un tavolino là tra il mucchio delle suppellettili sgomberate in mezzo al vicolo, quasi saltando e con furiosi gesticolamenti, si mise a urlare:
– Fermi! Fermi! State a sentire! Vengo a nome del notaro Stampa! State a sentire! Marco di Dio! Dov’è Marco di Dio? Vengo a nome del notaro Stampa ad avvertirlo che c’è una donazione per lui! Quest’usurajo Moscarda…
Ero, non saprei dir come, tutto un fremito, in attesa del miracolo: la mia trasfigurazione, da un istante all’altro, agli occhi di tutti. Ma all’improvviso quel mio fremito fu come tagliuzzato in mille parti e tutto il mio essere come scaraventato e disperso di qua e di là a un’esplosione di fischi acutissimi, misti a urla incomposte e a ingiurie di tutta quella folla al mio nome, non potendosi capire che la donazione l’avessi fatta io, dopo la feroce crudeltà dello sgombero forzato.
– Morte! Abbasso! – urlava la folla. – Usurajo! Usurajo!
Istintivamente, avevo alzato le braccia per far segno d’aspettare; ma mi vidi come in un atto d’implorazione e le riabbassai subito, mentre quel giovine di studio sul tavolino, sbracciandosi per imporre silenzio, seguitava a gridare:
– No! No! State a sentire! L’ha fatta lui, l’ha fatta lui, presso il notaro Stampa, la donazione! La donazione d’una casa a Marco di Dio!
Tutta la folla, allora, trasecolò. Ma io ero quasi lontano, disilluso, avvilito. Quel silenzio della folla, nondimeno, m’attrasse. Come quando s’appicca il fuoco a un mucchio di legna, che per un momento non si vede e non si ode nulla, e poi qua un tùtolo, là una stipa scattano, schizzano, e infine tutta la fascina crèpita lingueggiando di fiamme tra il fumo:
– Lui? – Una casa? – Come? – Che casa? – Silenzio! – Che dice? – Queste e altrettali domande cominciarono a scattar dalla folla, propagando rapidamente un vocìo sempre più fitto e confuso, mentre quel giovane di studio confermava:
– Sì, sì, una casa! la sua casa in Via dei Santi 15. E non basta! Anche la donazione di diecimila lire per l’impianto e gli attrezzi d’un laboratorio!
Non potei vedere quel che seguì; mi tolsi di goderne, perché mi premeva in quel momento di correre altrove. Ma seppi di lì a poco qual godimento avrei avuto, se fossi rimasto.
M’ero nascosto nell’àndito di quella casa in Via dei Santi, in attesa che Marco di Dio venisse a pigliarne possesso. Arrivava appena, in quell’àndito, il lume della scala. Quando, seguito ancora da tutta la folla, egli aprì la porta di strada con la chiave consegnatagli dal notaro, e mi scorse lì addossato al muro come uno spettro, per un attimo si scontraffece, arretrando; mi lanciò con gli occhi atroci uno sguardo, che non dimenticherò mai più; poi, con un arrangolìo da bestia, che pareva fatto insieme di singhiozzi e di risa, mi saltò addosso, frenetico, e prese a gridarmi, non so se per esaltarmi o per uccidermi, sbattendomi contro al muro:
– Pazzo! Pazzo! Pazzo!
Era lo stesso grido di tutta la folla lì davanti la porta:
– Pazzo! Pazzo! Pazzo!
Perché avevo voluto dimostrare, che potevo, anche per gli altri, non essere quello che mi si credeva.
««« Libro Terzo Libro Quinto »»»
| Uno, nessuno e centomila – Indice
Introduzione |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com

