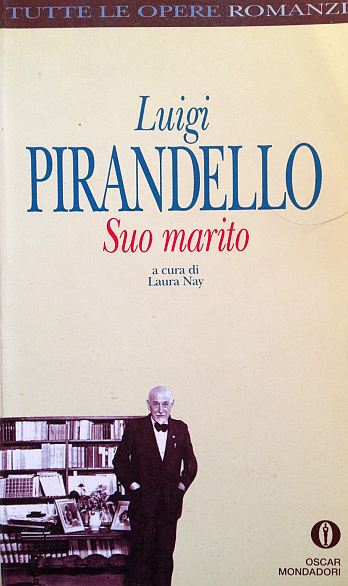««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «Suo marito» su Amazon
VII. Lume spento
1.
– E ’l giudisi? douva t’ l’as ’l giudisi, martuf?
Il bimbo, a cavalcioni su le gambe di nonno Prever, lo guardava con gli occhioni intenti e ridenti, frenandosi; poi subito alzava una manina e con l’indice teso si toccava la fronte.
– Bel e sì.
– L’è nen vera! – gli gridava allora il vecchione, afferrandogli con le grosse mani e fingendo di volergli strappar la pancina: – T’l’as anvece sì, sì, sì…
E il bimbo, a questo scherzo tante volte ripetuto, si buttava via dalle risa.
La nonna, allo scatto di quelle fresche ingenue risa infantili, si voltava a guardare la riccioluta testina rovesciata del nipotino. Non rideva troppo? E c’era una maledetta mosca che ronzava, così urtante, malaugurosa, nella camera. La cercava nel vano; quindi tornava con occhi dolenti a rimirare il figliuolo che se ne stava presso la finestra a guardar fuori, col capo insaccato ne le spalle e le mani in tasca, taciturno e scuro.
Già da circa nove mesi le era ritornato da Roma, così, quasi ignudo, con quegli abiti che aveva indosso e la poca biancheria. Ma avesse perduto soltanto la roba e l’impiego! Il cuore, il cervello, la vita, tutto, tutto aveva perduto, dietro a quella donna là, che per forza doveva esser cattiva.
Sessanta e più anni aveva ella vissuto, la signora Velia, e non aveva mai veduto alcun uomo ridursi in quello stato per una donna onesta e buona.
Dio, non più neanche un filo d’amore per quel piccino, per lei! Eccolo là: non voleva pensare più a niente; guardava e pareva non vedesse e non udisse, alienato da ogni senso, vuoto, distrutto, spento.
Solo per qualche traccia rimasta del soggiorno di colei nella casa accennava di rianimarsi un po’, e come un cane che si sdraj su le vestigia del padrone morto, quasi a covarne l’ultimo sentore, che non se ne vada via anche quello, stava lì e non c’era verso di mandarlo fuori a distrarsi.
Già più volte il Prever gli aveva proposto di andare con la Graziella, per qualche mese, per una settimana, per un giorno almeno, a la villa sul colle di Bràida; e poi, che lo ajutasse un po’ – essendo egli ormai vecchio – nell’amministrazione dei beni. A quest’ultima proposta, s’era un po’ scosso, ma come per il peso di un obbligo, col quale gli si volesse rendere crudelmente più grave l’infelicità. Tanto che il Prever, subito, lo aveva esonerato, non ostante che don Buti, il curato, sostenesse che bisognava persistere, anche lasciandogli credere che gli si facesse quel carico per obbligo e con crudeltà.
– Meisiña, – diceva – avei nen paura eh’a la treuva amera.
Medicina il signor Prever non voleva essere; o, se mai, dolce; così amara, no.
– Grazious! – diceva a madama Velia, appena don Buti se n’andava. – Chiel a ven con so canucial për Meisiña, e mi i dovria venì sì con i me count ’d cassa…
Don Buti infatti, visto che Giustino non s’era voluto arrendere a fargli una visitina lì nella canonica a due passi, una sera aveva portato con sé sotto il tabarro il suo vecchio famoso cannocchiale per fargli ammirare la gran potensa ’d Nosgnour come quand’era piccolino e per tener chiuso l’occhio manco faceva tante smorfie con la bocca:
– Ratoujin, così!
Ma Giustino non s’era commosso alla vista del vecchio cannocchiale; per non far dispiacere al brav’uomo aveva guardato con esso «le gran montagne» della Luna e aveva scosso appena appena il capo, con gli occhi aggrondati, quando don Buti aveva ripetuto col solito gesto il solito ritornello:
– La gran potensa ’d Nosgnour, eh? la gran potensa ’d Nosgnour!
Al ritornello era seguito un lungo predicozzo pieno di oh! e di eh! perché daquel tentennar del capo con gli occhi aggrondati la gran potenza di Dio era parsa a don Buti, se non propriamente messa in dubbio, riconosciuta però anche capace di permettere che si facesse tanto male a un povero innocente. Ma al predicozzo Giustino era rimasto impassibile, come per una cosa che don Buti, nella sua qualità di sacerdote, dovesse fare, e nella quale lui non avesse nulla da vedere, fuori com’era di quel dovere sacerdotale e padrone di pensarla a suo modo, come stava scritto sul campanile della chiesa.
Da quel cupo torpore di spirito lo aveva un po’ scosso, invece, il nuovo medico condotto, venuto da poco a Cargiore con una signora che non si sapeva ancor bene se gli fosse moglie oppur no. Doveva esser ricca madama, perché il dottor Lais aveva preso in affitto un bel villinetto di certi signori di Torino e diceva di volerlo comperare. Alto, asciutto, rigido e preciso come un inglese, coi baffetti ancora biondi e i capelli già canuti, fitti, corti corti, si dava l’aria di esercitar la professione tanto per fare qualche cosa; vestiva con ricca e semplice eleganza e portava sempre un pajo di splendidi gambali di cuojo, di cui pareva ogni volta si dimenticasse apposta a casa d’affibbiar qualche stringa, per affibbiarsela fuori, per istrada o nelle visite, e richiamar così su essi l’attenzione. Si dilettava molto di letteratura, il dottor Lais. Chiamato per un lieve disturbo del bimbo e saputo che il Boggiolo era marito della celebre scrittrice Silvia Roncella e per tanti anni era stato in mezzo alla letteratura, lo aveva assediato di domande e invitato al suo villino, ove la sua signora avrebbe avuto certamente tanto piacere di sentirlo parlare, amante appassionata com’era anch’ella de le belle lettere e insaziabile divoratrice di libri.
– Se lei non viene, badi! – gli aveva detto. – Son capace di portarla io qua, la mia signora.
E l’aveva portata, difatti. E tutti e due, egli che pareva un inglese, ella che pareva una spagnuola (era venezianina), tutta fiocchi e nastri, tutta cascante di vezzi, bruna, con due occhietti vivaci neri neri e due labbra carnute rosse rosse, il nasino ritto fiero e impertinente, avevano fatto parlar Giustino per una intera serata, ammirati da un canto, dall’altro irritati da certe notizie, da certi giudizii contrarii alle loro sviscerate simpatie di dilettanti ammiratori di provincia. – Me schiopa elfiel! – protestava lei. – Ma come? la Morlacchi… Flavia Morlacchi!… nessuno davvero la calcolava a Roma? Ma il suo romanzo La vittima… tanto bello!… Ma Fiocchi di neve… versi meravigliosi!… E il dramma… com’era intitolato?… Discordia, già già, no,La Discordia… perdio, applauditissimo a Como, quattr’anni fa!
Il signor Martino e don Buti stavano a sentire e a guardare con occhi spalancati, a bocca aperta, e la signora Velia mirava costernata il suo Giustino che, pur senza volerlo, tirato da quei due, ecco ricascava a parlar di quelle cose e si riscaldava, si riscaldava… Oh Dio, no: preferiva vederlo scuro, taciturno, sprofondato nel cordoglio, la signora Velia, anziché rianimato così, per quei discorsi. Via, via, quella tentazione! E si sentì più tranquilla quando, alcuni giorni dopo, a quei due che ebbero la sfrontatezza di mandargli a chiedere per la servetta un certo libro della moglie é d’invitarlo a colazione, Giustino rispose che non aveva il libro e che non poteva andare.
Se li era levati, così, d’attorno.
«Che avrà intanto, quest’oggi?», pensava la piccola signora Velia, seguitando a mirare il figliuolo innanzi alla vetrata della finestra, mentre Vittorino faceva il diavoletto su le ginocchia del Prever.
Forse quel giorno era più raffagottato del solito perché la mattina – per una disattenzione di quella stolida di Graziella – aveva scoperto una lettera arrivata parecchi giorni addietro e non distrutta come tutte le altre, quando si poteva, di nascosto a lui.
Tante e tante lettere gli arrivavano ancora, respinte da Roma, anche dalla Francia, anche dalla Germania… E la signora Velia, all’arrivo di esse, tentennava il capo, come se dalla distanza da cui arrivavano misurasse l’estensione del male che colei aveva fatto al suo figliuolo. .
Egli si buttava su quelle lettere come un affamato; andava a chiudersi in camera e si metteva a rispondere. Ma non rimandava poi quelle lettere con la risposta direttamente alla moglie. Per mezzo del signor Martino la signora Velia aveva saputo da monsù Gariola, il quale aveva in appalto l’ufficio postale, che il figliuolo le indirizzava a un tal Raceni, a Roma. Forse per il tramite di questo amico consigliava alla moglie come avrebbe dovuto regolarsi.
Era veramente così.
Dalla Barmis e dal Raceni, dopo il suo ritorno a Cargiore, Giustino aveva ricevuto fino a pochi mesi addietro frequenti lettere, dalle quali con strazio indicibile aveva saputo in quale disordine vivesse a Roma la moglie.
Ora egli era più che mai convinto che tra Silvia e il Gueli non fosse avvenuto nulla di male; e credeva d’averne la prova nel fatto che il Gueli, quasi miracolosamente guarito dalle due ferite, sebbene col braccio destro amputato, era ritornato a vivere con la Frezzi, liberata come incosciente dopo circa cinque mesi di carcere preventivo, appunto per le aderenze e le brighe del Gueli stesso.
Ah, se egli allora, nel primo momento, non si fosse lasciato sopraffare dallo scandalo e fosse corso a Ostia a rilevar la moglie ancora senz’altra colpa che quella d’aver voluto fuggire da lui! No, no, no: egli non doveva credere, non ostante quell’inganno della gita a Orvieto, non doveva credere che ella si fosse potuta mettere col Gueli. Avrebbe dovuto correre a Ostia e ricondurre con sé la moglie, la quale certamente, allora, non si sarebbe così perduta… Con chi viveva ella ora? La Barmis diceva col Baldani; il Raceni invece sospettava una relazione col Luna. Viveva sola, in apparenza. Il villino, tutti i mobili, venduti. E nelle ultime lettere il Raceni lasciava intendere che ella dovesse trovarsi in qualche imbarazzo finanziario. Ma sfido! Senza di lui… Chi sa come la rubavano tutti! Forse ella ora riconosceva che cosa volesse dire avere accanto un uomo come lui! Tutto venduto… Peccato!… Quel villino… quei mobili del Ducrot…
Da circa due mesi né la Barmis né il Raceni gli scrivevano più, né alcun altro amico da Roma. Che era accaduto? Forse non avevano veduto più la ragione di seguitare ancora la corrispondenza con uno ormai quasi sparito dalla vita. S’era prima stancata la Barmis, ora non rispondeva più neanche il Raceni.
Ma quel giorno egli non era né per questo silenzio né per la ragione supposta dalla madre più fosco del solito.
In casa, dacché era ritornato, non entravano più giornali per la promessa da lui fatta alla madre di non leggerne più. S’era poi pentito, e come! di questa promessa; ma non aveva osato manifestare il desiderio di leggere almeno quelli di Torino per timore che la madre non lo credesse ancor fisso col pensiero a quella donna. Finché la Barmis e il Raceni gli scrivevano, non aveva sofferto tanto di quella privazione; ma ora…
Ebbene, quella mattina, in un giornale vecchio d’una ventina di giorni, nel quale Graziella gli aveva portati avvolti in camera i colletti e i polsini stirati, aveva letto due notizie sotto la rubrica dei teatri, che lo avevano tutto sconvolto.
Una era di Roma: l’imminente rappresentazione al teatro Argentina del nuovo dramma della moglie, quello, quello stesso ch’egli aveva lasciato incompiuto, Se non così… L’altra, che a Torino, all’Alfieri, recitava la Compagnia Carmi-Revelli.
Divorato dalla brama di saper l’esito di quel nuovo dramma a Roma e forse in altre città, fors’anche a Torino, se c’era la Compagnia Carmi-Revelli; e di parlarne o con la signora Laura o col Grimi, con qualcuno insomma; non sapeva come dire alla madre che la mattina appresso desiderava di scendere a Torino. Temeva che il signor Prever lo volesse accompagnare. Sapeva in quale costernazione viveva la madre per lui. A dirle che voleva andar solo così lontano, all’improvviso, quando s’era rifiutato fino al giorno addietro anche di far due passi fuor di casa, chi sa che pensieri ella avrebbe fatto… E poi, non aveva più che pochi soldi con sé, residuo dello stretto costo del viaggio prelevato dai denari recati da Parigi; si vergognava a dirlo quasi a sé stesso, figuriamoci poi a chiederne per quella ragione alla madre, la quale non aveva altro che quel po’ di pensioncina lasciatale dal marito, e ora, con addosso anche il peso di lui, stentava più che mai a tirare avanti, poveretta. Il signor Prever, sì, porgeva qualche soccorso di tanto in tanto, sottomano, or con una scusa, or con un’altra. Ma se in quel momento la madre era agli sgoccioli e doveva chiedere ajuto al signor Martino, ecco che questi avrebbe saputo e certamente si sarebbe profferta d’accompagnarlo. Aspettò che il Prever, dopo cena, se n’andasse al suo villino e, per provocare un nuovo e più pressante invito della madre a procacciarsi qualche distrazione, si lamentò d’una enorme gravezza al capo. Sollecito, come s’aspettava, venne l’invito:
– Va’ a Bràida, domani…
– No, piuttosto vorrei… vorrei veder gente, ecco. Questa solitudine, forse, mi fa male…
– Vuoi andare a Torino?
– Ecco, piuttosto…
– Ma sì, subito, domani stesso! – s’affrettò a dire la madre. – Mando Graziella a fissarti un posto in vettura da monsù Gariola.
– No no, – disse Giustino. – Lascia. Scendo a piedi fino a Giaveno.
– Ma perché?
– Perché… Lascia! Mi farà bene camminare… sto in casa da tanto tempo. Piuttosto… per il tram a vapore da Giaveno… mamma, io…
La signora Velia capì a volo, e subito alzò una mano verso la fronte e chiuse gli occhi, come per dire: «Non ci pensare!».
Quando entrò nella sua camera, accompagnato dalla mamma che gli faceva lume, s’accorse che questa sul piano del cassettone aveva posato tre carte da dieci lire.
– Oh, no! – esclamò. – Che vuoi che me ne faccia di tante? Prendi, prendi… Basterà una!
La vecchia mamma si scostò parando le mani, e con un sorriso a un tempo mesto e maliziosetto su le labbra e negli occhi:
– Ma credi davvero, – gli disse, – che la tua vita sia finita, figliuolo mio?… Tu sei ancor quasi ragazzo… Va’! va’!
E richiuse l’uscio.
2.
Sceso dalla tramvia a vapore, la prima impressione che provò nel rimetter piede in città dopo nove mesi d’oscuro e profondo silenzio interiore, di seppellimento nel cordoglio, fu quella di non saper più camminare tra il rumore e la confusione. N’ebbe subito un intronamento quasi di greve e cupa ubriachezza, quell’irritazione, quell’uggia, quell’astio che prova un malato costretto a muoversi col ronzo della medicina negli orecchi in mezzo a sani àlacri e indifferenti.
Volgeva di qua, di là rapide occhiate oblique, per timore che qualcuno dei conoscenti antichi, non letterati, lo riconoscesse, e per un altro timore opposto, che fingesse cioè di non riconoscerlo qualcuno dei conoscenti nuovi, giornalisti e letterati. Assai più crudele della commiserazione derisoria di quelli gli sarebbe stata la noncuranza sdegnosa di questi, ora che egli non era più neanche l’ombra di quel che era stato.
Ah, se un giornalista amico, passando, gli avesse introdotto un braccio sotto il braccio, festosamente, come a’ bei tempi, e gli avesse detto:
«Oh, caro Boggiolo, ebbene, che notizie?».
E gli avesse fatto raccontare il trionfo di Parigi, che non aveva potuto raccontare a nessuno e gli era rimasto in gola, nodo d’angoscia che non si sarebbe sciolto mai più!
«E la vostra signora? A che lavori attendiamo? Un nuovo dramma, eh? Su, ditemi qualche cosa…»
Non sapeva neppure se fosse stato rappresentato il nuovo dramma, lui, e che esito avesse avuto…
Andò a un’edicola e comperò i giornali di Roma, di Milano e quelli cittadini.
Non se ne parlava.
Ma negli annunzii degli spettacoli nei giornali di Roma, ecco, al teatro Argentina: Se non così…
Ah, dunque, era stato rappresentato! Dunque aveva avuto un buon successo! Se si replicava… Chi sa da quante sere? Buon successo…
E si diede a immaginare che, questa volta, doveva essere andata lei, Silvia, a metterlo in iscena. Vide subito col pensiero il palcoscenico, di giorno, durante le prove; s’immaginò l’impressione che aveva dovuto provarne Silvia che non vi era mai stata e si vide lì con lei, sua guida, tra i comici; ella incerta, smarrita; lui invece ormai pratico, sicuro; ed ecco le dimostrava tutta la sua sicurezza, la padronanza che aveva del luogo e d’ogni cosa, e la esortava a non disperarsi della svogliatezza e della cascaggine di quelli, dei tagli che si facevano al copione, delle sfuriate del direttore capo-comico… Eh, non era mica facile combattere con quei tipi! Bisognava prenderli per il loro verso e aver pazienza se fino all’ultimo mostravano di non saper la parte…
A un tratto, s’infoscò in volto. Pensò che forse ella si era fatta ajutare, accompagnare a quelle prove da qualcuno, forse dal Baldani, forse dal Luna o dal Betti… Chi era in quel momento il suo amante? E a questo pensiero, diventò subito una cosa facilissima mettere in iscena quel dramma, assistere alle prove, combattere con gli attori. Ma sì, certo, bella forza, ora che ella, mercé lui, s’era fatto tanto nome e tutte le porte le erano aperte e tutti gli attori pendevano dalle labbra di lei, tra ossequii e sorrisi; bella forza!
«Ai conti però ti voglio! ai conti! ai conti!», esclamò tra sé.
«Ossequii, sorrisi… sfido! una donna… e poi, ora., senza marito… Ma ai conti, chi ci bada? Ci baderà lei? Con la bella pratica che ne ha! Ci baderà lui, il bello… Se la mangeranno viva! Sì sì, va’ che potrai arrivare a rifarti un villino adesso, come quello! Aspetta, aspetta…»
Aprì un giornale di Torino e vide che al teatro Alfieri la Compagnia Carmi-Revelli era alle ultime recite.
Rimase un pezzo col giornale aperto innanzi agli occhi, perplesso se andare o no. La brama di saper notizie del dramma, di parlar di lei, di sentirne parlare, lo spingeva; lo tratteneva il pensiero d’affrontar la vista, le domande di tutti quegli attori. Come lo avrebbero accolto? Si burlavano di lui un tempo; ma egli allora aveva il cappio in mano, con cui, dopo aver permesso che essi braveggiassero un pezzo come tanti cavallini scapati attorno a lui, poteva in un momento dare una stratta e legarli addomesticati al carro del trionfo. Ora, invece…
Si mosse, immerso nei ricordi eh’erano ormai tutta la sua vita, e dopo un lungo giro si ritrovò, guidato inconsciamente da essi, innanzi al teatro Alfieri.
Forse a quell’ora c’era prova. S’appressò titubante all’entrata e finse di leggere nel manifesto il titolo del dramma che si rappresentava quella sera, poi l’elenco dei personaggi; alla fine, facendosi animo, come un autor novellino chiese rispettosamente a uno lì di guardia, che non conosceva, se la signora Carmi era in teatro.
– Non ancora, – gli rispose quello.
E Giustino rimase innanzi al manifesto senz’ardire di chieder altro. In altri tempi sarebbe entrato da padrone nel teatro, senza neppur degnare d’uno sguardo quel cerbero là!
– E il cavalier Revelli? – chiese dopo un pezzo.
– entrato or ora.
– C’è prova, è vero?
– Prova, prova…
Sapeva che il Revelli era rigorosissimo nel concedere l’entrata a estranei durante la prova. Certo, se avesse porto a quell’uomo un biglietto da visita da presentare al Revelli, questi lo avrebbe fatto entrare; ma si sarebbe allora trovato esposto alla curiosità indiscreta e irriverente di tutti. Non volle. Meglio rimaner lì come un mendico ad attendere la Carmi, che non poteva tardar molto, se gli altri erano già venuti.
Difatti, la Carmi arrivò poco dopo, in carrozza. Non s’aspettava di trovar lui lì innanzi alla porta e, nel vedersi salutata, chinò appena il capo e passò oltre, senza riconoscerlo.
– Signora… – chiamò allora Giustino, trafitto.
La Carmi si volse, strizzando un po’ gli occhi miopi, e subito allungo il viso in un oooh di meraviglia.
– Voi, Boggiolo? E come mai qui? come mai?
– Eh… – fece Giustino, aprendo appena appena le braccia.
– Ho saputo, ho saputo, – riprese la Carmi con ansia pietosa. – Povero amico mio! Che azionaccia vile! Non me la sarei mai aspettata, credete. Non per lei, badiamo! Ah, ne so qualche cosa io, dell’ingratitudine di quella donna! Ma per voi, caro. Su, su, venite con me. Sono in ritardo!
Giustino esitò, poi disse con voce tremante e gli occhi invetrati di lagrime:
– La prego, signora, non… non vorrei farmi vedere…
– Avete ragione – riconobbe la Carmi. – Aspettate; prendiamo di qua.
Entrarono nel teatro quasi bujo; attraversarono il corridojo del primo ordine dei palchi; là in fondo la Carmi aprì l’usciolino dell’ultimo palco e disse al Boggiolo, sotto voce:
– Ecco, aspettatemi qua. Vado su in palcoscenico e ritorno subito.
Giustino si rannicchiò in fondo al palco, nel bujo, con le spalle a la parete attigua al palcoscenico, per non farsi scorgere dagli attori, di cui rimbombavano le voci nel teatro vuoto.
– Oh signora, oh signora, – baritoneggiava al solito suo il Grimi, coprendo la voce fastidiosa del suggeritore, – e vi par troppa grazia codesta?
– Ma no, nessuna grazia, caro signore, – sorrideva la piccola Grassi con la sua vocetta tenera.
E il Revelli gridava:
– Più strascicato! più strascicato! Ma nooo, ma nessuna grazia, amico…
– Il secondo ma non c’è!
– E lei ce lo metta, oh perdio! È naturale!
Giustino stava a udire quelle voci note che, pur senza volere, si alteravano nel dar vita al personaggio della scena; guardava l’ampia vacuità sonora del teatro in ombra; ne aspirava quel particolare odor misto d’umido, di polvere e di fiati umani ristagnati, e si sentiva a mano a mano crescer l’angoscia, come se lo assaltasse alla gola il ricordo preciso d’una vita che non poteva più esser sua, a cui non poteva accostarsi più, se non così, nascosto, quasi di furto, o commiserato come dianzi. La Carmi aveva riconosciuto, e tutti con lei, certo, avrebbero riconosciuto ch’egli non meritava d’esser trattato a quel modo; e questa pietà degli altri, se da un canto gli faceva sentire più profonda e più amara la sua miseria, gliela rendeva dall’altro più cara, perché era quasi l’ombra superstite di ciò che egli era stato.
Aspettò un bel pezzo la Carmi, che doveva provare una lunga scena col Revelli. Quando alla fine ella venne, lo trovò che piangeva, seduto, coi gomiti su le ginocchia e la faccia tra le mani. In silenzio piangeva, ma con calde lagrime abbondanti e sussulti di singhiozzi raffrenati.
– Su, su, – gli disse, posandogli una mano su la spalla. – Capisco, sì, povero amico; ma via, su! Così non mi sembrate più voi, caro Boggiolo! Lo so, consacrato tutto, anima e corpo a quella donna; ora…
– La rovina, capisce? – proruppe, soffocando la voce e le lagrime, Giustino,la rovina, la rovina di tutto un edificio, signora, messo su da me, a pietra a pietra! da me, da me soltanto! Sul più bello, quando già tutto era a posto, e mi toccava di goder la soddisfazione di quanto avevo fatto, una ventata a tradimento, una ventata di pazzia, creda, di pazzia, con quel vecchio là, con quel vecchio pazzo, che si è prestato vilmente, forse per vendicarsi, distruggendo un’altra vita com’era stata distrutta la sua; giù tutto, giù tutto, giù tutto!
– Piano, sì, piano, calmatevi! – lo esortava anche col gesto la Carmi.
– Mi lasci sfogare, per carità! Non parlo e non piango da nove mesi! Mi hanno distrutto, signora mia! Io non sono più niente, ora! Mi ero messo tutto in quell’opera che potevo fare io solo, io solo, lo dico con orgoglio, signora mia, io solo perché non badavo a tutte le sciocchezze, a tutte le fisime, a tutti i grilli che saltano in mente a questi letterati; non mi scaldavo mai la testa, io, e li lasciavo ridere, se volevano ridere; ha riso anche Lei di me, è vero? tutti hanno riso di me; ma che me n’importava? io dovevo edificare! E c’ero riuscito! E ora… e ora, capisce?
Mentre il Boggiolo qua, nel bujo del palchetto, parlava e piangeva così, strozzato dall’angoscia, seguitava di là, sul palcoscenico, la prova. La Carmi notò a un tratto, con un brivido, la strana contemporaneità di quei due drammi, uno vero, qua, d’un uomo che si struggeva in lagrime, con le spalle addossate alla parete verso il palcoscenico, donde sonavan false le voci dell’altro dramma finto, che al paragone immediato stancava e nauseava come un vano petulante irriverente giuoco. Ebbe la tentazione di sporgersi dal palchetto e di far cenno agli attori che smettessero e venissero qui, qui, a vedere, ad assistere a quest’altro dramma vero. S’accostò invece al Boggiolo e di nuovo lo pregò di calmarsi con buone parole e battendogli ancora la mano su la spalla.
– Sì, sì, grazie, signora… mi calmo, mi calmo, – disse Giustino, tranghiottendo le lagrime e asciugandosi gli occhi. – Mi perdoni, signora. Avevo bisogno, proprio bisogno di questo sfogo. Mi perdoni. Ecco, ora sono calmo. Dica un po’, questo dramma… questo dramma nuovo, Se non così… è andato eh?… com’è andato?
– Ah, non me ne parlate! – protestò la Carmi. – È la stessa azione, caro, la stessa azionaccia che ha fatto a voi! Non me ne parlate, lasciamo andare…
– Volevo saper l’esito… – insistè, con timidezza, Giustino, avvilito della sua stessa pena.
– Silvia Roncella, amico mio, è l’ingratitudine fatta persona! – sentenziò allora la Carmi. – Chi la portò al trionfo? Ditelo voi, Boggiolo! Non credetti io sola, io sola, mentre tutti ridevano o dubitavano, nella potenza del suo ingegno e del suo lavoro? Ebbene, ecco qua: ha pensato a tutte le altre, tranne che a me, per il nuovo dramma! Badate, questo lo dico a voi, perché so ciò che anche voi ne avete ricevuto. Agli altri – ah, perbacco, io tengo alla mia dignità agli altri dico che sono stata io a non volerne sapere. E non recito più neanche La nuova colonia, adesso. Per grazia di Dio, la gente viene a teatro per me, a sentir me, qualunque cosa io faccia: non ho bisogno di lei! Ne parlo soltanto perché l’ingratitudine, si sa, fa sdegno a tutti, e voi potete comprendermi.
Giustino rimase un pezzo in silenzio a tentennare il capo; poi disse:
– Tutti, sa? tutti gli amici che m’ajutarono, furono trattati così da lei… Ricordo la Barmis, anch’essa… Dunque, questo nuovo dramma… così… com’è andato?
– Mah! – fece la Carmi. – Pare che… niente di straordinario… Quel che si dice un successo di stima. Qualche scena, qua e là, pare che sia buona… il finale dell’ultimo atto, specialmente, sì, quello… quello ha salvato il lavoro… Non avete letto i giornali?
– Nossignora. Da nove mesi. Sono stato chiuso in casa… Scendo ora per la prima volta a Torino. Io sto qua, sopra Giaveno, nel mio paesello, con mia madre e il mio bambino…
– Ah, ve lo siete tenuto con voi, il figliuolo?
– Certo! Con me… È stato sempre qua, veramente, con mia madre.
– Bravo, bravo, – approvò la Carmi. – E così, voi non ne avete più notizia dunque?
– No, nessuna più. Per caso ho saputo che il nuovo dramma è stato rappresentato. Ho comperato i giornali, oggi, e ho visto che a Roma si replica…
– Anche a Milano, per questo… – disse la Carmi.
– Ah, si è dato anche a Milano?
– Sì sì, con lo stesso successo.
– Al Manzoni?
– Al Manzoni, già. E tra poco… aspettate, fra tre giorni, da Milano verrà la Compagnia Fresi a metterlo in iscena qua, in questo teatro. E lei, la Roncella, è a Milano adesso, e verrà qua ad assistere alla rappresentazione.
Giustino alla notizia balzò in piedi, anelante.
– Lo sa sicuro?
– Ma sì, mi par d’avere inteso così… Che?… Vi fa… vi fa un certo effetto, eh? Capisco…
La Carmi s’era alzata anche lei e lo guardava pietosamente.
– Verrà?
– Dicono! E io lo credo. La sua presenza, dopo tanto chiasso che si è fatto attorno a lei, può giovar molto, essendo il dramma anche un po’ scadente. Il pubblico poi non la conosce ancora e vuol conoscerla.
– Già già… – disse Giustino, smanioso. – È naturale… questo è come il primo lavoro per lei… Forse gliel’avranno anche imposto… Verrà fra tre giorni la Compagnia Fresi?
– Sì, fra tre giorni. C’è giù nell’atrio il cartello, non l’avete veduto?
Giustino non potè più stare alle mosse; ringraziò la Carmi dell’affettuosa accoglienza e andò via, sentendosi già soffocare in quell’ombra fitta del teatro, tutto stravolto com’era dalla tremenda notizia che quella gli aveva dato.
Silvia, a Torino! La avrebbero chiamata fuori, lì, a teatro, ed egli la avrebbe riveduta!
Si sentì mancare le gambe uscendo all’aperto; ebbe come una vertigine e si portò le mani al volto. Tutto il sangue gli era balzato alla testa e il cuore gli martellava in petto. La avrebbe riveduta! Ah, chi sa come s’era fatta, adesso, in quel disordine di vita, sbattuta da quella tempesta! Chi sa com’era cangiata! Forse non sussisteva più nulla in lei di quella Silvia ch’egli aveva conosciuta!
Ma no: forse non sarebbe venuta, sapendo che lui poteva scendere da Cargiore a Torino, e… E se veniva appunto per questo? per riaccostarsi a lui? Oh Dio, oh Dio… E come poteva più perdonarla, lui, dopo tanto scandalo? come riprendere a vivere con lei, ora? No, no… Egli non aveva più alcuno stato; si sarebbe coperto di vergogna; tutti avrebbero creduto ch’egli si riuniva con lei per viver di lei, su lei, ancora, turpemente. No, no! Non era più possibile, ormai… Ella doveva intenderlo. Ma non le aveva lasciato tutto, partendo? Anche gli altri da questo suo atto avevano potuto argomentare ch’egli non era un vile sfruttatore. Aveva dato a tutti la prova che non era capace di vivere con vergogna, lui, d’un denaro ch’era pur suo in gran parte, frutto del suo lavoro, sangue suo; e glielo aveva lasciato! Chi poteva accusarlo?
Questa protesta di fierezza, in cui s’indugiava con crescente soddisfazione, era la scusa con cui, tergiversando, la sua coscienza accoglieva la segreta speranza che Silvia venisse a Torino per farsi riprendere da lui.
Ma se ella veniva, invece, perché non poteva farne a meno, per impegno contratto con la Compagnia Fresi? E forse… chi sa?… non era sola; forse qualcuno la accompagnava, la sosteneva in quel viaggio penoso…
No, no: egli non poteva, non doveva far nulla. Solo, a ogni costo, voleva ritornare a Torino fra poche sere per assistere, di nascosto, alla rappresentazione del dramma, per rivederla da lontano un’ultima volta…
3.
Di nascosto! da lontano!
Un fiume di gente, in quella dolcissima sera di maggio, entrava nel teatro illuminato a festa, le vetture accorrevano rombanti e facevan ressa lì innanzi alle porte, fra il contrasto delle luci, il brusìo de la folla agitata.
Di nascosto, da lontano, egli assisteva a quello spettacolo. Ma non era ancor l’opera sua, quella, che aveva preso corpo e seguitava ora ad andare da sé, senza più curarsi di lui?
Sì, era l’opera sua, l’opera che gli aveva assorbito, succhiato tutta la vita, fino a lasciarlo così, vuoto, spento. E gli toccava di vederla proseguire, là, ecco, in quella fiumana di gente ansiosa, a cui non poteva più neanche accostarsi, mescolarsi; espulso, respinto, egli, egli per cui la prima volta quella fiumana s’era mossa, egli che primo la aveva raccolta e guidata, in quella serata memorabile al teatro Valle di Roma!
Ora doveva aspettare così, di nascosto, da lontano, eh’essa, fragorosa, impaziente, invadesse e riempisse tutto il teatro, dov’egli si sarebbe cacciato furtivamente e per ultimo, vergognoso.
Straziato da questo esilio, ch’era d’un passo e infinito, dalla sua stessa vita, la quale, ecco, viveva là, fuori di lui, innanzi a lui, e lo lasciava spettatore inerte della sua propria miseria, della sua nullità adesso, Giustino ebbe un impeto d’orgoglio e pensò che – sì – seguitava ad andare da sé l’opera sua; ma come? non certo come se ci fosse lui ancora, a dirigerla, a sorvegliarla, a governarla, a sorreggerla da tutte le parti! Davvicino avrebbe voluto vedere com’essa seguitava ad andare senza di lui! Che preparazione aveva avuto quella prima del nuovo dramma? Appena appena ne avevano parlato i giornali della sera avanti e della mattina… Se ci fosse stato lui, invece! Sì, affluiva, seguitava ad affluire la gente; ma perché? per la memoria della Nuova colonia, del trionfo procurato da lui; e per vedere, per conoscere l’autrice, quella timida, scontrosa, inesperta ragazzetta di Taranto ch’egli, con l’opera sua, aveva messo avanti a tutti e reso celebre: egli che se ne stava qui, ora, abbandonato, nascosto nel bujo, mentr’ella di là, nella luce della gloria, era circondata dall’ammirazione di tutti.
Doveva esser là, certo, sul palcoscenico, a quell’ora. Chi sa com’era! Che diceva? Possibile che non pensasse ch’egli da Cargiore, così vicino, sarebbe venuto ad assistere alla rappresentazione del dramma? Oh Dio, oh Dio… lo riassaliva, a farlo tremar tutto, il pensiero che gli era sorto al primo annunzio ch’ella sarebbe venuta a Torino: che fosse venuta appunto per riaccostarsi a lui; che si aspettasse, dopo i primi applausi, una furiosa irruzione di lui sul palcoscenico e un abbraccio frenetico innanzi a tutti gli attori commossi; e poi, e poi… oh Dio – si sentiva aprir le reni dai brividi, un formicolio per tutta la persona – ecco, si scostava da una parte e dall’altra la tenda, e tutti e due, lei e lui, presi per mano si mostravano, s’inchinavano, riconciliati e felici, a tutto il popolo acclamante in delirio.
Follie! follie! Ma, d’altra parte, non passava anche ogni limite l’improntitudine di lei, di venir là a Torino, fin sotto gli occhi di lui?
Si struggeva di sapere, di vedere… Ma come poteva da quel palchetto d’ultima fila, nel centro, che era riuscito ad accaparrarsi dal giorno avanti?
Vi era entrato or ora, di furia, salendo a quattro a quattro le scale.
Si teneva in fondo, per non farsi scorgere. Sul suo capo già la piccionaja strepitava; veniva dal basso, dai palchi, dalla platea, il fragorio, il fermento delle grandi serate. Il teatro doveva esser pieno e splendido.
Ancora anelante, più dall’emozione che dalla corsa, egli guardava il telone e avrebbe voluto trapanarlo con gli occhi. Ah che avrebbe pagato per riudire il suono della voce di lei! Credeva di non ricordarselo più! Come parlava ella adesso? come vestiva? che diceva?
Sobbalzò a uno squillo prolungato d’un campanello, che rispondeva al chiasso cresciuto nel loggione. Ed ecco s’apriva la tela!
Istintivamente, nell’improvviso silenzio, egli si fece innanzi, guardò la scena, che fingeva la sala di redazione d’un giornale. Conosceva il primo atto e anche il secondo del dramma, e sapeva che ella non ne era contenta. Forse li aveva rifatti, o forse, se il successo del dramma era stato mediocre, li aveva lasciati così com’erano, costretta a metter subito in iscena il lavoro per provvedere a difficoltà finanziarie.
La prima scena, tra Ersilia Arciani e il direttore del giornale Cesare D’Albis, era tal quale. Ma la Fresi non rappresentava la parte d’Ersilia con quella rigidezza che Silvia aveva dato al carattere della protagonista. Forse ella stessa, Silvia, aveva attenuato quella rigidezza per rendere il personaggio men duro e più simpatico. Ma, evidentemente, non bastava. In tutto il teatro s’era già, fin dalle prime battute, diffuso il gelo d’una disillusione.
Giustino lo avvertiva, e da tutto quel gelo si sentiva venire un gran caldo alla testa, e sudava e s’agitava, smanioso. Per Dio! esporsi così al cimento terribile d’un nuovo dramma, dopo il trionfo clamoroso del primo, senza un’adeguata preparazione della stampa, senza prevenire il pubblico che quel nuovo dramma sarebbe stato diverso in tutto dal primo, la rivelazione d’un nuovo aspetto dell’ingegno di Silvia Roncella. Ecco qua le conseguenze: il pubblico s’aspettava la poesia selvaggia della Nuova colonia, la rappresentazione di strani costumi, di personaggi insoliti; si trovava invece davanti aspetti consueti della vita, prosa, prosa, e restava freddo, disingannato, scontento.
Avrebbe dovuto goderne, egli; ma no, no! perché quant’era ancora di vivo in lui era tutto in quell’opera che vedeva cascare, e sentiva ch’era un peccato ch’egli non ci potesse più metter le mani per sorreggerla, rialzarla, farla di nuovo trionfare; un peccato per l’opera e una crudeltà feroce per sé!
Scattò in piedi a uno zittìo prolungato che si levò a un tratto dalla platea, come un vento ad agitare tutto il teatro, e arretrò fino in fondo al palchetto con le mani sul volto in fiamme, quasi gliel’avessero sferzato.
L’ostinazione con cui Leonardo Arciani si rifiutava di ragionare col suocero urtava gli spettatori. Ma forse in fine il grido di Ersilia, che spiegava quell’ostinazione: «Babbo, ha la figlia, la figlia: non può ragionare!» avrebbe salvato l’atto. Ecco, entrava la Fresi. Si faceva silenzio. Guglielmo Groa e il genero venivano quasi alle mani. Il pubblico, non comprendendo ancora, s’agitava vie più. E Giustino, fremente, avrebbe voluto gridar lui dal suo palchetto d’ultima fila:
«Idioti, non può ragionare! ha la figlia!».
Ma ecco, ecco, lo gridava la Fresi., brava! così… forte, con tutta l’anima, come una scudisciata… Il pubblico rompeva in un aaahhh prolungato… Come?… non piaceva? No… Molti applaudivano… Ecco, il sipario calava fra gli applausi; ma erano applausi contrastati; molti anche zittivano… Oh Dio, un fischio acuto, lacerante, dalla piccionaja… benedetto, benedetto fischio! in reazione, infittivano ora gli applausi nelle poltrone, nei palchi… Giustino, col volto inondato di lagrime, convulso, si storceva le mani, tentato d’applaudire anche lui furiosamente, e pur non di meno impedito dall’attesa angosciosa che gli concentrava tutta l’anima negli occhi. Venivano fuori gli attori… No, ella non c’era… Silvia non c’era… Fuori! fuori ancora una volta! Oh Dio… C’era? No… neanche questa volta… Gli applausi cadevano, e con gli applausi cadeva anche Giustino su una seggiola del palchetto, sfinito, ansimante, come se avesse fatto una corsa d’un’ora. Dal fuoco che gli bruciava la fronte venivano fuori gocce di sudore grosse come lagrime. Tutto ristretto in sé, cercava dar requie alle viscere contratte, al cuore tumultuante, e un gemito gli usciva dalla gola tra l’ansito, come per la crudeltà d’un tormento che non si possa più sopportare. Ma non poteva star fermo un istante; s’alzava, s’appoggiava alla parete del palchetto con le braccia abbandonate, il fazzoletto in mano, il capo ciondoloni… guardava l’usciolino… si portava il fazzoletto alla bocca e lo strappava… Era prigioniero lì… Non poteva farsi vedere… Avrebbe voluto udire almeno i commenti che si facevano su quel primo atto; accostarsi al palcoscenico, vedere quelli che vi entravano a confortar l’autrice… Ah, in quel momento ella di certo non pensava a lui; non esisteva egli per lei: era uno lì de la folla, confuso con tutti… eh no, no, neppur questo: neanche de la folla egli poteva più far parte: egli non doveva esserci, ecco; e non c’era, di fatti: chiuso, nascosto lì in un palchetto che tutti dovevano creder vuoto, l’unico vuoto, perché c’era uno che non doveva esserci… Che tentazione, intanto, di correre al palcoscenico, farsi largo, da padrone, riprendere il suo posto, la bacchetta del comando! Un furore eroico lo sollevava, di far cose inaudite, non mai vedute, per cangiar di punto in bianco le sorti di quella serata, sotto gli occhi attoniti di tutto il pubblico; dimostrare che c’era lui, adesso, lui, l’autore del trionfo della Nuova colonia…
Ecco, squillavano i campanelli per il secondo atto. Ricominciava la battaglia. Oh Dio, come avrebbe fatto ad assistervi, così stremato di forze?
Il pubblico rientrava nella sala agitato, turbolento. Se la prima scena del secondo atto, tra il padre e la figlia, non piaceva, il lavoro sarebbe caduto irreparabilmente.
Si alzò la tela.
La scena rappresentava lo studio di Leonardo Arciani. Era giorno, e il lume rimasto acceso tutta la notte, ardeva ancora su la scrivania. Guglielmo Groa dormiva, sdrajato su una poltrona, con un giornale su la faccia. Entrava Ersilia, spegneva il lume, svegliava il padre e gli annunziava che il marito non era rincasato; alle domande aspre e recise di quello, come martellate su la roccia, si rompeva la durezza di Ersilia, e la sua passione chiusa cominciava a fluire; ella parlava con languida calma accorata e difendeva il marito, il quale, posto tra lei e la figlia, se n’era andato da questa: «Dove sono i figli è la casa!».
Giustino, preso, affascinato anche lui dalla profonda bellezza di quella scena rappresentata con arte mirabile dalla Fresi, non avvertiva che il pubblico, s’era fatto, ora, attentissimo. Quando, alla fine, scoppiò un applauso caldo, lungo, unanime, sentì tutto il sangue d’un tratto piombargli al cuore e d’un tratto rimontargli alla testa. La battaglia era vinta; ma lui, lui si vide perduto; se Silvia a quegli applausi insistenti si presentava a ringraziare il pubblico, non la avrebbe veduta: gli era calato come un velo davanti agli occhi. No, no, per fortuna! La rappresentazione seguitava. Egli però non potè più prestare attenzione. L’ansia, l’angoscia, la smania gli crebbero di punto in punto, progredendo l’atto, approssimandosi alla fine, alla scena stupenda tra il marito e la moglie, allorché Ersilia, perdonando a Leonardo, lo allontana da sé: «Tu non puoi più rimanere qua, ora. Due case, no, io qua e tua figlia là, no. Non è più possibile, vattene! So quello che tu desideri». Ah, come lo diceva la Fresi! Ecco,Leonardo andava Via; ella rompeva in un pianto di gioja, e calava la tela tra applausi fragorosi.
– L’autrice! l’autrice!
Giustino con le braccia strette, incrociate sul petto e le mani aggrappate agli omeri, quasi a impedire che il cuore gli balzasse fuori, aspettò mugolando che Silvia comparisse alla ribalta. Lo spasimo dell’attesa gli rendeva quasi feroce il viso.
Eccola! No. Erano gli attori. Gli applausi seguitavano scroscianti.
– L’autrice! Fuori l’autrice!
Eccola! Eccola! Quella? Sì, eccola là tra i due attori. Ma si distingueva appena, così dall’alto: la distanza era troppa e troppo la commozione gl’intorbidava la vista! Ma ecco, la chiamavano ancora una volta fuori; eccola, eccola di nuovo; i due attori si traevano indietro e la lasciavano sola alla ribalta, là, esposta, a lungo, a lungo, alla dimostrazione solenne del pubblico acclamante in piedi. Questa volta Giustino la potè scorgere bene: stava diritta, pallida, e non sorrideva; inchinava appena il capo, lentamente, con una dignità non fredda, ma piena d’una invincibile tristezza.
Non pensò più a nascondersi, Giustino, appena ella si ritrasse dalla ribalta, scappò fuori del palchetto come un forsennato; si precipitò giù per le scale, incontro alla folla che usciva dalla sala e ingombrava i corridoi; si fece largo con gesti furiosi, tra lo stupore di quanti si videro strappati indietro; udì grida e risa alle sue spalle; trovò l’uscita del teatro, e via, via quasi di corsa, con una sola sensazione in sé nella tenebra vorticosa che gli occupava il cervello, tutta trafitta da sprazzi di luce; quella d’un fuoco che gli divorasse le viscere e gli désse alla gola un’arsura atroce.
Come un cane battuto, si cacciò dalla piazza nella prima via che gli s’aprì davanti, lunga, diritta, deserta; e prese ad andare senza saper dove, con gli occhi chiusi, grattandosi con ambo le mani i capelli su le tempie e dicendosi senza voce entro la bocca arida, come di sughero:
– È finita… è finita… è finita.
Questo, dalla vista di lei, gli era penetrato, gli s’era imposto come una convinzione assoluta: che tutto per lui era finito, perché quella non era più Silvia, no, no, quella non era più Silvia; era un’altra, a cui egli non poteva più accostarsi, lontana, irraggiungibilmente lontana; sopra di lui, sopra di tutti, per quella tristezza ond’era tutta avvolta, isolata, inalzata, così diritta e austera, com’era uscita dalla tempesta attraversata; un’altra, per cui egli non aveva più alcuna ragione d’esistere.
Dove andava? Dove s’era cacciato? Guardò smarrito le case tacite, buje; guardò i fanali veglianti tristi nel silenzio; si fermò; fu per cascare; s’appoggiò al muro, con gli occhi a uno di quei fanali; osservò come un insensato la fiamma immota, poi, sotto, il cerchio di luce sul marciapiede; allungò lo sguardo nella via; ma perché cercare di raccapezzarsi, se tutto era finito? Dove doveva andare? a casa? e perché? doveva seguitare a vivere, è vero? e perché? Lì, nel vuoto, in ozio, a Cargiore, per anni e anni e anni… Che gli restava più, che potesse dare un qualche senso, un qualche valore alla sua vita? Nessun affetto, che non rappresentasse ormai un dovere insopportabile: quello per il figlio, quello per la madre. Egli non ne sentiva più bisogno, di questi affetti; ne sentivano il bisogno gli altri, il figlio, la madre; ma che poteva più fare per loro? Vivere, è vero? Vivere per non far morire di dolore la sua vecchia mamma… Quanto al figlio, se egli fosse morto e morta la nonna, restava la madre, e sarebbe stato meglio per lui e meglio anche per lei. Col bambino accanto, ella avrebbe dovuto per forza pensare a lui, al padre, a quello ch’era stato suo marito, e così egli avrebbe seguitato a esistere per lei, col figlio, nel figlio.
Ah, come ridursi a piedi, così sfinito, da Giaveno a Cargiore? Certo sua madre stava ad aspettarlo, chi sa fra quali tristi pensieri per quella sua scomparsa… Era stato come pazzo tutti quei giorni, da che aveva saputo che Silvia sarebbe venuta a Torino. Lo aveva saputo anche la madre per mezzo del Prever, a cui forse qualcuno lo aveva detto in paese, il dottor Lais probabilmente, che aveva letto la notizia nei giornali. E gli era entrata in camera, la madre, a scongiurarlo di non scendere più in città in quei giorni. Ah, poverina! poverina! che spettacolo le aveva dato! S’era messo a gridare, proprio come un pazzo, che voleva essere lasciato stare, che non aveva bisogno della tutela d’alcuno, che non voleva essere soffocato da tutte quelle premure e paure, né accoppato da tutti quei consigli. E per tre giorni non era più sceso neanche a desinare e a cenare, tappato in camera, senza voler vedere nessuno né sentir nulla.
Basta, ora. La aveva riveduta, s’era tolta ogni speranza; che più gli restava da fare? Ritornare al suo figliuolo, alla sua mamma, e basta… basta per sempre!
S’avviò, si raccapezzò, si diresse alla stazione della tramvia a vapore che doveva condurlo a Giaveno; vi giunse appena in tempo per l’ultima corsa.
Sceso a Giaveno circa a mezzanotte, si mise in via per Cargiore. Tutto era silenzio, sotto la luna, nella fresca dolcissima notte di maggio. Provò, più che sgomento della solitudine attonita e quasi stupefatta nel blando chiaror lunare, una guardinga ambascia della misteriosa affascinante bellezza della notte tutta pezzata d’ombre di luna e sonora di trilli argentini. A tratti, certi segreti mormorii d’acque e di frondi gli rendevano più cupa e più vigile l’ambascia. Gli pareva che quei mormorii non volessero essere uditi né udire il suono dei suoi passi; ed egli camminava più lieve. All’improvviso, dietro un cancello, un cane gli abbajò ferocemente e lo fece sobbalzare e tremare e gelar di spavento. Subito, tant’altri cani presero ad abbajare da presso, da lontano, protestando contro quel suo passare a quell’ora. Cessato il tremito, avvertì maggiormente l’estrema stanchezza che gli aggravava le membra; pensò a che doveva quella stanchezza; pensò alla via interminabile che aveva davanti, e subito gli s’oscurò la bellezza della notte, gli svanì il fascino di essa, e si sprofondò nel vuoto tenebroso del suo dolore. Andò, andò per più di un’ora, senza voler sostare un momento a riprender fiato; alla fine non ne potè più e sedette sul ciglio del viale: proprio cascava a pezzi; non aveva neanche più forza di reggere il capo. Gli si fece distinto, a poco a poco, il fragorio profondo del Sangone giù nella valle, poi anche il fruscio delle foglie nuove dei castagni e la frescura densa della vallata boscosa, in fine il riso d’un rivoletto di là; e risentì l’arsura della bocca. Si lagnò per far pietà a sé stesso, al suo animo cupo e incrudelito; si vide così solo, per via, nella notte, e così stanco e disperato, e provò un cocente bisogno di conforto. Si rialzò per giunger più presto a colei che sola ormai poteva darglielo. Ma dovette andare per un’altra ora buona, prima di scorgere la cuspide ottagonale della chiesa, appuntata come un dito minaccioso al cielo. Quando vi giunse e volse gli occhi alla sua casa, vi vide con stupore accesi i lumi a tre finestre. Uno, sì, se lo aspettava; ma tanti perché?
Al bujo, seduto su lo scalino innanzi alla porta, trovò il Prever che piangeva dirottamente.
– La mamma? – gli gridò.
Il Prever si levò e con la testa bassa gli tese le braccia:
– Rino… Rino… – gemette, tra i singhiozzi, entro il barbone abbatuffolato.
– Rino?… Ma come?… Che ha?
E, sciogliendosi con rabbia dalle braccia del vecchio, Giustino corse su alla camera del bimbo gridando ancora:
– Che ha? che ha?
Restò, su la soglia, davanti allo scompiglio della camera.
Il bimbo era stato tratto or ora da un bagno freddo, e la nonna lo teneva su le ginocchia, avvolto nel lenzuolo. C’era il dottor Lais. Graziella e la bàlia piangevano. Il bimbo non piangeva; tremava tutto, con la testina ricciuta inzuppata d’acqua, gli occhi serrati, il visino avvampato, quasi paonazzo, già gonfio.
La madre alzò appena gli occhi, e Giustino si sentì trafiggere da quello sguardo.
– Che ha? che ha? – chiese con voce tremante al dottore. – Che è accaduto? Così… d’un colpo?
– Eh, da due giorni… – fece il dottore.
– Due giorni?
La madre tornò a sogguatarlo.
– Io non so… non so nulla… – balbettò allora Giustino al medico, come a scusarsi. – Ma come? Che ha, dottore? Mi dica! Che è stato? che è stato?
Il Lais lo prese per un braccio, gli fece un cenno col capo, e se lo portò nella stanza accanto.
– Lei viene da Torino, è vero? È stato a teatro?
– Sì, – bisbigliò Giustino, guardandolo, intronato.
– Ebbene, – riprese il Lais, esitante. – Se la madre è qua…
– Che cosa?
– Penso che… sarà bene, forse, avvertirla…
– Ma dunque, – gridò Giustino, – dunque Rino… il mio bimbo…
Gli risposero tre scoppi di pianto dalla stanza attigua, e un quarto alle spalle, del Prever ch’era risalito. Giustino si volse, si abbandonò tra le braccia del vecchio e ruppe in pianto anche lui.
Il Lais rientrò nella stanza del bimbo, che, riposto sul letto, pure sprofondato nel letargo, pareva désse gli ultimi tratti. Già scottava di nuovo. Sopravvenne Giustino, invano trattenuto dal Prever.
– Voglio sapere che ha! voglio sapere che ha! – gridò al dottore, in preda a una rabbia feroce.
Il Lais se ne irritò, e gli gridò a sua volta:
– Che ha? Una perniciosa!
E il tono e il cipiglio dicevano: «Lei se ne viene dal teatro, e ha il coraggio di domandare a me a codesto modo che cos’ha il suo figliuolo!».
– Ma come! In tre giorni?
– In tre giorni, sicuro! Che meraviglia? È ben per questo una perniciosa!… S’è fatto di tutto… ho tentato…
– Rino mio… Rino mio… Oh Dio, dottore… Rirì mio!
E Giustino si buttò in ginocchio accanto al lettuccio, a toccare con la fronte la manina bruciante del bimbo, e tra i singhiozzi pensò che non aveva dato mai, mai tutto il suo cuore a quell’esseruccio che se n’andava, ch’era vissuto circa due anni quasi fuori dell’anima sua, fuori di quella de la madre, povero bimbo, e aveva trovato rifugio soltanto nell’amor della nonna… Ed egli poc’anzi aveva pensato di darlo alla madre! Ma non se lo meritava neanche lei, come non se lo meritava lui! Ed ecco, perciò il bimbo se ne andava… Non se lo meritavano nessuno dei due.
Il dottor Lais lo fece alzare da terra e con dolce violenza se lo portò di nuovo nella camera accanto.
– Ritornerò appena sarà giorno, – gli disse qua. – Se vuole fare il telegramma alla madre… Mi sembra giusto… Posso, se vuole, incaricarmi io di passarlo, prima di ritornare. Ecco, scriva qua.
E gli porse un biglietto del suo taccuino e la penna. Egli vi scrisse: «Vieni subito. Tuo figlio muore. Giustino».
4.
Tutta la cameretta era piena di fiori; pieno di fiori il lettuccio su cui giaceva il cadaverino sotto un velo azzurro; quattro ceri ardevano agli angoli, quasi a stento, come se le fiammelle penassero a respirare in quell’aria troppo gravata di profumi. Anche il morticino ne pareva oppresso: cereo, coi globi degli occhietti induriti sotto le pàlpebre livide.
Tutti quei fiori insieme non facevano più odore: avevano ammorbato l’aria chiusa di quella cameretta; stordivano e nauseavano. E il bimbo sotto il velo azzurro, irremovibilmente abbandonato a quel profumo ammorbante, sprofondato in esso, prigioniero di esso, ecco, non poteva esser più guardato se non da lontano, al lume di quei quattro ceri, il cui giallor caldo rendeva quasi visibile e impenetrabile il graveolente ristagno di tutti quegli odori.
Soltanto Graziella stava presso l’uscio a mirare con occhi disfatti dal pianto il cadaverino, allorché, verso le undici, come in un vento improvviso su per la scala, tra gemiti e fruscii d’abiti e singhiozzi rinnovati giù a pianterreno, Silvia, sorretta dal dottor Lais, fece per irrompere nella cameretta e subito s’arrestò poco oltre la soglia, levando le mani, come a ripararsi da quello spettacolo, e aprendo la bocca a un grido, a un altro, a un altro, che non poterono romperle dalla gola. Il dottor Lais se la sentì mancare tra le braccia; gridò:
– Una sedia!
Graziella la porse; entrambi, sorreggendola, la fecero sedere, e subito il Lais balzò alla finestra, esclamando:
– Ma, dico, come si fa a star così? Qua dentro non si respira! Aria, aria!
E ritornò sollecito a Silvia, la quale ora, seduta, con le mani sul volto, il capo piegato come sotto una condanna, che oltre al peso del cordoglio avesse quello del rimorso e della vergogna, piangeva scossa da violenti singulti. Pianse così un pezzo; poi levò il capo, sorreggendoselo con le mani allargate di qua e di là dagli occhi, e guardò il lettuccio; si alzò, vi s’accostò, dicendo al dottore che voleva impedirglielo:
– No… no… mi lasci… me lo lasci vedere…
E dapprima lo mirò attraverso il velo, poi senza il velo, soffocando i singhiozzi, rattenendo il respiro per provare in sé la morte del figlio, che non riconosceva più; e come non potè regger più oltre a quell’arresto di vita in sé, si chinò a baciare la fronte del cadaverino e vi gemette sopra:
– Ah, come sei freddo… come sei freddo…
E dentro sé piangeva: «Perché il mio amore non ha potuto riscaldarti…».
– Freddo… freddo…
E gli carezzò sul capo, lievemente, i riccioletti biondi.
Il dottor Lais la costrinse a staccarsi dal lettuccio. Ella guardò Graziella che piangeva, ma le scorse dietro le lagrime per il bimbo uno sguardo ostile per lei; non ne provò sdegno, anzi amò l’odio di quella vecchia ch’era un atto d’amore per il suo bimbo, e si rivolse al dottore:
– Com’è stato? com’è stato?
Il Lais la condusse nella stanza attigua, in quella stessa ov’ella aveva dormito nei mesi del suo soggiorno là. Il pianto, allora, che nella cameretta del bimbo le era venuto agli occhi se non propriamente sforzato, quasi strappato dalla violenza di quella vista, qua le sgorgò spontaneo e impetuoso: qua si sentì lacerare il cuore dai ricordi vivi della sua creaturina, qua si risentì madre veramente, col cuore d’allora, quando la bàlia ogni mattina le recava a letto il piccino roseo ignudo levato or ora dal bagno, ed ella, stringendoselo al seno, pensava che presto le sarebbe toccato di separarsi da lui…
Intanto il Lais le parlava della malattia improvvisa, di quanto aveva fatto per salvarlo, e le raccontava che anche per il padre quella sciagura era stata uno schianto inatteso, perché la sera avanti egli era a teatro ad assistere al dramma di lei, senza sapere che il bambino fosse così gravemente malato.
Silvia levò il capo, percorsa da un brivido, a questa notizia:
– Iersera? a teatro? Ma come non sapeva?…
– Eh, signora, – rispose il Lais. – Con la notizia che lei sarebbe venuta a Torino…
E con la mano fece un gesto che significava: parve si levasse di cervello.
– La madre non gliene disse nulla, vedendolo così, – aggiunse. – Non suppose veramente che si trattasse d’un caso così grave… Fa pietà, creda, fa pietà! Appena arrivato jeri notte, verso le due, a piedi da Giaveno, trovò qua il bimbo moribondo. Sono stato io a suggerirgli di avvisar lei per telegramma, anzi l’ho passato io stesso il telegramma, quando già il bimbo purtroppo… È spirato verso le sei… Sente? sente?
Su per la scaletta, all’improvviso, sonarono i singhiozzi di Giustino tra uno scalpiccio confuso e le grida di altri che forse cercavano di trattenerlo.
Silvia balzò in piedi, sconvolta, e si ritrasse in un angolo, come se volesse nascondersi.
Sorretto da don Buti, dal Prever e dalla madre, Giustino apparve su la soglia come smemorato, scomposto negli abiti, nei capelli, il volto bagnato di lagrime; guardò truce il dottor Lais, disse:
– Dov’è?
Appena la vide, il ventre, il petto gli si misero a sussultare e le gambe e il mento a tremar d’un lieve e fitto tremito crescente, finché il pianto, scomponendogli a mano a mano i tratti del viso, non gli gorgogliò in gola convulso; ma come il Prever e don Buti cercarono di trarlo via, si strappò da loro ferocemente:
– No, qua! – gridò.
E stette un istante così, sciolto, perplesso; poi, arrangolando, si precipitò su Silvia e l’abbracciò furiosamente.
Silvia non mosse un braccio; s’interì per resistere allo strazio che quell’impeto disperato le cagionava, serrò gli occhi per pietà, poi li riaprì per rassicurar la madre che non temesse di lei, che – ecco – non abbracciava, si lasciava abbracciare per pietà, e quella pietà avrebbe saputo contenere.
– Hai veduto? hai veduto? – le singhiozzava intanto Giustino sul seno, stringendola sempre più. – Se n’è andato,… Rirì se n’è andato, perché noi non c’eravamo… tu non c’eri… e neanche io c’ero più… e allora il povero piccino ha detto: «E che ci faccio più io qua?» e se n’è andato… Se ti vedesse qua ora… Vieni! vieni! Se ti vedesse qua…
E la trascinò per mano alla camera del bimbo, come se la venuta di lei e la gioja ch’egli ne provava potessero fare il miracolo di richiamare in vita il bambino.
– Rirì!… Ah, Rirì… ah, Rirì mio…
E cadde di nuovo in ginocchio innanzi al letto, affondando la faccia tra i fiori.
Silvia si sentì venir meno; il dottor Lais accorse, la sorresse, la riportò nella camera attigua. Anche Giustino fu strappato dal lettuccio da don Buti e dal Prever e ricondotto giù a pianterreno.
– Silvia! Silvia! – seguitava a chiamare, subendo la violenza di quei due senza più coraggio di ribellarsi ora che aveva riveduto morto il suo bambino.
Al suono del suo nome che s’allontanava, Silvia si sentì come chiamata dal fondo della vita trascorsa lì un anno addietro: era tra la letizia d’allora il presentimento oscuro di questa sciagura; e qual presentimento ora la chiamava così tra il pianto: – Sii via!… Silvia!… – da lontano. Ah, se avesse potuto sentire allora il suo nome gridato così, ella avrebbe trovato la forza di resistere a ogni tentazione; sarebbe rimasta lì col suo piccino, in quel nido di pace tra i monti, e il suo piccino non sarebbe morto, e nessuna delle cose orrende che erano avvenute, sarebbe avvenuta. Quella più orrenda fra tutte… ah, quella! Ancora, tra vampe di soffocanti immaginazioni, ella si sentiva bruciar le carni dalla vergogna d’un unico amplesso, tentato quasi a freddo, per un’orrida necessità ineluttabile, là a Ostia, e rimasto disperatamente incompiuto; si sentiva da esso insozzata per sempre, più che se si fosse resa colpevole mille e mille volte con tutti quei giovani che la voce pubblica le aveva affibbiati e le affibbiava ancora per amanti. La memoria viscida di quell’unico amplesso mancato le aveva incusso una nausea invincibile, un’abominazione, nella quale si sarebbe ormai sempre affogato ogni desiderio d’amore. Era sicura che Giustino, se ella avesse voluto, si sarebbe strappato dalle braccia della madre, da ogni ritegno d’amor proprio, per ritornare a lei. Ma no: ella non voleva; per lui e per sé non doveva! Ora anche l’ultimo vincolo tra loro era stato spezzato dalla morte; e invano egli laggiù si dibatteva tra le braccia che volevano trattenerlo. Il dottor Lais era stato chiamato in ajuto. Di là giaceva tra i fiori il suo bambino morto. Saliva gente a vederlo: donne del paese, vecchi, ragazzi, e recavano tutti altri fiori, altri fiori…
Poco dopo il dottor Lais, tutto accaldato e sbuffante, risalì da lei con un foglio di carta in mano, la bozza d’un telegramma, che il marito giù, gridando e dibattendosi, aveva voluto scrivere per forza. E voleva che lui, il dottor Lais, andasse subito a passarlo, dopo averlo fatto vedere a lei.
– Un telegramma? – domandò Silvia, stordita.
– Già, eccolo.
E il Lais glielo porse.
Era un telegramma alla Compagnia Fresi. Parecchie parole erano rese quasi illeggibili dalle lagrime che vi erano cadute sopra. Vi si annunziava la morte del bambino, chiedendo che fossero sospese le repliche del dramma; previo annunzio al pubblico del grave lutto dell’autrice. Era firmato Boggiolo.
Silvia lo lesse e restò, sotto gli occhi del dottore in attesa, assorta stupita e perplessa.
– Si deve passare?
Ecco: dopo l’abbraccio,.egli si sentiva già ridiventato suo marito.
– Così, no, – rispose al dottore. – Levi l’annunzio al pubblico e, se vuole incomodarsi, lo passi pure, ma sotto il mio nome, prego…
Il dottor Lais s’inchinò.
– Comprendo bene, – disse. – Non dubiti, sarà fatto.
E andò via.
Ma dopo circa mezz’ora, ecco Giustino su di nuovo, con un’aria da folle, insieme con un giornalista, con quello stesso giovine giornalista venuto da Torino un anno addietro alla scoperta dell’autrice, della Nuova colonia.
– Eccola qua! eccola qua! – disse, facendolo entrare nella camera; e, rivolto a Silvia: – Tu lo conosci, è vero?
Il giovine, mortificato da quell’ansia scomposta, quasi ilare, del Boggiolo, che avventava in mezzo al luttuoso momento, benché il pover’uomo mostrasse pure il volto bruciato dalle lagrime, s’inchinò e stese la mano a Silvia, dicendo:
– Mi duole, signora, di ritrovarla qui in un animo così diverso dalla prima volta. Ho saputo in teatro, ch’ella era corsa qui… Non m’aspettavo, che già…
Giustino lo interruppe, afferrandolo per un braccio:
– Mentre jersera giù a Torino si rappresentava il dramma, – prese a dirgli con un gran tremore nella voce e nelle mani, ma pur con gli occhi fissi in quelli di lui, come se volesse fargli la lezione, – qua il bambino moriva, e nonlo sapevamo né io né lei, capisce? E lei, – seguitò, additando Silvia, – lei qua, la prima volta, sa perché ci venne? Per la nascita del nostro bimbo! E sa quando nacque il nostro bimbo? La sera stessa del trionfo della Nuova colonia, proprio la stessa sera, per cui lo chiamammo Vittorio, Vittorino… Ora è ritornata qua per la sua morte! E quando avviene questa morte? Proprio mentre a Torino si rappresenta il nuovo dramma! Veda un po’ ! veda un po’ la fatalità… Nasce e muore così… Venga, venga qua, glielo faccio vedere…
Così ripreso dalla foga della sua professione, in quello stato, faceva quasi spavento. Il giovine giornalista lo guatava, sbalordito.
– Eccolo! eccolo qua, il nostro angioletto! Vede com’è bello tra tanti fiori? Queste sono le tragedie della vita, caro signore, le tragedie che afferrano… Non c’è mica bisogno di andarle a cercar sempre nelle isole lontane, tra gente selvaggia, le tragedie della vita! Lo dico per il pubblico, sa? che certe cose non le vuol capire… Loro, loro giornalisti dovrebbero spiegarlo bene al pubblico, che se oggi una scrittrice si può cavare una tragedia… così, dalla testa, una tragedia selvaggia, che per la novità piace subito a tutti, domani lei stessa, la scrittrice, può essere afferrata da una di queste tragedie qua, della vita, che stritolano un povero bambino, il cuore d’un padre e d’una madre, capisce? Questo, questo dovrebbero loro spiegare al pubblico, che resta freddo davanti alla tragedia d’un padre che ha una figlia fuori di casa, d’una moglie che sa di non poter riavere il marito se non a patto di prendersi con sé la figlia di lui, e va là, va dall’amante del marito a farsela dare! Queste sono tragedie… le tragedie… le tragedie della vita, caro signore… Questa povera donna qua, creda, non può far nulla… non… non le sa far valere, le cose sue… Io, io ci voglio, io che so bene queste cose… ma la testa in questo momento mi… mi fa male assai, creda… mi fa male assai… Troppe emozioni… troppe, troppe… e ho bisogno di dormire… È la stanchezza, sa? che mi fa parlare così… Bisogna proprio che vada a dormire… non mi reggo più… non mi reggo più…
E se n’andò, curvo, con la testa presa tra le mani, ripetendo: – Non mi reggo più… non mi reggo più…
– Oh poverino! – sospirò il giornalista, rientrando con Silvia nell’altra camera. – In che stato si trova!…
– Per carità, – s’affrettò a pregar Silvia, – non dica, non riferisca nulla nel giornale…
– Signora mia! che crede? – la interruppe quello, parando le mani.
– È un doppio strazio per me! – riprese Silvia quasi soffocata. – È stato come un fulmine! E ora… quest’altro strazio…
Fa veramente pietà!
– Sì, e proprio per la pietà che ne sento, io voglio andarmene, voglio andarmene…
– Se vuole, signora, ho qui con me…
– No, no: domani, domani. Finché il mio bimbo è qua, starò qua. Qua è sepolto anche mio zio. E mi faceva tanto male il pensiero che quel mio caro vecchio fosse qua, in una tomba non sua. I morti, capisco, non sono tra loro né amici né nemici. Ma io lo pensavo tra morti non amici. Ora avrà con sé il nipotino e non sarà più solo nella tomba straniera. Gli darò domani il mio piccino e, appena sarà finito tutto, me ne scenderò…
– Vuole che venga io domani a rilevarla? Sarebbe per me una fortuna.
– Grazie, – disse Silvia. – Ma io non so ancor quando…
– M’informerò, non dubiti. A domani!
E il giovine giornalista andò via, tutto contento. Silvia chiuse gli occhi, con le labbra atteggiate più d’amarezza che di sdegno, e scosse un pezzo il capo. Poco dopo, Graziella le recò con gli occhi bassi, un ristoro; ma ella non volle neppur accostarvi le labbra. Sul tardi, le toccò il supplizio d’una visita: quella della moglie del dottore, più che mai cascante di vezzi. Ma per fortuna, nella stanchezza e nello stordimento, mentre colei cercava di confortarla scioccamente, potè trovare una nuova sorgiva di pianto, volgendo gli occhi a un angolo della camera.
Sul cassettone, come in colloquio tra loro, erano i giocattoli di Rirì: un cavalluccio di cartapesta, fissato su una tavoletta a quattro ruote, una trombettina di latta, una barchetta, un pagliaccetto coi cembali a scatto. Il cavalluccio, con la coda spelata, un orecchio ammaccato e una rotellina mancante, era il più malinconico di tutti. La barchetta con le vele stese gli voltava la poppa e pareva lontana lontana, una grande barca in un mare lontano lontano, di sogno; e andava così a vele stese in quel mare, di sogno con l’animuccia di Rirì meravigliata e smarrita… Ma che! no! il pagliaccetto, ridendo, le diceva che non era vero, che il piano del cassettone non era mica il mare, e che l’animuccia di Rirì non navigava più su lei.
Li aveva lasciati, Rirì, per fare una cosa seria seria, una cosa che pareva inverosimile per un bimbo: morire! Il cavalluccio, benché zoppo e spelato, com’era sorte di tutti i giocattoli, pareva tentennasse il capo, quasi non se ne sapesse capacitare. Se la trombetta si fosse provata a richiamarlo da quel sonno in mezzo a tutti quei fiori di là!… Ma anch’essa la trombetta era rotta, non sonava più… Anche la bocca di Rirì non parlava più… non si movevano più le manine… gli occhi non si riaprivano più… giocattolino rotto anche lui, Rirì!
Che avevano veduto quegli occhiuzzi di due anni aperti allo spettacolo di un mondo così grande? Chi serba memoria delle cose vedute con occhi di due anni? Ed ecco, quegli occhiuzzi che guardavano senza serbar memoria delle cose vedute, s’erano chiusi per sempre. Fuori c’erano tante cose da vedere: i prati, i monti, il cielo, la chiesa; Rirì se n’era andato da quel mondo grande che non era stato mai suo, se non in quel piccolo cavalluccio di cartapesta, che sentiva di colla, in quella barchetta con le vele stese, in quella trombetta di latta, in quel pagliaccetto che rideva e batteva i cembali a scatto. E non aveva conosciuto il cuore della sua mamma. Rirì…
Venne la sera; la moglie del dottore se ne andò; ella restò sola, nel silenzio enorme di tutta la casa.
S’affacciò alla cameretta mortuaria. C’erano Graziella e la bàlia: quella pisolava su la seggiola, l’altra recitava il rosario. Silvia ebbe all’improvviso la tentazione di mandar via a dormire l’una e l’altra, di restar sola lì col suo bimbo, serrar bene la finestra e l’uscio, stendersi accanto al suo piccino, lasciarsi prendere tutta dal suo gelo di morte e uccidere da tutti quei fiori. Con lo stordimento del loro profumo, che le aveva reso come di piombo la testa, si era a un tratto sentita vincere da una disperata stanchezza di tutte le cose della vita, nel tetro silenzio di quella casa schiacciata dall’incubo della morte. Affacciandosi però alla finestra, ebbe la strana impressione che la sua anima in tutto quel tempo fosse rimasta fuori, là, e che lei la ritrovasse ora con uno stupore e un refrigerio infinito. Era quella stessa anima che aveva mirato lassù lo spettacolo di un’altra notte di luna simile a questa. Ma c’era nella dolcezza del refrigerio, ora, un accoramento più intenso, un più urgente bisogno di sciogliersi da tutto, e nello stupore un più anelante risveglio a nuove aure, ad aure più vaste, di sogni eterni. Guardò in cielo la luna che pendeva su una di quelle grandi montagne, e nel placido purissimo lume che allargava il cielo, mirò, bevve le poche stelle che vi sgorgavano come polle di più vivida luce; abbasso gli occhi alla terra e rivide le montagne in fondo con le azzurre fronti levate a respirare nel lume, rivide gli alberi attoniti, i prati sonori d’acqua sotto il limpido silenzio della luna; e tutto le parve irreale, e che in quella irrealtà la sua anima si soffondesse divenuta albore e silenzio e rugiada.
Ma, ecco, come una tenebra enorme le assommava a mano a mano dal fondo dello spirito, di fronte a quella limpida irrealità di sogno: il sentimento oscuro e profondo della vita, composto da tante impressioni inesprimibili, sbuffi e vortici e accavallamenti nella tenebra di più dense tenebre. Fuori di tutte le cose che davan senso alla vita degli uomini, c’era nella vita delle cose un altro senso che l’uomo non poteva intendere: lo dicevan quegli astri col loro lume, quelle erbe coi loro odori, quelle acque col loro murmure: un arcano senso che sbigottiva. Bisognava andar oltre a tutte le cose che davan senso alla vita degli uomini, per penetrare in questo arcano senso della vita delle cose. Oltre alle meschine necessità che gli uomini si creavano, ecco altre cupe gigantesche necessità profilarsi entro il fluir fascinoso del tempo, come quelle grandi montagne là, entro l’incanto della verde silentissima alba lunare. In esse ella doveva d’ora innanzi affisarsi, infrontar con esse gli occhi inflessibili della mente, dar voce a tutte le cose inespresse del suo spirito, a quelle che sempre finora le avevano incusso sgomento, e lasciar la fatuità dei miseri casi dell’esistenza quotidiana, la fatuità degli uomini che, senz’accorgersene, vàgolano immersi nel vortice immenso della vita.
Tutta la notte stette lì affacciata alla finestra, finché l’alba frigida non venne a poco a poco a scomporre e a irrigidire gli aspetti prima vaporosi di sogno. E a questo frigido irrigidirsi delle cose toccate dalla luce del giorno, anch’ella sentì la divina fluidità del proprio essere quasi rapprendersi, e avvertì l’urto della realtà cruda, la terribilità bruta e dura della materia, la possente, avida, distruttrice ferocia della natura sotto l’occhio implacabile del sole che sorgeva. Questa terribilità e questa ferocia si riprendevano ora il suo povero bimbo, a rifarlo terra sottoterra.
Ecco, portavano la cassa. La campana della chiesa squillò a gloria nella luce del nuovo giorno.
Per un morticino che aspetta sul letto il tempo d’esser sepolto, quant’è lungo un giorno? quant’è lungo il ritorno della luce non più veduta fin dal giorno avanti? Questa lo ritrova già più lontano nelle tenebre della morte, già più lontano nel dolore dei superstiti. Per poco ora il dolore si ravvicinerà e urlerà allo spettacolo orrendo della chiusura del cadaverino nella cassa già pronta; poi, subito dopo il seppellimento, tornerà ad allontanarsi, a rifarsi in fretta di quel breve riavvicinamento crudele, finché non scomparirà a poco a poco nel tempo, dove di tratto in tratto soltanto la memoria, volando s’affannerà di raggiungerlo e lo scorgerà in fondo in fondo, e si ritrarrà oppressa e stanca, richiamata da un sospiro di rassegnazione…
Che cosa lesse Giustino, il quale aveva dormito fin’allora d’un sonno di piombo, nel volto di Silvia, in cui pareva si fosse illividito il pallore della luna mirato dalla finestra tutta la notte? Egli restò come sbigottito di fronte a lei; ebbe di nuovo nel ventre, nel petto un sussulto tremendo di pianto, ma non ardì più l’abbraccio della prima volta; si buttò invece a terra sul cadaverino del bimbo già composto nella bara, coperto di fiori. Fu tratto via dal Prever; la Graziella e la bàlia trassero via la nonna. Nessuno si curò di lei, che volle avere il cuore d’assistere a tutto sino alla fine, dopo aver baciato la morte su la piccola, dura e gelida fronte del bimbo. Quando già il coperchio della cassa era saldato, sopravvenne il giovine giornalista, ed ella si commosse un poco alle premure che costui le usò; ma non volle allontanarsi.
– Ormai… ormai è fatto, – gli disse. – Grazie, lasciatemi! Ormai ho visto tutto… Non si vede più nulla… Una cassa e l’amor mio di madre, là…
Un émpito di pianto le balzò alla gola, le sgorgò dagli occhi. Lo represse, quasi rabbiosamente, col fazzoletto.
Appena Giustino, sorretto dal Prever, a pie’ della casa, in mezzo alla gente accorsa per l’accompagnamento funebre, vide scendere dietro la piccola bara il giovine giornalista accanto a Silvia, comprese che questa, dopo il seppellimento, non sarebbe più ritornata a casa. Disse allora al Prever e alla gente che gli faceva ressa attorno:
– Aspettate, aspettate…
E corse su, in casa. La morte per lui non era tanto in quella piccola bara, quanto nell’aspetto di Silvia, nella definitiva partenza di lei. Quel ch’era morto di lui nel suo bimbo era ben poco a confronto di quel che di lui moriva con l’allontanamento della moglie. I due dolori erano per lui un dolore solo, inseparabile. Deponendo il bimbo nella tomba, egli doveva deporre insieme un’altra cosa, nelle mani di lei: gli ultimi resti della sua vita, ecco.
Fu visto poco dopo ridiscendere con un fascio di carte sotto il braccio. Con esse, appoggiato al Prever, seguì il mortorio fino alla chiesa, fino al cimitero. Quando il mortorio si sciolse, si strappò dal braccio del Prever e si accostò vacillante a Silvia che si disponeva a montare su l’automobile del giornalista.
– Ecco, – le disse, porgendole le carte, – tieni… Ormai io… che… che me ne faccio più? A te possono servire… Sono… sono recapiti di traduttori… note mie… appunti, calcoli… contratti… lettere… Ti potranno servire per… per non farti ingannare… Chi sa… chi sa come ti rubano… Tieni… e… addio! addio! addio!…
E si buttò singhiozzando tra le braccia del Prever che s’era avvicinato.
| Suo marito – Indice
Introduzione |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com