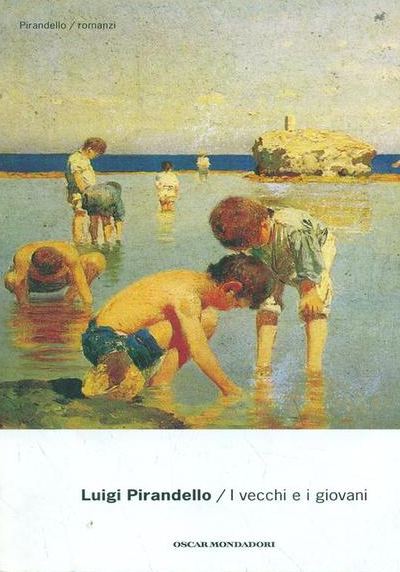««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «I Vecchi e i giovani» su Amazon
IV.
Corrado Selmi uscì dalla Camera dei deputati livido, stravolto, con un tremor convulso per tutto il corpo. Appena su la piazza, nel sole, fece uno sforzo disperato su se stesso per riaversi, per riafferrare in sé e rimettere sotto il suo dominio la vita che gli sfuggiva in un tremendo scompiglio; ma restò, avvertendo che non aveva neanche la forza di trarre il respiro, quasi avesse il petto, il ventre squarciati.
Un sentimento nuovo gli sorse allora improvviso: la paura. Non degli altri; ma di sé.
Or ora gli altri li aveva sfidati e assaliti, nell’aula del Parlamento, con estrema violenza. Ancora ne tremava tutto. Nessuno, là, aveva osato fiatare. Ma quel silenzio… ah, quel silenzio era stato per lui peggiore di ogni invettiva, d’ogni tumultuoso insorgere di tutta l’assemblea.
Quel silenzio lo aveva ucciso.
Aveva ancora negli orecchi il suono dei suoi passi nell’uscire dall’aula. Nel silenzio formidabile, quei passi avevano sonato come colpi di martello su una cassa da morto.
Sentiva una grande arsione; e le gambe, come… come se gli si fossero stroncate sotto.
Schiacciato dall’accusa, aveva voluto rilevarsene con tutto l’impeto delle energie vitali, ancora possenti in lui; ma appena aveva finito di parlare, quel silenzio. Nessun dubbio che l’assemblea, subito dopo la sua uscita dall’aula, avesse votato l’autorizzazione a procedere contro di lui.
Eppure tutti lo sapevano povero; sapevano che il denaro preso alle banche non poteva essere rinfacciato a lui come a tanti altri.
Dall’avere affrontato la morte, quando più bella suol essere per tutti la vita, non gli veniva il diritto di vivere? Nella losca complicazione di tante oblique vicende la semplicità di questo diritto appariva quasi ingenua e tale, che tutti, ridendo, dovessero negarglielo.
Morto; non solo, ma anche svergognato lo volevano! Doveva morire allora, e sarebbe stato un eroe per tutti questi vivi d’oggi che gli rinfacciavano come un delitto l’aver vissuto.
Ma non tanto l’accusa, in fondo, gli sembrava ingiusta, quanto ingiusti gli accusatori; e, più che ingiusti, ingrati e vili: vili perché, dopo aver per tanti anni compreso che egli aveva pure questo diritto di vivere, si levavano ora a dimostrargliene con ischerno l’ingenuità; dopo avere per tanti anni compreso il suo bisogno, si levavano ora a rinfacciarglielo come un’onta.
Né si sarebbero arrestati qui! Ora, il processo, la condanna, il carcere.
Corrado Selmi rise, e avvertì ancora lo sforzo che gli costava lo scomporre la truce espressione del volto in quel riso orribile. Il sorriso schietto e lieve, che aveva accompagnato sempre tutti gli atti della sua vita, anche i più gravi e i più rischiosi, s’era tramutato in quella triste smorfia dura e amara? Ebbe di nuovo paura di sé: paura di assumere coscienza precisa di un certo che oscuro e orrendo che gli s’era cacciato all’improvviso nel fondo dell’essere e glielo scompaginava, dandogli quell’impressione d’esser come squarciato dentro, irrimediabilmente. E per ricomporre comunque la compagine del suo essere, per vincere il ribrezzo e l’orrore di quell’impressione, si guardò attorno, quasi chiedendo sostegno e conforto ai noti aspetti delle cose. Gli parvero anche questi cangiati e come evanescenti. Sentì con terrore che non gli era più possibile ristabilire una relazione qual si fosse tra sé e tutto ciò che lo circondava. Sì, poteva guardare; ma che vedeva? poteva parlare; ma che dire? poteva muoversi; ma dove andare?
Parlò, tanto per udire il suono della sua voce, e gli parve anch’esso cangiato. Disse:
– Che faccio?
Sapeva bene quel che gli restava da fare. Ma nello schiacciar con la lingua contro il palato le due c di faccio, non avvertì altro che l’annodatura della lingua e l’amarezza aspra della bocca; e rimase col viso disgustato e arcigno.
– No, – soggiunse. – Prima… che altro?
Qualunque altra cosa gli apparve inutile, vana. Poteva soltanto, ancor per poco, per passarsi la voglia e darsi così fuor fuori uno sfogo, dire e fare sciocchezze. Pensare seriamente, agire seriamente non avrebbe potuto se non a costo di cedere al proposito oscuro e violento che stava a distruggergli dentro tutti gli elementi della vita. Baloccarsi poteva coi frantumi di essa che dal tumulto interno balzavano a galla della sua coscienza squarciata: baloccarsi un poco… Sì, in casa di Roberto Auriti! Doveva vederlo, dirgli che per lui, per coprirlo, si era messo da sé sotto accusa. Ecco che aveva ancora dove andare.
Chiamò una vettura, per non avvertire il tremore e la debolezza delle gambe, e diede al vetturino l’indirizzo: via delle Colonnette.
Appena montato, se ne pentì, prevedendo, in compenso di quanto aveva fatto, una scenata. Ma no: a ogni costo avrebbe saputo impedirla. Più che doveroso, il suo atto gli appariva generoso verso Roberto Auriti. E, in quel momento, non poteva sentir che disprezzo della sua stessa generosità. S’era spogliato d’ogni prestigio, d’ogni prerogativa, per subir la stessa sorte d’uno sconfitto, che delle sue doti, dei suoi meriti non aveva saputo avvalersi per farsi uno stato, per imporsi, come avrebbe potuto, alla considerazione altrui. Non pietà, ma dispetto poteva ispirare Roberto Auriti. Che se pure egli, navigando alla ventura, lo aveva gittato con sé in quei frangenti, non meritava certo quel naufrago che Corrado Selmi, già quasi scampato, si ributtasse in mare per perire con lui: non lo meritava, perché non aveva saputo mai vivere, quell’uomo, mai disimpacciarsi da ostacoli anche lievi: era già per se stesso un annegato, a cui tante e tante volte egli aveva gettato una corda per ajutarlo a trarsi in salvo. L’unica volta che quest’uomo s’era messo a dar lui ajuto, ecco, con la stessa mano che gli aveva teso, lo tirava con sé nel baratro, giù, giù, costringendolo a rinunziare al salvataggio altrui. E quel suo fratello corso in Sicilia per salvare entrambi, ma sì! tutti dovevano stare ad aspettare che andasse e ritornasse col denaro! a comodo! senza fretta! e dopo avere svelato tutto a Lando Laurentano! imbecille! Ecco: per questo solo fatto, egli avrebbe potuto fare a meno d’esporsi per coprire un inetto. Ma ormai…
Arrivato in via delle Colonnette, salendo la scala semibuja, incontrò Olindo Passalacqua che scendeva gli scalini a quattro a quattro.
– Ah! giusto lei, onorevole! Correvo in cerca di lei… Dica, che c’è? che c’è?
– Vento, – rispose Corrado Selmi, placidamente.
Olindo Passalacqua restò come un ceppo.
– Vento? Che dice? Quella denunzia infame? Ma come? chi è stato? roba da sputargli in faccia! Andate a far l’Italia per questa canaglia!
Corrado Selmi gli prese il mento fra due dita:
– Bravo, Olindo! Nobili sensi, invero… Sù, andiamo!
– Aspetti, onorevole, – pregò il Passalacqua, trattenendolo. – La prevengo! Nanna mia non sa ancora nulla. Non sapevamo nulla neanche noi. Per combinazione a mio cognato Pilade càpita tra le mani il giornale di due giorni fa… apre e vede… ce lo manda sù, segnato… Roberto stava ad annaffiare i fiori in terrazzo… legge, casca dalle nuvole… Ma ci si crede? un uomo, un uomo come lui, non leggere i giornali, in un momento come questo? Capisce? come quell’uccello… qual è? che caccia la testa nella rena… E gliene compro tre, sa? ogni sera: tre giornali! Ne leggesse uno! Appena lo apre, si mette a pisolare; e poi dice che li ha letti tutti e tre e che dorme poco!
– Lo struzzo, – disse Corrado Selmi. – Permetti?
E alzò le mani per aggiustare sotto la gola a Olindo Passalacqua la cravatta rossa sgargiante, annodata a farfalla.
– Lo struzzo, – ripetè. – Quell’uccello che dicevi… Così va bene!
Olindo Passalacqua restò di nuovo a bocca aperta.
– Grazie, – disse. – Ma dunque… dunque possiamo star tranquilli?
Corrado Selmi lo guardò negli occhi, serio; gli posò le mani sugli omeri, e:
– Non sei censore tu? – gli domandò.
– Censore… già, – rispose perplesso, quasi non ne fosse ben sicuro, il Passalacqua.
– E dunque lascia crollare il mondo! – esclamò il Selmi con un gesto di noncuranza sdegnosa. – Censore, te ne impipi. Sù, sù, vieni sù con me.
Trovarono Roberto abbattuto su una poltrona, con la faccia rivolta al soffitto, le braccia abbandonate, l’annaffiatojo accanto. Appena vide il Selmi, fece per balzare in piedi, e, arrangolando in una irrompente convulsione, andò a buttarglisi sul petto.
– Per carità! per carità! – scongiurò Olindo Passalacqua, correndo a chiudere l’uscio e accennando con le mani di far piano, che Nanna non sentisse di là.
Attraverso l’uscio chiuso, all’arrangolìo di Roberto sul petto di Corrado Selmi rispondeva di là il vocalizzo miagolante di una studentessa di canto. Corrado Selmi, gravato dal peso di Roberto, stette un po’ a guardare i cenni del Passalacqua, che seguitava a implorar carità per il cuore malato della sua povera moglie, carità per Roberto così perduto, carità per la casa che sarebbe andata a soqquadro; e scattò alla fine, scrollandosi, in una risata pazzesca:
– Ma da’ qui! – disse, ghermendo l’annaffiatojo e avviandosi di furia al terrazzo. – Ma che facciamo sul serio? Annaffiavi? E seguitiamo ad annaffiare! Qua… qua… così! così! Pioggia, Olindo! pioggia! pioggia!
E una vera pioggia furiosa si rovesciò dalla mela dell’annaffiatojo addosso a Olindo Passalacqua, che prese a fuggire per il terrazzo, gridando e riparandosi con le mani la testa, inseguito dal Selmi che seguitava a ridere, dicendo:
– Io passo l’acqua, tu passi l’acqua, egli passa l’acqua, tutti passiamo l’acqua!
– Oh Dio! per carità… no! caro… noooo… ma che fa? basta… per carità… non è scherzo! basta… uuuh… basta!…
Alle grida, sopravvennero Nanna, la studentessa di canto, Antonio Del Re e Celsina. Subito Corrado Selmi, ansante, corse a stringere la mano alla signora Lalla che rideva, guardando il marito che si scrollava come un pulcino bagnato. Ridevano anche le due giovinette.
– La pianta, Nanna mia, – gridò il Selmi, – quale è la pianta più utile? Il riso! Coltiviamo il riso e annacquiamo Olindo che fa ridere!
– Ma io piango, invece… – gemette il Passalacqua.
– E appunto perché piangi, fai ridere! – ribattè il Selmi.
– Chi fa ridere, invece… – brontolò Antonio Del Re, serrando le pugna.
– Fa piangere, è vero? – compì fa frase il Selmi. – Bravo, giovanotto! Sempre serio! Tu le tue sciocchezze lé farai sempre sode, bene azzampate e con tanto di grugno. Noi, le nostre… qua, censore… ballando, ballando… Sù, di là, Nanna, di là… al pianoforte! Lei suona, e noi balliamo! Roberto si metterà i calzoncini con lo spacco di dietro e la falda della carnicina fuori; prenderà la sciaboletta e il cavalluccio di legno, quelli con cui giocò alla guerra, al Sessanta; gli faremo l’elmo di carta, e si metterà a girare attorno… arri!… arri!… mentre io e Olindo balleremo al suono dell’inno di Garibaldi… Va’ fuori d’Italia… va’ fuori d’Italia… va’ fuori d’Italia… va’ fuori, o stranier!
Non aveva finito l’ultima battuta, che su la soglia del terrazzo si presentò, con gli occhi ilari e lagrimosi, raggiante di commossa beatitudine, Mauro Mortara, con le medaglie sul petto e lo zainetto dietro le spalle. Appena lo vide, Corrado Selmi fece un gesto d’orrore e scappò via per l’altro finestrone che dava sul terrazzo, gridando:
– Ah perdio, no! Questo poi è troppo!
Roberto Auriti gli corse dietro per trattenerlo:
– Corrado! Corrado!
Mauro Mortara, a quella fuga, restò come smarrito davanti allo stupore della signora Lalla, del Passalacqua e della studentessa di canto, alla meraviglia sorridente di Celsina e a quella ingrugnita di Antonio Del Re.
– Vengo, se non c’è offesa, – disse, – a salutare don Roberto. Parto domani.
– Ma chi siete? – gli domandò la signora Lalla, come se avesse davanti un abitante della luna, piovuto dal cielo.
– Sono… – prese a rispondere Mauro Mortara; ma s’interruppe riconoscendo Antonio Del Re. – Non siete il nipote di donna Caterina, voi?
E, pronunziando questo nome, si levò il cappello.
– Diteglielo voi, – soggiunse, – chi sono io. Sono venuto due altre volte; non mi hanno fatto salire, perché don Roberto non era in casa.
Il Passalacqua, tutto bagnato, gli s’accostò, gli sbirciò le medaglie sul petto, e:
– Patriota siciliano? – domandò. – Ai patrioti siciliani, perdio, statue d’oro! sta… statu… statue… .
Uno starnuto, tardo a scoppiare, lo tenne un tratto a bocca aperta, le nari frementi, le mani tese corne a pararlo; finalmente scoppiò e:
– D’oro! – ripetè il Passalacqua. – Mannaggia il Selmi che m’ha fatto raffreddare! Ma perché è scappato? Che è pazzo?… Guardate come mi… mi ha… ma dove è andato?
– Roberto! – strillò a questo punto la signora Lalla, accorrendo dal terrazzo nella stanza, attraverso la quale il Selmi era poc’anzi fuggito.
Rientrarono tutti, spaventati, dietro a lei.
Un estraneo, col cappello in mano e gli occhi bassi, stava rigido su la soglia di quella camera, mentre Roberto, col viso terreo, chiazzato qua e là, si guardava attorno, convulso, indeciso. Al grido di lei, protese le mani, ma come per impedire il prorompere della sua più che dell’altrui commozione.
– Vi prego, vi prego, – disse, – senza chiasso… Nulla… Una… una chiamata in questura…
– Lo arrestano! – fischiò allora tra i denti Antonio Del Re, col volto scontraffatto e tutto vibrante.
Nanna cacciò uno strillo e cadde in convulsione tra le braccia del marito.
– Lo arrestano? – domandò Mauro Mortara, facendosi innanzi, mentre Roberto Auriti cercava nella camera gli abiti da indossare e con le mani accennava a tutti di non gridare, di non far confusione.
– Come? – seguitò Mauro, guardando Antonio Del Re.
Non ottenendo risposta da nessuno, andò incontro a quell’estraneo e, levando un braccio, lo apostrofò:
– Voi! voi siete venuto qua ad arrestare don Roberto Auriti?
– Mauro! – lo interruppe questi. – Per carità, Mauro… lascia!
– Ma come? – ripetè Mauro Mortara, rivolgendosi a Roberto. – Arrestano voi? Perché?
Roberto accorse a dare una mano al Passalacqua, alla studentessa di canto, a Celsina, che non riuscivano a sorreggere la signora Lalla, la quale si dibatteva e si scontorceva, tra urli, singhiozzi, gemiti e risa convulse.
– Di là, per carità, di là, portatela di là! – scongiurò.
Ma non fu possibile. Il Passalacqua, invece di avvalersi dell’ajuto di Roberto, pensò bene di buttargli le braccia al collo, rompendo in singhiozzi ed esclamando:
– Cireneo! Cireneo! Cireneo!
Roberto si divincolò, quasi con schifo, e si turò gli orecchi, mentre il Passalacqua, rivolto a Mauro Mortara, seguitava:
– Patriota, vedete? così l’Italia compensa i suoi martiri! così.
– Il figlio di Stefano Auriti! – diceva tra sé Mauro Mortara, con gli occhi sbarrati, battendosi una mano sul petto. – Il figlio di donna Caterina Laurentano!… E dovevo veder questo a Roma? Ma che avete fatto? – corse a domandare a Roberto, afferrandolo per le braccia e scotendolo. – Ditemi che siete sempre lo stesso! Sì? E allora…
Si afferrò con una mano le medaglie sul petto; se le strappò; le scagliò a terra; vi andò sopra col piede e le calpestò; poi, rivolgendosi al delegato:
– Ditelo al vostro Governo! – gridò. – Ditegli che un vecchio campagnuolo, venuto a veder Roma con le sue medaglie garibaldine, vedendo arrestare il figlio d’un eroe che gli morì tra le braccia nella battaglia di Milazzo, si strappò dal petto le medaglie e le calpestò! così!
Tornò a Roberto, lo abbracciò, e sentendolo singhiozzare su la sua spalla:
– Figlio mio! figlio mio! – si mise a dirgli, battendogli dietro una mano.
A questo punto, Antonio Del Re scappò via dalla camera, mugolando e rovesciando nella furia una seggiola. Celsina, che lo spiava, gli corse dietro, sgomenta, chiamandolo per nome. Mauro Mortara si voltò felinamente, come se a quell’uscita precipitosa gli fosse balenato in mente che si volesse impedire comunque l’arresto; e si mostrò pronto a qualunque violenza. Sciolto dall’abbraccio di lui, Roberto Auriti si fece innanzi al delegato:
– Eccomi.
– No! – gridò Mauro, riafferrandolo per un braccio. – Don Roberto! Così vi consegnate?
– Ti prego, lasciami… – disse Roberto Auriti; e, rivolgendosi al delegato: – Lei scusi…
Con la mano chiamò Nanna, che fiatava ora a stento, con ambo le mani sul cuore, e la baciò in fronte, dicendole:
– Coraggio…
– E che dirò a vostra madre? – esclamò allora Mauro agitando le mani in aria.
Roberto Auriti si gonfiò, si portò le mani sul volto per far argine all’impeto della commozione e andò via, seguito dal delegato, mentre la signora Lalla, sostenuta dal marito e dalla studentessa di canto, riprendeva più a gemere che a gridare:
– Roberto! Roberto! Roberto!
Mauro Mortara restò a guatare, come annichilito. Quando il Passalacqua lo ragguagliò di tutto, e, fresco della recente lettura del giornale, gli espose tutta la miseria e la vergogna del momento:
– Questa, – disse, – questa è l’Italia?
E, nel crollo del suo gran sogno, non pensò più a Roberto Auriti, all’arresto di lui, non sentì, non vide più nulla. Le sue medaglie rimasero lì per terra, calpestate.
Uscendo dalla casa di Roberto, Corrado Selmi s’imbatté per le scale nel delegato e nelle guardie che salivano ad arrestar l’innocente. Si fermò un istante, indeciso; ma subito si sentì occupare il cervello da una densa oscurità, e in quella tenebra d’ira e d’angoscia udì una voce che dal fondo della coscienzalo ammoniva ch’egli non poteva in alcun modo sul momento impedire quell’atroce ingiustizia. Seguitò a scendere la scala; rimontò in vettura e provò quasi stupore alla domanda del vetturino, ove dovesse condurlo. Ma a casa; c’era bisogno di dirlo? dove poteva più andare? che più gli restava da fare?
– Via San Niccolò da Tolentino.
E, come se già vi fosse, si vide per le scale della sua casa: ecco, entrava in camera; si recava all’angolo, ov’era uno stipetto a muro, di lacca verde; lo apriva; ne traeva una boccetta, e… Istintivamente, s’era cacciata una mano nel taschino del panciotto, ov’era la chiave di quello stipetto. Cosa strana: pensava ora allo specchio, a un piccolo specchio ovale, appeso accanto a quello stipetto, al quale egli non avrebbe dovuto volger lo sguardo, per non vedersi. Ma pure, ecco, si vedeva: sì, in quello specchio, con la boccetta in mano: vedeva l’espressione dei suoi occhi, ridente, quasi non credessero ch’egli avrebbe fatto quella cosa. No! Prima doveva scrivere e suggellare una dichiarazione per l’Auriti: poche righe, esplicite. Non meritavano gli accusatori un suo ultimo sfogo. Due righe soltanto, per salvar l’amico, già in carcere.
I nemici… – ma quali? quanti erano? Tutti! Possibile? Tutti gli amici di jeri. Tutti e nessuno, a prenderli a uno a uno. Ché nulla egli aveva fatto a nessuno di loro perché le liete accoglienze di jeri si convertissero così d’un tratto in tanta alienazione d’animi, in tanta ostilità. Ma era il momento, la furia cieca del momento, che s’abbatteva su lui, che in lui trovava la preda, e lo abbrancava, ecco, e lo sbranava in un attimo.
Ah come andava lenta quella vettura! Parve a Corrado Selmi ch’essa gli prolungasse con feroce dispetto l’agonìa.
– Non sono in casa per nessuno, – disse a Pietro, il vecchio servo che stava da tanti anni con lui.
E il primo suo moto, entrando in camera, fu verso quello stipetto. Si trattenne. Pensò alla dichiarazione da scrivere. Ma pur volle prendere prima la boccetta e, senza guardarla, la recò con sé alla scrivania dello studio. Restò un pezzo lì in piedi, come sospeso in cerca di qualche cosa che s’era proposto di fare e a cui non pensava più. Istintivamente, pian piano, rientrò nella camera; gli occhi gli andarono al piccolo specchio ovale, appeso alla parete presso lo stipetto. Aveva dimenticato di guardarsi lì. Scrollò le spalle e tornò indietro, alla scrivania; sedette; trasse dalla cartella un foglio e una busta; guardò se su la scrivania ci fosse il cannello di ceralacca e il sigillo; si alzò di nuovo e rientrò nella camera per prendere dal tavolino da notte la bugia con la candela.
La dichiarazione gli venne men breve di quanto aveva divisato, poiché a maggior salvaguardia dell’innocenza dell’Auriti pensò di chiamare in testimonio lo stesso governatore della banca, già anche lui tratto in arresto, col quale, prima di contrarre sott’altro nome quel debito, si era segretamente accordato. Finito di scrivere, guardò su la scrivania la boccetta, e sentì mancarsi a un tratto la voglia di rileggere quanto aveva scritto. Gli parvero enormi tutte le piccole cose che gli restavano ancora da fare: piegare in quattro quel foglio; chiuderlo nella busta; accendere la candela; bruciarvi il cannello di ceralacca: apporre i sigilli… Si diede a far tutto con esasperazione. Ansava; le dita, senza più tatto, gli ballavano. Stava per chiudere la busta, quando giù dalla via scattò stridulo, sguajato, il suono d’un organetto. Parve al Selmi che quel suono, in quel punto, gli spaccasse il cranio: si turò gli orecchi, balzò in piedi, contrasse tutto il volto come per uno strazio insopportabile, fu per avventarsi alla finestra a scagliare ingiurie a quel sonatore ambulante. Ah no, perdio! così, no! al suono d’una canzonetta napoletana, no, no, no. Si sentì avvilito da tutta quella furia. O che era un ladro davvero? Piano, piano, senza tremor di mani, senza quell’aridezza in bocca; dopo aver sedato i nervi, e sorridente, egli doveva uccidersi, come a lui si conveniva. Prese la busta con la dichiarazione e la cacciò dentro la cartella; si pose in tasca la boccetta del veleno. Voleva uscir di nuovo, per un’ultima passeggiata, per salutar la vita, scevro ormai d’ogni cura, esente d’ogni peso, libero d’ogni passione, con occhi limpidi e animo sereno; salutar la vita, col suo lieve antico sorriso; bearsi per l’ultima volta delle cose che restavano, liete in quel giorno di sole, ignare in mezzo al torbido fluttuare di tante vicende che presto il tempo avrebbe travolte con sé. Ridiscese in istrada, fe’ cenno a un vetturino d’accostarsi e si fece condurre al Gianicolo. Dapprima, come in preda a quello stordimento rombante cagionato da un improvviso otturarsi degli orecchi, non potè avvertire, né vedere, né pensar nulla; solo quando passò con la vettura per la via della Lungara, innanzi le carceri di Regina Coeli, pensò che forse a quell’ora Roberto Auriti vi era rinchiuso; ma non volle affliggersene più. Tra poco, con quella sua dichiarazione, ne sarebbe uscito, per seguitare la sua incerta e penosa esistenza tra quella sua signora Lalla e il Passalacqua e il Bonomè, mentre egli, invece – ah! si sarebbe liberato!
Giunto in cima al colle, gli parve davvero una liberazione quell’altezza, da cui potè contemplare Roma luminosa nel sole, sotto l’azzurro intenso del cielo; liberazione da tutte le piccole miserie acerbe che laggiù lo avevano offeso e soffocato; dall’urto di tutte le meschine volgarità quotidiane; dalle fastidiose risse dei piccoli uomini che volevano contendergli il passo e il respiro. Si sentì lassù libero e solo, libero e sereno, sopra tutti gli odii, sopra tutte le passioni, sopra e oltre il tempo, inalzato, assunto a quella altezza dal suo grande amore per la vita ch’egli difendeva, uccidendosi. E in esso e con esso si sentì puro, in un attimo, per sempre. Nell’eternità di quell’attimo si cancellarono, sparvero assolte le sue debolezze, i suoi trascorsi, le sue colpe, già che egli era pure stato un uomo e soggetto a contrarie necessità. Ora, con la morte, le avrebbe vinte tutte. Restava solo, in quel punto, luminoso indefettibile immortale il suo amore per la vita, l’amore per la sua terra, per la sua patria, per cui aveva combattuto e vinto. Sì, come i tanti che avevano avuto lassù, in difesa di Roma, una bella morte, troncati nel frenetico ardore della gioventù e resi immuni di tutte le miserie, liberi di tutti gli ostacoli che forse nel tempo li avrebbero deformati e avviliti. Ora in quel momento anch’egli, spogliandosi di tutte le miserie, liberandosi di tutti gli ostacoli, acceso e vibrante dell’ardore antico, con negli occhi l’oro dell’ultimo sole su le case della grande città quadrata, si foggiava com’essi una bella morte, una morte che lo inalzava a se stesso, senza invidia per quelli effigiati e composti lassù per la gloria in un mezzo busto di marmo. Pensò che aveva con sé la boccetta del veleno; ma no! a casa! a casa! tranquillamente, sul suo letto: senza dare spettacolo! E ridiscese alla città. Ridisceso, gli parve di aver lasciato la propria anima lassù, nel sole. Qua, nell’ombra, era il corpo ancor vivo, per poco. Si guardò le mani, le gambe, e provò subito un brivido d’orrore. Ma, come se di lassù una voce severamentelo richiamasse, egli si riprese e a quella voce rispose che sì, quel suo corpo, egli lo avrebbe tra poco ucciso, senza esitare.
Passato il ponte di ferro, udì strillare da alcuni giornalaj un’edizione straordinaria del foglio più diffuso di Roma. Pensò che fosse per lui, e fece fermar la vettura; comprò quel foglio. Difatti, in prima pagina era il resoconto della seduta parlamentare, e nella sesta colonna spiccava in cima il suo nome
CORRADO SELMI
come titolo dell’articolo del giorno. Prese a leggerlo; ma presto n’ebbe un fastidio strano: avvertì che quello era già per lui un linguaggio vuoto e vano, che non aveva più alcun potere di muovere in lui alcun sentimento, quasi fatto di parole senza significato. Gli parve che lo scrittore di quell’articolo non avesse altra mira che quella di dimostrare che egli era vivo, ben vivo, e che, come tale, poteva e sapeva giocare con le parole, perché gli altri vivi, i lettori, potessero dire: «Guarda com’è bravo! guarda come scrive bene!». Quel foglio, così leggero, gli parve a un tratto, con quel suo nome stampato lì in cima, una lapide, la sua lapide, ch’egli stesso per uno strano caso si portasse in carrozza, diretto alla fossa; strana lapide, in cui, anziché le solite lodi menzognere, fossero incise accuse e ingiurie. Ma che importavano più a lui? Era morto.
Voltò la pagina del giornale. Subito gli occhi gli andarono su un’intestazione a grossi caratteri, che prendeva cinque colonne di quella seconda pagina:
L’ECCIDIO D’ARAGONA IN SICILIA
e sotto, a caratteri più piccoli: Gli operaj delle zolfare in rivolta – L’assalto alla vettura dell’ingegnere minerario Costa – Scene selvagge – Lo uccidono con la moglie del deputato Capolino e bruciano i cadaveri.
Corrado Selmi restò, oppresso d’orrore e di ribrezzo, con gli occhi fissi su quelle notizie. Comprese che per esse e non per lui era uscita quell’edizione straordinaria del giornale. La moglie del deputato Capolino? Egli l’aveva veduta a Girgenti, quando vi si era recato per sostenere la candidatura di Roberto Auriti e assistere il Verònica nel duello col marito di lei. Bellissima donna… Uccisa? E come si trovava in vettura, ad Aragona, con quell’ingegnere? Ah, partita da Roma con lui… Una fuga?… Era l’ingegnere del Salvo… Gli operaj delle zolfare si recavano in colonna dal paese alla stazione, risoluti a non farlo entrare, se da Roma non portava l’assicurazione che le promesse sarebbero state mantenute… Oh, guarda… quel Prèola… Marco Prèola, quel miserabile che Roberto Auriti aveva scaraventato contro l’uscio a vetri della redazione del giornalucolo clericale… capitanava lui, adesso, quella turba selvaggia di facinorosi… li incitava all’assalto della vettura, al macello. Ah, vili! colpire una donna… Il Costa sparava… e allora…
Il Selmi non potè leggere più oltre; restò, nel raccapriccio, col giornale aperto tra le mani, come soffocato da quella strage; gli parve di sentirsi investito dal feroce affanno di tutto un popolo inselvaggito. Appallottò in un impeto di schifo il foglio e lo scagliò dalla vettura. Domani, o la sera di quello stesso giorno, in una nuova edizione straordinaria esso avrebbe annunziato con quei grossi caratteri il suicidio di lui.
Rientrando in casa, da Pietro, il vecchio servo, fu avvertito che c’era in salotto il nipote dell’Auriti, Antonio Del Re.
– Sta bene, – disse. – Lo farai entrare nello studio, appena sonerò.
Forse Pietro si aspettava una riprensione per aver fatto entrare quel giovanotto, e aveva pronta la risposta, che questi cioè s’era introdotto di prepotenza in casa, non ostante che lui già una prima volta gli avesse detto che il padrone non c’era e avesse fatto poi di tutto per impedirgli il passo. Aprì le braccia e s’inchinò al reciso ordine del Selmi; ma, come questi s’avviò per la sua camera, rimase perplesso, se non lo dovesse prevenire circa al contegno minaccioso e all’aspetto stravolto di quel giovanotto. Socchiuse gli occhi, si strinse nelle spalle, come per dire: «L’ordine è questo!» e si recò nel salotto per tener d’occhio quell’insolente visitatore.
– Ecco – gli disse, indicando con una mossa del volto l’uscio di fronte. – Adesso, appena suona…
Antonio Del Re non stava più alle mosse; friggeva. Il viso, nello spasimo dell’attesa terribile, gli si scomponeva. Teneva una mano irrequieta in tasca. E il vecchio servo gli guatava quella mano che, dentro la giacca, pareva brancicasse un’arma. Il suono del campanello, intanto, tardava; e più tardava, più cresceva l’ansito, invano dissimulato, del giovine e l’irrequietezza di quella mano. Il vecchio servo, ormai al colmo della costernazione, si accostò all’uscio, vi si parò davanti, appena a tempo, ché allo squillo del campanello Antonio Del Re s’avventò all’uscio come una belva con un pugnale brandito, trascinandosi dietro nella furia il vecchio che lo teneva abbrancato.
Corrado Selmi, pallidissimo, seduto innanzi alla scrivania, col bicchiere ancora in mano, da cui aveva bevuto or ora il veleno della boccetta rovesciata presso la cartella, si volse e arrestò d’un tratto con uno sguardo gelido e un sorriso appena sdegnoso, tremulo su le labbra, la violenza del giovine.
– Non t’incomodare! – gli disse. – Vedi? Ho fatto da me… Lascialo! – ordinò al servo. – E ti proibisco di gridare o di correre a soccorsi.
Prese dalla scrivania la busta sigillata e la mostrò al giovine che ansimava e mirava, ora, allibito.
– Tu butti male, ragazzo, – gli disse. – Hai una trista faccia… Ma sta’ tranquillo: questa busta è per tuo zio. Sarà liberato. Lasciala stare qua.
Posò di nuovo la busta su la scrivania; strizzò gli occhi; serrò i denti; s’interi, mentre nel pallore cadaverico il viso gli si chiazzava di lividi. Fece per alzarsi; il servo accorse a sostenerlo.
– Accompagnami… al letto…
Si voltò al Del Re, con gli occhi già un po’ vagellanti. Quasi l’ombra d’un sorriso gli tremò ancora nella faccia spenta. E disse con strana voce:
– Impara a ridere, giovanotto… Va’ fuori: oggi è una bellissima giornata.
E scomparve dall’uscio, sostenuto dal servo.
Come da via delle Colonnette, all’arresto di Roberto Auriti, Antonio Del Re era scappato alla casa del Selmi, così, ma con altro animo, Mauro Mortara era corso in cerca di Lando Laurentano. Al villino di via Sommacampagna, Raffaele il cameriere gli aveva detto che il padrone, letta nel giornale la notizia di quell’eccidio avvenuto in Sicilia, dalle parti di Girgenti, era saltato in vettura, diretto alla casa dei Velia.
– E dov’è? Come faccio a trovar la via?
– Se volete, in vettura vi ci accompagno io.
In vettura, vedendolo affannato e smanioso d’arrivare, gli aveva chiesto se conosceva quella signora e quell’ingegnere.
– Che signora? che ingegnere?
– Come? Non avete inteso? Non sapete nulla? Li hanno assassinati ad Aragona…
– Ad Aragona?
– I solfaraj.
– Ma dunque…
E s’era interrotto, con un balzo, per guardar prima fiso in faccia, con occhi stralunati, il cameriere, poi dalla vettura la gente che passava per via, quasi tutt’a un tratto assaltato dal dubbio che una gran catastrofe fosse accaduta, senza ch’egli ne sapesse nulla.
– Ma dunque, che succede? Tutto sottosopra? Là ammazzano! Qua arrestano! Sapete che hanno arrestato don Roberto Auriti?
– Il cugino del padrone?
– Il cugino! il cugino! E lui se ne va dai Velia! Gli arrestano il cugino, don Roberto Auriti, uno dei Mille, che al Sessanta aveva dodici anni, e combatteva! E suo padre mi morì fra le braccia, a Milazzo… Arrestato! Sotto gli occhi miei! A questo, a questo mi dovevo ritrovare!
S’era messo a gridare in vettura e a gesticolare e a pianger forte; e tutta la gente, a voltarsi, a fermarsi, a commentare, nel vederlo così stranamente parato, con quello zainetto dietro le spalle, in fuga su quella vettura e vociferante.
– Statevi zitto! statevi zitto!
Ma che zitto! Voleva giustizia e vendetta Mauro Mortara di quell’arresto; e come Raffaele, per farlo tacere, gli parlò della visita che, alcuni giorni addietro, forse per questo don Giulio, il fratello di don Roberto, aveva fatto al padrone:
– Ma sicuro! – gridò, sovvenendosi. – C’ero io! c’ero io! E l’ho visto piangere. Per questo, dunque, piangeva quel povero figliuolo? Voleva ajuto… E dunque… e dunque don Landino gliel’ha negato? possibile?
– Forse perché la somma era troppo forte…
– Ma che troppo forte mi andate dicendo! Quando si tratta dell’onore d’un patriota! E lui è ricco! E sua zia non ebbe nulla dei tesori del padre, ché si prese tutto il fratello maggiore… Oh Dio! Dio! Donna Caterina… l’unica degna figlia di suo padre… Ora donna Caterina ne morrà di crepacuore… Ma se è vero questo, per la Madonna, che gli ha negato ajuto, non lo guardo più in faccia, com’è vero Dio! Non ci credo! non ci voglio credere!
Arrivato in casa Velia, però, vi trovò tale scompiglio, che non potè più pensare a domandar conto a Lando dell’arresto di Roberto Auriti. Dianella Salvo, la sua amicuccia donna Dianella, la sua colomba, che in quel mese passato a Valsanìa aveva saputo avvincerlo e intenerirlo con la grazia soave degli sguardi e della voce, nel vederlo entrare aggrondato e smarrito nel salone, gli si precipitò subito incontro quasi con un nitrito di polledra spaurita, e gli s’aggrappò al petto, tutta tremante, affondandogli la testa scarmigliata entro la camicia d’albagio, quasi volesse nascondersi dentro di lui, e gridando, con una mano protesa indietro, verso il padre:
– Il lupo!… Il lupo!
Mauro Mortara, così soprappreso, frugato nel petto da quella fanciulla in quello stato, levò il capo, sbalordito, a cercar negli occhi degli astanti una spiegazione: mirò visi sbigottiti, afflitti, piangenti, mani alzate in gesti di timore, di riparo, di pena e di maraviglia. Non comprese che la fanciulla fosse impazzita. Le prese il capo tra le mani e provò di scostarselo dal petto per guardarla negli occhi:
– Figlia mia! – disse. – Che vi hanno fatto? che vi hanno fatto? Ditelo a me! Assassini… Il cuore… hanno strappato il cuore… Il cuore anche a me!
Ma, come potè vederle gli occhi e la faccia disfatta, stravolta, aperta ora a uno squallido riso, con un filo di sangue tra i denti, inorridì: guatò di nuovo tutti in giro e, riponendosi sul petto il capo di lei e lasciandovi sui capelli scarmigliati la mano in atto di protezione e di pietà:
– Come la madre? – disse in un brivido, e addietro spinto dalla fanciulla che, seguitando sul petto di lui quell’orribile riso come un nitrito, con ansia frenetica lo incitava:
– Da Aurelio… da Aurelio…
Accorse, col volto inondato di lagrime, la cugina Lillina, mentre in fondo al salone Lando Laurentano e don Francesco Velia cercavano di far coraggio a Flaminio Salvo che, a quella scena, s’era nascosto il volto con le mani, imprecando.
– Sì, Dianella, sii buona! sii buona! Ora lui ti porterà… ti porterà dove tu vuoi… sii buona, cara, sii buona! da Aurelio!
Ma Dianella, sentendo la voce del padre, invasa di nuovo dal térrore, aveva ripreso ad affondar la testa sul petto di Mauro e a riaggrapparsi a lui più freneticamente, urlando:
– Il lupo!… il lupo!…
– Ci sono qua io! Dov’è il lupo? – le gridò allora Mauro, ricingendola con le braccia. – Non abbiate paura! Ci sono io, qua!
– Vedi? c’è lui, ora! c’è lui! – le ripeteva Lillina. E anche Ciccino e la zia Rosa le si fecero attorno a ripetere:
– C’è lui! Vedi che è venuto per te? per difenderti, cara…
Levò, felice e tremante, il volto, appena appena, la poverina, a mostrare un sorriso di riconoscenza, e seguitò a spinger Mauro verso la porta:
– Sì… sì… da Aurelio… da Aurelio…
Strozzato dalla commozione Mauro, così respinto indietro, tra quella gente che non conosceva e gli si stringeva attorno, domandò con rabbia:
– Ma insomma, che è? com’è stato? che dice? dice Aurelio? Chi è? Il figlio di don Leonardo Costa? Ah, è lui… quello che hanno assassinato?
Con gli occhi, con le mani, tutti gli facevano cenno di tacere, e qualcuno gli rispondeva chinando il capo.
– Lo amava? Oh figlia…
Lando Laurentano e don Francesco Velia si portarono via di là Flaminio Salvo.
– Ditemi, ditemi che vi hanno fatto, – seguitò Mauro rivolto a Dianella, con tenerezza quasi rabbiosa. – Ora andiamo da Aurelio… Ma ditemi che vi hanno fatto! Chi è il lupo, che lo ammazzo? Chi è il lupo? – domandò agli altri con viso fermo.
Ma nessuno sapeva con certezza che cosa fosse accaduto, a chi veramente alludesse Dianella con quel suo grido. Pareva al padre, ma poi, chi sa? Forse lo scambiava per un altro. Era stato lì, durante la loro assenza, Ignazio Capolino. Dianella era rimasta in casa, lei sola, perché si sentiva poco bene; e certo sopra di lei Capolino, senza misericordia, forsennato per l’orrenda sciagura, aveva dovuto rovesciar la furia della sua disperazione. Ciccino e Lillina, che erano stati i primi a rincasare, gli avevano sentito gridare:
– Tuo padre! tuo padre, capisci?
Ma al loro entrare, quegli era scappato via, furibondo, lasciando questa poveretta come insensata, come intronata da tanti colpi spietati alla testa, e, subito dopo, dando segni di terrore, s’era messa a urlare: – Il lupo!… il lupo!…
Che le aveva detto Capolino?
Uno solo poteva saperlo, così bene come se fosse stato presente alla scena: Flaminio Salvo, che di là, tra Lando Laurentano e il cognato Francesco Velia, sentiva prepotente il bisogno di confessare il suo rimorso, ma che tuttavia, senza che potesse impedirlo, si scusava accusandosi.
Francesco Velia gli aveva domandato, se si fosse mai accorto che la figliuola amava il Costa.
– Se tu non lo sapevi!
– Io lo sapevo. Ma potevo io, io padre, profferire la mia figliuola a un mio dipendente? Quel disgraziato, lui, non se n’era mai accorto, per la modestia della mia figliuola, e perché a lui stesso non poteva passare per il capo una tal cosa; tanto più che, da un pezzo, era invescato nella passione per quell’altra disgraziata… Ma il torto è mio, il torto è mio: io non ho scuse! Nessuno meglio di me può sapere che il torto è mio! Avevo beneficato quel povero giovine, come avevo beneficato tutti coloro che laggiù lo hanno assassinato! Qual altro frutto poteva recare il beneficio? Il Costa era cresciuto a casa mia, come un figliuolo; e quella mia povera ragazza… Ma sì, certo! E io, io vedevo bene la necessità che il male da me fatto in principio, beneficando, si dovesse compiere con un matrimonio; però, lo confesso, mi ripugnava, e cercavo d’allontanarlo quanto più mi fosse possibile. Ma, vedete: intanto, avevo richiamato quel figliuolo dalla Sardegna, e lo avevo assunto alla direzione delle zolfare d’Aragona; e ora, qua a Roma, avevo detto al Capolino, che se il Costa fosse riuscito a domare quei bruti laggiù, io gli avrei dato in premio la mia figliuola. Notate questo: che dunque Capolino sapeva e, per conseguenza, sapeva anche la moglie, che questo era il mio disegno. Sì, è vero, sotto, avevo altre intenzioni, o piuttosto, una speranza… Signori miei, io potevo bene per la mia figliuola aspirare a ben altro… (e, così dicendo, fissò negli occhi Lando Laurentano). L’avevo perciò condotta a Roma e mi proponevo di lasciarla qua in casa di mia sorella, con la speranza che si distraesse da quella sua puerile ostinazione. Ebbene, la signora Capolino volle profittare di questa mia speranza per render vano quel mio disegno: volle partire col Costa per toglierlo per sempre alla mia figliuola. E il signor Capolino forse sperava che, sposo Aurelio, domani, di mia figlia e già amante di sua moglie, egli potesse seguitare a tenere un posto in casa mia. E ora, ora che tutto gli è crollato così d’un tratto, ha gridato a mia figlia, come mie, le sue macchinazioni! Ma io vi giuro, signori, che lo schiaccerò, lo schiaccerò… Seppure… ormai… ormai…
Scrollò le spalle, scartò con le mani quella sua minaccia come se ogni proposito gli désse ora un’invincibile nausea. E andò a buttarsi su una poltrona, come atterrito a mano a mano dal vuoto arido, orrido, che dopo quel lungo sfogo gli s’era fatto dentro.
Nulla: non sentiva più nulla: nessuna pietà, né affetto per nessuno. Un fastidio enorme, anzi afa, afa sentiva ormai di tutto, e specialmente della parte che doveva rappresentare, di padre inconsolabile per quella sciagura della figliuola, che invece non gli moveva altro che irritazione, ecco, e dispetto, e quasi vergogna, sì, vergogna. Quella smania folle della figliuola per l’innamorato lo rivoltava come alcunché di vergognoso. E si domandava, con bieca crudezza, se avesse mai amato veramente, di cuore, quella sua figliuola. No. Come per dovere l’aveva amata. E ora che questo dovere gli si rendeva così grave e penoso, non poteva provarne altro che uggia e nausea. Ma sì, perché era anche fatalmente condannata quella sua figliuola! Non era pazza la madre? E ormai, tutto quello che poteva accadergli, ecco, gli era accaduto. La misura era colma, e basta ormai! Lo sterminio della sorte su la sua esistenza era compiuto; in quel vuoto arido, orrido, restava padrone, senza più nulla da temere. La morte non la temeva. E guardò il brillìo della grossa pietra preziosa dell’anello nel tozzo mignolo della sua mano pelosa, posata su la gamba. Quel brillìo, chi sa perché, gli richiamò un lembo delle carni di Nicoletta Capolino che laggiù quei bruti avevano arse. Sollevò il capo, con le nari arricciate. Ah come volentieri avrebbe fumato un sigaro! Ma pensò che non poteva fumare, perché in quel momento sarebbe sembrato scandaloso. Sentì che Francesco Velia diceva a Lando Laurentano:
– Ma sì, è certo: erano fuggiti! Partiti da quattro giorni, arrivavano allora appena ad Aragona… Dove erano stati in questi quattro giorni?
E interloquì, con altra voce, con altro aspetto, come se non fosse più quello di prima:
– Non c’è luogo a dubbio, – disse. – Già l’altro jeri da Napoli m’era arrivata una lettera del Costa, con la quale si licenziava da me. È andato dunque a morire per conto suo laggiù: e anche di questo, dunque, posso non aver rimorsi.
Entrò a questo punto Ciccino come sospeso e smarrito nell’ambascia della notizia che recava.
– Lando – disse esitante, – bisogna che ti avverta… Quel vecchio…
– Mauro?
– Ecco, sì… era venuto qua col tuo domestico a cercarti per… dice che… dice che hanno arrestato Roberto Auriti.
Lando impallidì, poi arrossì, aggrottando le ciglia come per un pensiero che, contro la sua volontà, gli si fosse imposto; si mostrò imbarazzato lì tra gente che aveva per sé una sciagura ben più grave. – Vada, vada, – s’affrettò a dirgli Flaminio Salvo, tendendogli una mano e posandogli l’altra su una spalla per accompagnarlo.
– Le auguro, – gli disse allora Lando, – che sia un turbamento passeggero questo della sua figliuola.
Flaminio Salvo socchiuse gli occhi e negò col capo:
– Non mi faccio illusioni.
E rientrarono nel salone, così, con le mani afferrate.
Mauro Mortara, già da un pezzo esasperato, soffocato, ancora con la povera fanciulla demente aggrappata al petto, non seppe trattenersi a quello spettacolo: si scrollò con un muggito nella gola, e gridò alle due donne che gli stavano attorno:
– Tenetela… prendetevela… Gli dà la mano… Non posso vederlo… Sapete come si chiama? Ha il nome di suo nonno: Gerlando Laurentano!
E, strappandosi dalle braccia di Dianella, scappò via.
Flaminio Salvo schiuse le labbra a un sorriso amaro, più di commiserazione derisoria che di sdegno: e, alle scuse che gli porgeva Lando Laurentano, rispose:
– Contagio… Niente, principe… La pazzia purtroppo è contagiosa…
| I vecchi e i giovani – Indice Introduzione |
|
| Parte I
Capitolo 1 |
Parte II
Capitolo 1 |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com