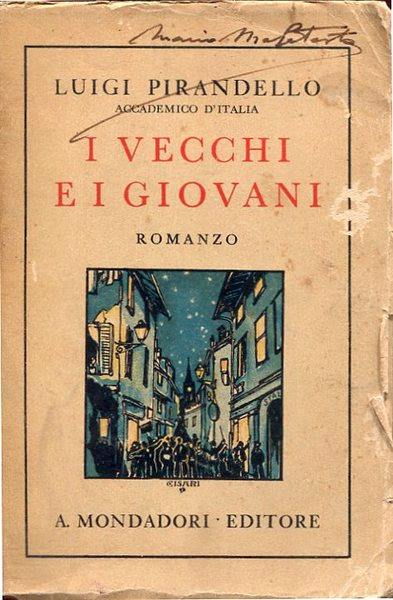««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «I Vecchi e i giovani» su Amazon
II.
Pregati da Flaminio Salvo, che dagli affari di banco e dai tanti altri negozii a cui attendeva non aveva mai un momento libero, Ignazio Capolino, già suo cognato, e Ninì De Vincentis, giovane amico di casa, scendevano il giorno dopo in carrozza da Girgenti a Valsanìa per dare le opportune disposizioni per la villeggiatura: incarico graditissimo all’uno e all’altro, per due diverse, anzi opposte ragioni.
I carri, sovraccarichi di suppellettile, erano partiti da un pezzo da Girgenti, e a quell’ora dovevano essere già arrivati a Valsanìa. Il discorso, tra i due in quella carrozza padronale del Salvo, era caduto su le proposte nozze di donna Adelaide, sorella di don Flaminio, col principe di Laurentano.
– No no: è troppo! è troppo! – diceva sogghignando Capolino. – Povera Adelaide, è troppo, dopo cinquant’anni d’attesa! Diciamo la verità!
Ninì De Vincentis batteva di continuo le pàlpebre, come per contenere nei begli occhi neri a mandorla il dispiacere per quella derisione. Nello stesso tempo, con l’atteggiamento del volto pallido affilato avrebbe voluto mostrare l’intenzione almeno d’un sorriso, per regger la célia e rispondere in qualche maniera all’ilarità pur così smodata e sconveniente di Capolino.
– Già, nozze per modo di dire! – seguitò questi, implacabile, lì che nessunolo sentiva (Ninì, il buon Ninì, pasta d’angelo, era men che nessuno). – Per modo di dire… perché, lasciamo andare! sarà bene, sarà male: la legge è legge, caro mio, e le opinioni politiche e religiose, se contano, contano poco di fronte a lei. Ora il principe, lo sai, conditio sine qua non, vuole che il matrimonio sia soltanto religioso, non ammette l’altro per le sue idee. Dunque, matrimonio senza effetti legali, mi spiego? Sarà una cosa bella, oh! gustosa… anche coraggiosa, non dico di no: ma quella povera Adelaide, via!
E Capolino si mise a ghignar di nuovo, come se nel suo concetto Adelaide Salvo non fosse la donna più adatta a quell’eroismo di nuovo genere che si richiedeva da lei, a quella sfida coraggiosa alla società civilmente costituita.
Ninì De Vincentis taceva e continuava a sbattere gli occhi, ancora con quel sorriso afflitto, rassegato sulle labbra, sperando che il suo silenzio impacciasse la foga derisoria del compagno.
Ma che! Ci sguazzava, Capolino.
– Perché lo fa? – riprese, ponendosi davanti la sposa zitellona. – Per entrare nel mondo con tutti i diritti di signora? Ma io direi che ne esce, piuttosto. Va a rinchiudersi a Colimbètra! E, monacazione sotto tutti i rispetti, mi spiego? Il principe, a buon conto, ha sessantacinque anni sonati.
S’interruppe a un atto del De Vincentis.
– Eh, caro mio! Lo so, tu fai professione d’angelo; ma qua si tratta di matrimonio; e ci si deve pur pensare all’età. Vis, vis, vis: lo dicono anche i sacerdoti! Dunque, mondo, niente. Diventa principessa, principessa di Laurentano: dirò, regina di Colimbètra! Sì: per me, per te, per tutti noi che riteniamo il matrimonio religioso, non pur superiore al civile, ma il solo, il vero che valga; quello che, bastando davanti a Dio, dovrebbe strabastare per gli uomini. Tutti gli altri però, ohè, non hanno mica l’obbligo di riconoscerlo e di rispettare lei, fuori di Colimbètra, quale principessa di Laurentano; e Lando, per esempio, il figlio del primo letto, di rispettarla quale seconda madre. E che le resta allora? La ricchezza… Non lo fa per questo certamente, ricca com’è di casa sua. Se lo facesse per questo, oh! povera Adelaide, ho una gran paura che le andrebbe a finire come a me…
E qui rise di nuovo Capolino, ma come una lumaca nel fuoco.
Dopo una lunghissima lotta, era riuscito a ottenere in moglie una sorella di Flaminio Salvo, mezza gobba, minore di due anni di donna Adelaide, e formarsi con la dote di lei uno stato invidiabile. Allegrezza in sogno, ahimè! Povero mondo, e chi ci crede! Cinque anni dopo, morta la moglie, sterile per colmo di sventura, aveva dovuto restituire al Salvo la dote, ed era ripiombato nello stato di prima, con tante e tante idee, una più bella e più ardita dell’altra nel fecondo cervello, alle quali purtroppo, così d’un tratto, era venuta meno la benedetta leva del denaro. S’era concesso sei mesi di profondo scoramento e poi altri sei d’invincibile malinconia, sperando con quello e con questa d’intenerire il cuore dell’altra sorella del Salvo, di donna Adelaide appunto. Ma il cuore di donna Adelaide non s’era per nulla intenerito: ben guardato nell’ampia e solida fortezza del busto, aveva per due anni resistito all’assedio di lui, assedio di gentilezze, di cortesie, di devozione; aveva infine respinto d’un colpo un assalto supremo e decisivo, e Capolino s’era dovuto ritirare in buon ordine. Altri sei mesi di profondo scoramento, d’invincibile malinconia; e, finalmente, munito d’una seconda moglie, giovane, bella e vivacissima, era ritornato con più fortuna all’assalto della casa di Flaminio Salvo.
Le male lingue dicevano che in grazia di Nicoletta Spoto, cioè della moglie giovane, bella e vivacissima, la quale era diventata subito quasi la dama di compagnia di donna Adelaide e dell’unica figliuola di don Flaminio, Dianella, Capolino era bucato nel banco in qualità di segretario e d’avvocato consulente. Ma se vogliamo pigliare tutte le mosche che volano… Da un anno egli viveva nel lusso e nell’abbondanza; tanto lui quanto la moglie si servivano da padroni dei Lando pomposi e dei superbi cavalli della scuderia del Salvo; elegantissimo cavaliere, ogni domenica, sù e giù per il viale della Passeggiata, pareva che egli ne facesse la mostra; e infine col favore incondizionato di Flaminio Salvo era riuscito a imporsi, a farsi riconoscere capo del partito clericale militante, il quale, dopo il ritiro dell’onorevole Fazello, gli avrebbe offerta fra pochi giorni la candidatura alle imminenti elezioni politiche generali.
All’anima candida di Ninì De Vincentis non balenava neppur da lontano il sospetto che tutta quell’acredine di Capolino per donna Adelaide potesse avere una ragione recondita e inconfessabile. Come non credeva che qualcuno mai si fosse potuto accorgere del suo timido, puro e ardentissimo amore per Dianella Salvo, la figlia ora inferma di don Flaminio, così non s’era mai accorto, prima, del vano ostinato assedio di Capolino a donna Adelaide, né credeva ora minimamente alle chiacchiere maligne sul conto di quella cara signora Nicoletta, seconda moglie di Capolino. Non sapeva scoprir secondi fini in nessuno; meno che mai poi quello del denaro. Era, su questo punto, come un cieco. Da parecchi anni, dopo la morte dei genitori, si lasciava spogliare, insieme col fratello maggiore Vincente, da un amministratore ladro, chiamato Jaco Pacia, il quale aveva saputo arruffar così bene la matassa degli affari, cheil povero Ninì, avendogliene tempo addietro domandato conto, per poco non ne aveva avuto il capogiro. E s’era dovuto recare una prima volta al banco del Salvo per un prestito di denaro su cambiali. Parecchie altre volte era poi dovuto ritornare allo stesso banco; e, alla fine, per consiglio dell’amministratore, aveva fatto al Salvo la proposta di saldare il debito con la cessione della magnifica tenuta di Primosole, proposta che il Salvo aveva subito accettata, acquistandosi per giunta la più fervida gratitudine di Ninì, a cui naturalmente non era passato neppure per il capo il sospetto d’un accordo segreto tra il Pacia, suo amministratore, e il banchiere. Amava Dianella Salvo e in don Flaminio non sapeva veder altro che il padre di lei.
Ora avrebbe tanto desiderato che la fanciulla, scampata per miracolo a un’infezione tifoidea, fosse andata a recuperar la salute a Primosole, nell’antica villa di sua madre, dove tutto le avrebbe parlato di lui, con la mesta, amorosa dolcezza dei ricordi materni. Ma i medici avevano consigliato al Salvo per la figliuola aria di mare. E Ninì pensava, dolente, che a Valsanìa sul mare egli non avrebbe potuto recarsi a vederla se non di rado. Si confortava per il momento col pensiero che avrebbe sorvegliato lui alla preparazione della camera, del nido che l’avrebbe accolta per qualche mese.
Come se Capolino avesse letto il pensiero del suo giovane amico, di cui facilmente e da un pezzo aveva indovinato l’ingenua aspirazione, suggellò, dopo la risata, con un basta! il primo discorso, e riprese, fregandosi le mani:
– Tra poco saremo arrivati. Tu attenderai alla camera di Dianella; sarà meglio. Io penserò per donna Vittoriona.
Ninì, soprappreso così, mostrò una viva costernazione per quest’ultima, ch’era la moglie del Salvo, pazza da molti anni.
– Sì sì, – disse, – bisogna star bene attenti, che questo cambiamento, Dio liberi, non la turbi troppo.
– Non c’è pericolo! – lo interruppe Capolino. – Vedrai che neppure se n’accorgerà. Seguiterà tranquillamente la sua interminabile calza. Fa le calze al Padreterno, lo sai. Notte e giorno; e vuole che lavorino con lei anche le due suore di San Vincenzo che l’assistono. Pare che questa calza sia già grande come un tartanone.
Ninì crollò il capo mestamente.
La vettura, poco oltre la Seta, entrò nel fèudo, dallo stradone. Il cancello era rovinato: una sola banda, tutta arrugginita, era in piedi, fissa a un pilastro; l’altro pilastro era da gran tempo diroccato. La strada carrozzabile, che attraversava quest’altra parte del fèudo, ceduta anch’essa a mezzadria, era come tuttoil resto in abbandono, irta di cespugli, tra i quali si vedevano i solchi lasciati di recente dai carri con la suppellettile.
Ninì De Vincentis guardò tutt’intorno quella desolazione, senza dir nulla, ma seguitò a parlar per sé e per lui Capolino.
– La malatuccia – disse, facendo una smusata, – avrà poco da stare allegra, qua, non ti pare?
– È molto triste, – sospirò Ninì.
– Non dico soltanto per il luogo – soggiunse Capolino. – Anche per quelli che vi stanno. Due tomi, caro mio. Adesso vedrai. Mah… Questa villeggiatura si farà più per donna Adelaide che non ci viene, che per Dianella. E Dianella, che forse lo sospetta, la soffrirà in pace, al solito, per amore della zia… Eh! Flaminio è un grand’uomo, non c’è che dire!
– L’aria però è buona, – osservò il giovanotto per attenuare, almeno un po’, l’aspro giudizio del compagno sul Salvo.
– Ottima! ottima! – sbuffò Capolino, il quale, da questo punto, si chiuse in un silenzio accigliato, fino all’arrivo alla villa.
I carri erano giunti da poco, insieme con la giardiniera che aveva portato due servi del Salvo, il cuoco, una cameriera e due tappezzieri. Donna Sara Alàimo, sul pianerottolo in cima alla scala, batteva le mani, festante, a quelle quattro montagne di bella roba su i carri.
– Presto, scaricate! – ordinò ai servi e ai carrettieri Capolino, smontando dalla vettura e agitando la mazzettina. Poi, salita in fretta la scala, domandò a donna Sara: – Don Cosmo?
Ed entrò, senza aspettar risposta, nel vecchio cascinone con Ninì De Vincentis, che gli andava dietro come un cagnolino sperduto.
– Scaricate! – ripetè uno dei servi, rifacendo tra le risate dei compagni il tono di voce e il gesto imperioso di quel padrone improvvisato.
Don Cosmo s’aggirava come una mosca senza capo per le stanze lavate di fresco da donna Sara, la quale fin dal giorno avanti, appena saputo la notizia della prossima venuta del Salvo, s’era sentita tutta allargare dalla contentezza e, subito messa in gran da fare, aveva anche persuaso a don Cosmo che sarebbe stato bene sgombrare questa e quella stanza della decrepita mobilia, perché gli ospiti ricconi non vedessero tutta quella miseria in una casa di principi.
– Ma no! ma no! ma no! – aveva cominciato subito a strillare don Cosmo dalla sua stanza, udendo il fracasso di quei poveri vecchi mobili strappati a forza dai loro posti e trascinati; e donna Sara, stupefatta da quella protesta: – No? Come no, se me l’ha detto lei? –. Perché avveniva sempre così: donna Sara parlava, parlava, e don Cosmo, dal canto suo, pensava, pensava, facendo finta di tanto in tanto d’udire, con qualche rapido cenno del capo, quando piùlo pungeva il fastidio del suono di quelle interminabili parole. Questi cenni erano interpretati naturalmente da donna Sara come segni d’assentimento; la sopportazione con cui don Cosmo simulava d’ascoltarla, come riconoscimento della saggezza con cui lei governava la casa e il mondo; e tanto lontana era arrivata nell’interpretare a suo modo quei segni e quella sopportazione del suo padrone, che forse qualche sera se lo sarebbe preso per mano e condotto a letto, se tutt’a un tratto don Cosmo, sbarrando tanto d’occhi e prorompendo in un’esclamazione inopinata, non le avesse fatto crollare tutto il castello delle sue supposizioni.
– Don Cosmo onorandissimo! – esclamò Capolino, scoprendolo alla fine dopo aver girato anche lui di qua e di là per trovarlo. – In gran confusione eh? Perbacco!
– No, no, – s’affrettò a rispondere don Cosmo per troncar subito le cerimonie con le nari arricciate per il lezzo acre di muffa che ammorbava il cascinone umido ancora per l’insolita lavatura. – Cercavo una stanza appartata, dove starmene senza recare incomodo.
Capolino fece per protestare; ma don Cosmo lo fermò a tempo:
– Lasciatemi dire! Ecco… comodo io, comodi loro: va bene così? In capo, in capo, tenete in capo!
Alzò una mano, così dicendo, a carezzare l’elegantissima barbetta nera di Ninì De Vincentis.
– Ti sei fatto un bel ragazzo, figliuolo mio, e così cresciuto, mi fai accorgere di quanto sono vecchio! Tuo fratello Vincente? sempre arabista?
– Sempre! – rispose Ninì, sorridendo.
– Ah! Quei quattordici volumi d’arabo manoscritti dovrebbero pesare come tanti macigni, nel mondo di là, sull’anima del conte Lucchesi-Palli che volle farne dono morendo alla nostra Biblioteca per rovinare codesto povero figliuolo!
– Ne ha già interpretati dieci, – disse Ninì. – Gliene restano ancora quattro, ma grossi così!
– Faccia presto! faccia presto! – concluse don Cosmo paternamente. – E anche tu, figliuolo mio, bada… badate alle cose vostre: so che vanno male! Giudizio!
Capolino intanto, presso la finestra, s’industriava di farsi specchio della vetrata aperta, e si lisciava sulle gote le fedine, già un po’ brizzolate. Bello non era davvero, ma aveva occhi fervidi e penetranti che gli accendevano simpaticamente tutto il volto bruno e magro.
Sentendo cadere il discorso tra il Laurentano e Ninì, finse di star lì a determinare i punti cardinali della villa.
– Esposizione a mezzogiorno, è vero? Ma se l’era scelta per lei, questa camera, don Cosmo?
– Questa o un’altra, – rispose il Laurentano. – Camere, ce n’è d’avanzo, vedrete; ma tutte così, vecchie e in pessimo stato. Uscendo di qua… (no, senza cerimonie: scusate, che gusto c’è a dire che non è vecchio quello che è vecchio? Si vede!)… dicevo, uscendo di qua, abbiamo questo lungo corridojo, che divide in due parti il casermone: le camere da questa parte sono a mezzogiorno; quelle di là, a tramontana. La sala d’ingresso interrompe di qua e di là il corridojo, e divide la villa in due quartieri uguali, salvo che di qua, in fondo, abbiamo un camerone, il cui uscio è alle mie spalle; di là, invece, abbiamo una terrazza. È semplicissimo.
– Ah bene bene bene, – approvò Capolino. – E dunque abbiamo anche un camerone?
Don Cosmo sorrise, negando col capo; poi spiegò che cosa era il «camerone», e come ridotto e da chi custodito.
– Per amor di Dio! – esclamò Capolino.
– Sarebbe meglio perciò, – concluse don Cosmo, – che disponeste l’abitazione nel quartiere di là, libero del tutto. Io m’ero scelta apposta questa camera.
Capolino approvò di nuovo; e poiché i servi eran già venuti sù col primo carico, s’avviò con Ninì per l’altro quartiere. Don Cosmo rimase in quella camera, dove con l’ajuto di donna Sara trasportò tutti i suoi libracci. La povera casiera, sentendo quanto pesava tutta quella erudizione, non riusciva a capacitarsi come mai don Cosmo che se l’era messa in corpo, potesse vivere poi così sulle nuvole. Don Cosmo, ancora con le nari arricciate, non riusciva a capacitarsi, invece, perché quella mattina ci fosse tutto quel puzzo d’umido. Ma forse non distingueva bene tra il puzzo e il fastidio che gli veniva dal pensare che or ora, per l’arrivo degli ospiti, tutte le sue antiche abitudini sarebbero frastornate, e chi sa per quanto tempo.
Di lì a poco, Capolino ritornò, lasciando solo di là il De Vincentis, che s’era dimostrato molto più adatto di lui alla bisogna: così almeno dichiarò. In verità, veniva per porre a effetto una delle ragioni per cui s’era volentieri accollato l’incarico del Salvo: quella cioè di scoprir l’umore di don Cosmo circa il matrimonio del fratello, o di «tastargli il polso» su quell’argomento, com’egli diceva tra sé.
Non già che sperasse che ormai quelle nozze potessero andare a monte; ma, conoscendo la diversità, anzi l’opposizione inconciliabile tra i due modi di pensare e di sentire del Salvo e di don Cosmo, gli piaceva supporre che qualche attrito, qualche urto potesse nascere dal soggiorno di quello a Valsanìa. Era così astratta e solitaria l’anima di don Cosmo, che la vita comune non riusciva a penetrargli nella coscienza con tutti quegli infingimenti e quelle arti e quelle persuasioni che spontaneamente la trasfigurano agli altri, e spesso, perciò, dalla gelida vetta della sua stoica noncuranza lasciava precipitar come valanghe le verità più crude.
– Uh quanti libri! – esclamò Capolino entrando. – Già lei studia sempre… Romagnosi, Rosmini, Hegel, Kant…
A ogni nome letto sul dorso di quei libri sgranava gli occhi, come se vi ponesse punti esclamativi sempre più sperticati.
– Poesie! – sospirò don Cosmo, con un gesto vago della mano, socchiudendo gli occhi.
– Come come? Don Cosmo, non capisco. Filosofia, vorrà dire.
– Chiamatela come volete, – rispose il Laurentano, con un nuovo sospiro. – Da studiare, poco o niente: c’è da godere, sì, della grandezza dell’ingegnaccio umano, che su un’ipotesi, cioè su una nuvola, fabbrica castelli: tutti questi varii sistemi di filosofia, caro avvocato, che mi pajono… sapete che mi pajono? chiese, chiesine, chiesacce, di vario stile, campate in aria.
– Ah già, ah già… – cercò d’interrompere Capolino, grattandosi con un dito la nuca.
Ma don Cosmo, che non parlava mai, toccato giusto su quell’unico tasto sensibile, non seppe trattenersi:
– Soffiate, rùzzola tutto; perché dentro non c’è niente: il vuoto, tanto più opprimente, quanto più alto e solenne l’edifizio.
Capolino s’era tutto raccolto in sé, per raccapezzarsi, incitato dalla passione con cui don Cosmo parlava, a rispondere, a rintuzzare; e aspettava, sospeso, una pausa; avvenuta, proruppe:
– Però..
– No, niente! Lasciamo stare! – troncò subito don Cosmo, posandogli una mano su la spalla. – Minchionerie, caro avvocato!
Per fortuna, in quella, Mauro Mortara, sulla spianata innanzi alla villa dalla parte che guardava la vigna e il mare, si mise a chiamare col suo solito verso – pïo, pïo, pïo – gl’innumerevoli colombi, a cui soleva dare il pasto due volte al giorno.
Don Cosmo e Capolino s’affacciarono al balcone. Anche Ninì si sporse a guardare dalla ringhiera dell’ultimo balcone in fondo, e poi dal terrazzo s’affacciarono i servi e le cameriere e i tappezzieri.
Era ogni volta, tra quel candido fermento d’ali, una zuffa terribile, giacché la razione delle cicerchie era rimasta da tempo la stessa, mentre i colombi s’erano moltiplicati all’infinito e vivevano, ormai, quasi in istato selvaggio per il fèudo e per tutte le contrade vicine. Sapevano l’ora dei pasti e accorrevano puntuali a fitti nugoli fruscianti, da ogni parte: invadevano, tubando d’impazienza, in gran subbuglio, i tetti della villa, della casa rustica, del pagliajo, del colombajo, del granajo, del palmento e della cantina; e se Mauro tardava un po’, dimentico o assorto nelle sue memorie, una numerosa comitiva si spiccava dai tetti e andava a sollecitarlo dietro la porta della nota camera a pianterreno: la comitiva a poco a poco diventava folla e in breve tutta la spianata ferveva d’ali e grugava, mentre per aria tant’altri si tenevan su le ali sospesi a stento, non sapendo dove posarsi.
Don Cosmo pensò con dispiacere che quel giorno, intanto, Mauro non sarebbe salito a desinare; gliel’aveva detto la sera avanti:
– Questa è l’ultima volta che mangio con voi. Perché mi farete la grazia di credere che non verrò a sedermi a tavola con Flaminio Salvo.
Ora se ne stava giù tra i suoi colombi a testa bassa, aggrondato. Capolino l’osservava dal balcone, come se avesse sotto gli occhi una bestia rara.
– Lo saluto? – domandò piano a don Cosmo.
Questi con la mano gli fe’ cenno di no.
– Orso, eh? – soggiunse Capolino. – Ma un gran bel tipo!
– Orso, – ripetè don Cosmo, ritirandosi dal balcone.
Andati nella sala da pranzo dell’altro quartiere, già riccamente addobbata dai tappezzieri, Capolino tentò di nuovo di «tastare il polso» a don Cosmo sul noto argomento. Non sarebbe più certo ricascato a muovergliene il discorso dai libri di filosofia.
Don Cosmo era distratto nell’ammirazione di quella sala, resa così d’improvviso irriconoscibile.
– Prodigio d’Atlante! – esclamava, battendo una mano su la spalla di Ninì De Vincentis. – Mi par d’essere a Colimbètra!
Subito Capolino colse la palla al balzo:
– Lei non ci va più da anni, a Colimbètra, eh?
Don Cosmo stette un po’ a pensare.
– Da circa dieci.
E restò sospeso, senza aggiunger altro. Ma Capolino, fissando il gancio per tirarlo a parlare:
– Da quando vi morì sua cognata, è vero?
– Già, – rispose, asciutto, il Laurentano.
E Capolino sospirò:
– Donna Teresa Montalto… che dama! che lutto! Vera donna di stampo antico!
E, dopo una pausa, grave di simulato rimpianto, un nuovo sospiro, d’altro genere:
– Mah! Cosa bella mortai passa e non dura!
Donna Sara Alàimo, la casiera, che si trovava in quel punto a servire in tavola, per rialzarsi agli occhi degli ospiti della sua indegna condizione di serva, fu tentata d’interloquire e sospirò timidamente con un languido risolino:
– Metastasio!
Ninì si voltò a guardarla, stupito; don Cosmo accomodò la bocca per emettere un suo riso speciale, fatto di tre oh! oh! oh! pieni, cupi e profondi. Ma Capolino, nel vedersi minacciato d’aver guastate le uova nel paniere sul più bello, rimbeccò, stizzito:
– Leopardi, Leopardi…
– Petrarca, Petrarca, scusate, caro avvocato! – protestò don Cosmo, aprendo le mani. – Me n’appello a Ninì!
– Ah, già, Petrarca, che bestia! Muor giovine colui che al cielo è caro… – si riprese subito Capolino. – Confondevo… E lei dunque., dunque lei non rivede il fratello da allora?
Don Cosmo riprese a un tratto l’aria addormentata; socchiuse gli occhi; confermò col capo.
– Sempre sepolto qui! – spiegò allora Capolino al De Vincentis, come se questi non lo sapesse. – Altri gusti, capisco… anzi diametralmente opposti, perché don Ippolito ama la… la compagnia, non sa farne a meno… E forse, io dico, dopo la sciagura, avrebbe molto desiderato di non restar solo, senza parenti attorno… Ma, lei qui; il figlio sempre a Roma… e…
Don Cosmo, che aveva già compreso, ma a suo modo, l’intenzione di Capolino, per tagliar corto uscì a dire:
– E dunque fa bene a riammogliarsi, volete dir questo? D’accordo! Tu intanto, – soggiunse, rivolgendosi a Ninì, – bello mio, non ti risolvi ancora?
Ninì, nel vedersi così d’improvviso tirato in ballo, s’invermigliò tutto:
– Io?
– Guarda come s’è fatto rosso! – esclamò Capolino, scoppiando a ridere, dalla rabbia.
– Dunque c’è, dunque c’è? – domandò don Cosmo, picchiandosi con un dito il petto, dalla parte del cuore.
– Altro se c’è! – esclamò Capolino, ridendo più forte.
Ninì, tra le spine, mortificato, urtato da quella risata sconveniente, protestò con qualche energia:
– Ma non c’è nientissim’affatto! Per carità, non dicano codeste cose!
– Già! San Luigi Gonzaga! – riprese allora Capolino, prolungando sforzatamente la risata. – O piuttosto… sì, dov’è donna Sara? lui sì, davvero, Metastasio… un eroe di Metastasio, don Cosmo! o diciamo meglio, un angelo… ma un angelo, non come ad Alcamo, badiamo! Sa, don Cosmo, che ad Alcamo chiamano angelo il porchetto?
Ninì s’inquietò sul serio; impallidì; disse con voce ferma:
– Lei mi secca, avvocato!
– Non parlo più! – fece allora Capolino, ricomponendosi.
Don Cosmo rimase afflitto, senza comprendere in prima: poi aprì la bocca a un ah! che gli rimase in gola. Si trattava forse della figlia del Salvo? Ah, ecco, ecco… Non ci aveva pensato. Non la conosceva ancora. Ma sicuro! benissimo! Una fortuna per quel caro Ninì! E glielo volle dire:
– Non ti turbare, figliuolo mio. È una cosa molto seria. Non dovresti perder tempo, nella tua condizione.
Ninì si torse sulla seggiola quasi per resistere, senza gridare, alla puntura di cento spilli su tutto il corpo. Capolino rattenne il fiato e aspettò che la valanga precipitasse. Don Cosmo non seppe rendersi ragione dell’effetto di quelle sue parole e guardò stordito, prima l’uno, poi l’altro.
– M’e scappata qualche altra minchioneria? – domandò. – Scusate. Non parlo più neanche io.
Ninì viveva veramente in cielo, in un cielo illuminato da un suo sole particolare, lì lì per sorgere, non sorto ancora, e che forse non sarebbe sorto mai. Lo lasciava lì, dietro le montagne dure della realtà, e preferiva rimanere nel lume roseo e vano d’una perpetua aurora, perché il sole, sorgendo, non dovesse poi tramontare, e perché le ombre, inevitabili, rimanessero tenui e quasi diafane. Già gli s’era affacciato il dubbio che il Salvò ormai non avrebbe accolto bene la sua richiesta di nozze, dato che egli si fosse mai spinto a fargliela. Ma aveva sempre rifuggito dall’accogliere e ponderare questo dubbio per non turbare il purissimo sogno di tutta la sua vita. E non perché quel dubbio gliel’avesse impedito, ma perché veramente gli mancava il coraggio di tradurre in atto un ideale così altamente vagheggiato che quasi temeva si potesse guastare al minimo urto della realtà, non s’era mai risoluto, non che a fare la richiesta, ma nemmeno a dichiararsi apertamente con Dianella Salvo. Ora, il sospetto che egli potesse farlo per la dote della ragazza che avrebbe rimesso in sesto le sue finanze, gli cagionò un acutissimo cordoglio, gli avvelenò la gioja di quel servigio reso per amore, e che invece potevà parere interessato; e, come se tutt’a un tratto il suo sole avesse dato un tracollo, tutto improvvisamente gli s’oscurò, e quando le stanze furon messe in ordine, ed egli con la gola stretta d’angoscia fece un ultimo giro d’ispezione, non seppe posare, come s’era proposto, sul guanciale del letto di Dianella il bacio dell’arrivo, perché ella, senza saperlo, ve lo trovasse la sera, andando a dormire.
Don Cosmo e Capolino, piccoli, neri, sotto un cielo altissimo, cupamente infocato dal tramonto, s’erano messi intanto a passeggiare innanzi alla vecchia villa, per il lungo, diritto viale, che fa quasi orlo, a manca, al ciglio, d’onde sprofonda ripido un burrone ampio e profondo, detto il vallone.
Pareva che lì l’altipiano per una convulsione tellurica si fosse spaccato innanzi al mare.
La tenuta di Valsanìa restava di qua, scendeva con gli ultimi olivi in quel burrone, gola d’ombra cinerulea, nel cui fondo sornuotano i gelsi, i cambi, gli aranci, i limoni lieti d’un rivo d’acqua che vi scorre da una vena aperta laggiù in fondo nella grotta misteriosa di San Calogero.
Dall’altra parte del burrone, alla stessa altezza, eran le terre alberate di Platanìa che a mezzogiorno scendono minacciose sulla linea ferroviaria, la quale, sbucando dal traforo sotto Valsanìa, corre quasi in riva al mare fino a Porto Empedocle.
La zona di fiamma e d’oro del tramonto traspariva in un fantastico frastaglio di tra il verde intenso degli alberi lontani, di là dal burrone. Qua, su i mandorli e gli olivi di Valsanìa, alitava già la prima frescura d’ombra, dolce, lieve e malinconica, della sera.
Quest’ora crepuscolare, in cui le cose, nell’ombra calante, ritenendo più intensamente le ultime luci, quasi si smaltano nei lor chiusi colori, era alla solitudine di don Cosmo più d’ogn’altra gradita. Egli aveva costante nell’animo il sentimento della sua precarietà nei luoghi dove abitava, e non se n’affliggeva. Per questo sentimento che si trasfondeva lieve e vago nel mistero impenetrabile di tutte le cose, ogni cura, ogni pensiero gli erano insopportabilmente gravi. Figurarsi, ora, come schiacciante dovesse riuscirgli il discorso di Capolino, che s’aggirava fervoroso intorno alle imprese fortunate del Salvo, a un gran disegno che costui meditava, insieme col direttore delle sue zolfare, l’ingegnere Aurelio Costa, per sollevar le sorti dell’industria zolfifera, miserrime da parecchi anni.
– Coscienza nuova, la sua, – diceva Capolino. – Lucida, precisa e complicata, don Cosmo, come un macchinario moderno, d’acciajo. Sa sempre quel che fa. E non sbaglia mai!
– Beato lui! – ripeteva don Cosmo con gli occhi socchiusi, in atto di rassegnata sopportazione.
– E credentissimo, sa! – seguitava Capolino. – Veramente divoto!
– Beato lui!
– È una meraviglia come, tra tante brighe, riesca a trovar tempo e modo di badare anche al nostro partito. E con che impegno ne ha sposato la causa!
Ma, poco dopo, Capolino cambiò discorso, accorgendosi che don Cosmo non gli prestava ascolto. Gli si fece più accosto, gli toccò il braccio e aggiunse piano, con aria mesta:
– Quel povero Ninì! Son sicuro che ci piange, sa? per quel po’ di baja che gli abbiamo dato a tavola. Innamoratissimo, povero figliuolo! Ma la ragazza, eh! purtroppo, non è per lui.
– Fidanzata ad altri? – domandò don Cosmo, fermandosi.
– No no: ufficialmente, no! – negò subito Capolino. – Ma… zitto però, mi raccomando: non deve saperlo neanche l’aria! Io credo, caro don Cosmo, che la ragazza sia in fondo più malata d’anima che di corpo.
– Toccata, eh?
– Toccata. Questa forse è l’unica cosa mal fatta di suo padre. Qua Flaminio ha sbagliato… eh, non c’è che dire, ha sbagliato!
Don Cosmo si rifermò, crollò più volte il capo e disse, serio serio:
– Vedete dunque che sbaglia anche lui, caro avvocato?
– Ma se il diavolo, creda, ci volle proprio cacciar la coda, quella volta! – riprese Capolino. – Lei saprà che Flaminio… sarà dieci anni, altro che dieci! saranno quindici di sicuro! Insomma lì, poco più poco meno, fu a un pelo di morire affogato… Non lo sa? E come! Ai bagni di mare, a Porto Empedocle. Una cosa buffa, creda, buffa e atroce al tempo stesso! Per un pajo di zucche…
– Di zucche? Sentiamo, – disse don Cosmo, contro il suo solito, incuriosito.
– Ma sì, – seguitò Capolino. – Prendeva un bagno, ai Casotti. Non sa nuotare e, per prudenza, si teneva tra i pali del recinto, dove l’acqua, sì e no, gli arrivava al petto. Ora (il diavolo!) vide un pajo di zucche galleggiare accanto a lui, lasciate in mare forse da qualche ragazzo. Le prese. Stando accoccolato, perché l’acqua lo coprisse fino al collo – (com’è brutto l’uomo nell’acqua, don Cosmo mio, l’uomo che non sa nuotare!) – gli venne la cattiva ispirazione d’allungar la mano a quel pajo di zucche e cacciarsele sotto con la cordicella che le teneva unite; ci si mise a seder sopra, e, siccome le zucche, naturalmente, spingevano, e lui aveva lasciato il sostegno del palo per veder se quelle avessero tanta forza da sollevargli i piedi dal fondo, a un tratto, patapùmfete! perdette l’equilibrio e tracollò a testa giù, sott’acqua!
– Oh, guarda! – esclamò don Cosmo, costernato.
– Si figuri, – riprese Capolino, – come cominciò a fare coi piedi per tornare a galla! Ma, per disgrazia, i piedi gli s’erano impigliati nella cordicella e, naturalmente, per quanti sforzi facesse sott’acqua, non li poteva più tirare al fondo.
– Zitto! zitto! ohi ohi ohi… – fece don Cosmo, contraendo le dita e tutto il volto.
Ma Capolino seguitò:
– Badi che è buffo davvero rischiar d’affogare in un recinto di bagni, in mezzo a tanta gente che non se ne accorgeva e non gli dava ajuto, non sospettando minimamente ch’egli fosse lì con la morte in bocca! E sarebbe affogato, affogato com’è vero Dio, se un ragazzotto di tredici anni – questo Aurelio Costa, che ora è ingegnere e direttore delle zolfare del Salvo ad Aragona e a Comitini – non si fosse accorto di quei due piedi che si azzuffavano disperatamente a fior d’acqua e non fosse accorso, ridendo, a liberarlo…
– Ah, capisco… – fece don Cosmo. – E la figliuola, adesso…
– La figliuola… la figliuola… – masticò Capolino. – Flaminio, capirà, dovette disobbligarsi con quel ragazzo e si disobbligò nella misura del pericolo che aveva corso e del terrore che s’era preso. Gli dissero che era figlio d’un povero staderante all’imbarco dello zolfo…
– Il Costa, già, Leonardo Costa, – interruppe don Cosmo. – Amico mio. Viene a trovarmi qua, qualche domenica, da Porto Empedocle.
– Saprà dunque che sta con Flaminio, adesso? – soggiunse Capolino. – Flaminio lo levò dalle stadere e gli diede un posto nel suo gran deposito di zolfi su la spiaggia di levante. Al figlio Aurelio, poi, volle dar lui la riuscita, senza badare a spese; non solo, ma se lo tolse con sé, lo fece crescere in casa sua, coi figliuoli, con Dianella e con quell’altro bimbo che gli morì. Anche questa disgrazia contribuì certo a fargli crescere l’affetto per il giovine. Ma, affetto, dico, fino a un certo punto. Per la stessa ragione per cui ora non darebbe la figlia a Ninì De Vincentis, non la darebbe mai, m’immagino, neanche ad Aurelio Costa, suo dipendente, si figuri!
– Ma! – esclamò don Cosmo, scrollando le spalle. – Ricco com’è… con una figlia sola…
– Eh no… eh no…, – rispose Capolino. – Capisco, a un caso di lui, tutte le ricchezze cascheranno per forza in mano a qualcùno, a un genero, a quello che sarà. Ma vorrà ben pesarlo, prima, Flaminio! Non è uomo da rosee romanticherie. Può averne la figlia… E, romanticherie nel vero senso della parola, badi! Perché, di questa sua vera e segreta malattia sono a conoscenza io, per certe mie ragioni particolari; ne è a conoscenza, credo, anche Flaminio, o almeno ne ha il sospetto; ma lui, l’ingegnere Costa (ottimo giovine, badiamo! giovine solido, cosciente del suo stato e di quanto deve al suo benefattore) non ne sa nulla di nulla, non se l’immagina neppur lontanamente; glielo posso assicurare, perché ne ho una prova di fatto, intima. L’ingegnere…
A questo punto Capolino s’interruppe, scorgendo in fondo al viale un uomo, che veniva loro incontro di corsa, gesticolando.
– Chi è là? – domandò, fermandosi, accigliato.
Era Marco Prèola, tutto impolverato, arrangolato, in sudore, con le calze ricadute su le scarpacce rotte. Stanco morto.
– Ci siamo! ci siamo! – si mise a gridare, appressandosi. – È arrivato!
– L’Auriti? – domandò Capolino.
– Sissignore! – riprese il Prèola. – Per le elezioni: non c’è più dubbio! Vengo di corsa apposta da Girgenti.
Si tolse il cappelluccio roccioso, e con un fazzoletto sudicio s’asciugò il sudore che gli grondava dal capo tignoso.
– Mio nipote? – domandò, frastornato e stupito, don Cosmo.
Subito Capolino, con aria rammaricata, prese a informarlo e delle dimissioni del Fazello, e delle premure che si facevano su lui perché accettasse la candidatura, e delle voci che correvano a Girgenti su questa venuta inattesa di Roberto Auriti. Voci… voci a cui egli, Capolino, non voleva prestar fede per due ragioni: prima, per il rispetto che aveva per l’Auriti, rispetto che non gli consentiva di supporre che, non chiamato, venisse a contendere un posto che il Fazello lasciava volontariamente. La compagine del partito che rappresentava la maggioranza del paese, come per tante prove indiscutibili s’era veduto, rimaneva salda, anche dopo il ritiro di Giacinto Fazello. L’altra ragione era più intima, ed era questa: che gli sarebbe doluto, troppo doluto, d’aver per avversario non temibile, in una lotta impari, uno che, non ostanti le divergenze d’opinioni in famiglia, era parente pur sempre dei Laurentano ch’egli venerava e della cui amicizia si onorava. No, no: preferiva credere piuttosto che l’Auriti fosse venuto a Girgenti solo per riveder la madre e la sorella.
– Ma che dice, avvocato? – proruppe Marco Prèola, scrollandosi dalle spalle quel lungo, faticoso discorso, col quale Capolino, senza parere, aveva voluto dare un saggio delle sue attitudini politiche. – Se sono andati a prenderlo alla stazione quattro mascalzoni, studentelli dell’istituto Tecnico? se sono arrivate in paese la mafia e la massoneria, capitanate da Guido Verònica e da Giambattista Mattina? Non c’è più dubbio, le dico! È venuto per le elezioni.
Mentre Capolino e il Prèola discutevano tra loro, gli occhi, il naso, la bocca di don Cosmo facevano una mimica speciosissima: si strizzavano, s’arricciavano, si storcevano… Vivendo in quell’esilio, assorto sempre in pensieri eterni, con gli occhi alle stelle, al mare lì sotto, o alla campagna solitaria intorno, ora, così investito da tutte quelle notizie piccine, si sentiva come pinzato da tanti insettucci fastidiosi.
– Gesù! Gesù! Pare impossibile… Quante minchionerie…
– E allora, un bicchiere di vino, si-don Co’, – esclamò, per concluder bene, Marco Prèola. – Vossignoria mi deve fare la grazia d’un bicchiere di vino. Non ne posso più! Ho girato tutta Girgenti per trovare il nostro carissimo avvocato; m’hanno detto che si trovava qua a Valsanìa, e subito mi sono precipitato a piedi per la Spina Santa. Mi guardino! Ho la gola, propriamente, arsa.
– Andate, andate a bere alla villa, – gli rispose don Cosmo.
– E non c’è il Mortara? – domandò il Prèola. – Ho paura… – aggiunse ridendo. – Mi sparò, or è l’anno… Dice che venivo qua nel fèudo a caccia dei suoi colombi. Parola d’onore, si-don Cosmo, non è vero! Per le tortore venivo. Forse, qualche volta, non dico, avrò sbagliato. Tiro e, botta e risposta, mi sento arrivare… Fortuna che mi voltai subito. Pum! Nelle natiche, una grandinata… Privo di Dio, le giuro, si-don Co’, che se non era per il rispetto alla famiglia Laurentano… La doppietta ce l’avevo anch’io e, parola d’onore…
Dal fondo del viale giunse in quella un rumore di sonaglioli. I tre, che s’erano accostati alla villa conversando, si voltarono a guardare. Capolino chiamò:
– Ninì! Ninì! Ecco le vetture! Arrivano!
Ninì s’affrettò a scendere dalla villa; ne scesero anche i servi, donna Sara Alàimo e la cameriera, già amiche tra loro.
Erano due vittorie. Nella prima stava don Flaminio con la figliuola; nella seconda, la demente con due infermiere. Don Cosmo s’aspettava di vedere smontare da una delle vetture anche donna Adelaide, la sposa: restò disilluso. Ninì De Vincentis non ebbe il coraggio di farsi avanti a offrire il braccio a Dianella. Col cuore tremante e la vista annebbiata dalla commozione, le intravide il volto affilato, pallidissimo sotto la spessa veletta da viaggio, e la seguì con lo sguardo, mentre, appoggiata al braccio di Capolino, tutta avvolta in una pesante mantiglia, saliva pian piano la scala, come una vecchina, tra gli augurii ossequiosi di donna Sara Alàimo.
Donna Vittoria, smontata dalla vettura faticosamente per l’enorme pinguedine, restò tra le due infermiere con gli occhi immobili, vani nell’ampio volto pallido, incorniciato dall’umile scialle nero, che teneva in capo; guardò così un pezzo don Cosmo; poi aprì le labbra carnose e quasi bianche a un sorriso squallido e disse in un inchino:
– Signor Priore!
Una delle infermiere la prese per mano, mentre don Cosmo, accanto al Salvo, socchiudeva gli occhi, afflitto. Ninì andò dietro alla demente.
– Grazie, – disse Flaminio Salvo, stringendo forte la mano a don Cosmo. – E non dico altro a lei.
– No, no… – s’affrettò a rispondere il Laurentano, turbato e commosso ancora dal triste spettacolo, sentendo un’improvvisa, profonda pietà per quell’uomo che, nella sua invidiata potenza, con quella stretta di mano gli confidava in quel punto il sentimento della propria miseria.
| I vecchi e i giovani – Indice Introduzione |
|
| Parte I
Capitolo 1 |
Parte II
Capitolo 1 |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com