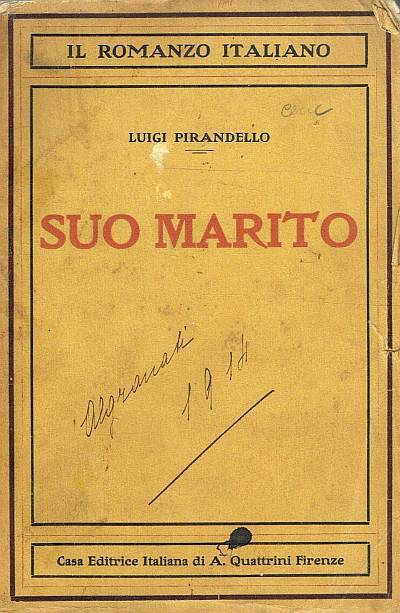««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «Suo marito» su Amazon
IV. Dopo il trionfo
1.
Alla stazione, una folla. I giornali avevano divulgato la notizia che Silvia Roncella, per miracolo scampata alla morte proprio nel momento supremo del suo trionfo, finalmente in grado di sopportar lo strapazzo d’un lungo viaggio, partiva quella mattina, ancora convalescente, per andare a recuperar le forze e la salute in Piemonte, nel paesello nativo del marito. E giornalisti e letterati e ammiratori e ammiratrici erano accorsi alla stazione per vederla, per salutarla, e s’affollavano innanzi alla porta della sala d’aspetto, poiché il medico che la assisteva e che l’avrebbe accompagnata fino a Torino, non permetteva che molti le facessero ressa attorno.
– Cargiore? Dov’è Cargiore?
– Uhm! Presso Torino, dicono.
– Ci farà freddo!
– Eh, altro… Mah!
Quelli intanto che erano ammessi a stringerle la mano, a congratularsi, non ostanti le proteste del medico, le preghiere del marito, non sapevano più staccarsene per dar passo agli altri; e, seppur si allontanavano un poco dal divano ov’ella stava seduta tra la suocera e la bàlia, rimanevano nella sala a spiare con occhi intenti ogni minimo atto, ogni sguardo, ogni sorriso di lei. Quelli di fuori picchiavan sui vetri, chiamavano, facevan cenni d’impazienza e d’irritazione; nessuno di quelli entrati se ne dava per inteso; anzi qualcuno pareva si compiacesse di mostrarsi sfrontato fino al punto di guardare con dispettoso sorriso canzonatorio quello spettacolo d’impazienza e d’irritazione.
L’esito del dramma La nuova colonia era stato veramente straordinario, un trionfo. La notizia della «morte dell’autrice, diffusasi in un baleno nel teatro, durante la prima rappresentazione, alla fine del secondo atto, quando già tutto il pubblico era preso, affascinato dalla vasta e possente originalità del dramma, aveva suscitato una così nuova e solenne manifestazione di lutto e d’entusiasmo insieme, che ancora, dopo circa due mesi, ne durava un fremito di commozione in tutti coloro che avevano avuto la ventura di parteciparvi. Affermando quel trionfo della vita dell’opera d’arte, acclamando, gridando, deprecando, singhiozzando, era parso che il pubblico quella sera volesse vincere la morte: era rimasto lì, in teatro, alla fine dello spettacolo, a lungo, a lungo, frenetico, quasi in attesa che la morte lasciasse quella preda sacra alla gloria, la restituisse alla vita; e quando Laura Carmi, esultante, era irrotta al proscenio ad annunziare che l’autrice non era ancor morta, un delirio s’era levato come per una vittoria soprannaturale.
La mattina appresso tutti i giornali erano usciti in edizioni straordinarie per descrivere quella serata memorabile, e per tutta Italia, per tutti i paesi n’era volata subito la notizia, suscitando in ogni città il desiderio più impaziente di vedere al più presto rappresentato il dramma e d’avere intanto altre notizie, altre notizie dell’autrice e del suo stato, altre notizie del lavoro.
Bastava guardar Giustino Boggiolo per farsi un’idea dell’enormità dell’avvenimento, della febbre di curiosità per tutto divampata. Non la moglie, ma lui pareva uscito or ora dalle strette della morte.
Strappato, quella sera, dalle braccia dei comici che lo tenevano agguantato per il petto, per le spalle, per le falde della giacca, a impedire che si presentasse, o piuttosto, si precipitasse alla ribalta, lui invece della moglie, ebbro furente per i fragorosi applausi scoppiati a scena aperta, in principio del secondo atto, nel momento dell’approdo della nuova colonia, allorché alla vista delle donne i primi coloni smettono di combattere e lasciano solo Currao, era stato trascinato via, a casa, da Attilio Raceni che si squagliava in lagrime, convulso.
Come non era impazzito alla vista del tragico trambusto, lì in casa, innanzi a quei tre medici curvi addosso alla moglie sanguinosa abbandonata urlante, nel veder fare scempio e strazio del corpo esposto di lei?
Chiunque altro forse, balzato così da una violenta terribile emozione a un’altra opposta, non meno violenta e terribile, sarebbe impazzito. Lui no! Lui, invece, poco dopo entrato in casa, aveva dovuto e potuto trovare in sé la forza sovrumana di tener testa alla petulanza crudele dei giornalisti accorsi dal teatro appena la prima notizia della morte aveva cominciato a circolar tra i palchi e la platea. E mentre di là venivano gli urli, gli ùluli lunghi orrendi della moglie, aveva potuto, pur sentendosi da quegli urli, da quegli ùluli strappar le viscere e il cuore, rispondere a tutte le domande che quelli gli rivolgevano e dar notizie e ragguagli e finanche andare a scovar nei cassetti e distribuire ai redattori dei giornali più in vista il ritratto della moglie, perché fosse riprodotto nelle edizioni straordinarie del mattino.
Ora ella intanto – bene o male – s’era liberata del suo compito: quel che doveva fare, lo aveva fatto: eccolo là, tra i veli, quel caro gracile roseo cosino in braccio alla bàlia; e andava lontano, a riposarsi, a ristorarsi nella pace e nell’ozio. Mentre lui… Già prima di tutto, altro che quel cosino lì! Un gigante, un gigante aveva messo su, egli; un gigante che ora, subito, voleva darsi a camminare a grandi gambate per tutta l’Italia, per tutta l’Europa, anche per l’America, a mietere allori, a insaccar denari; e toccava a lui d’andargli appresso col sacco in mano, a lui già stremato di forze, così sfinito per il suo parto gigantesco.
Perché veramente per Giustino Boggiolo il gigante non era il dramma composto da sua moglie; il gigante era il trionfo, di cui egli solamente si riconosceva l’autore. Ma sì! se non ci fosse stato lui, se lui non avesse operato miracoli in tutti quei mesi di preparazione, ora difatti tanta gente sarebbe accorsa lì, alla stazione, a ossequiar la moglie, a felicitarla, ad augurarle il buon viaggio!
– Prego, prego… Mi facciano la grazia, siano buoni… Il medico, hanno sentito?… E poi, guardino, ci sono tant’altri di là… Sì, grazie, grazie… Prego, per carità… A turno, a turno, dice il medico… Grazie, prego, per carità… – si rivolgeva intanto a questo e a quello, con le mani avanti, cercando di tenerne quanti più poteva discosti dalla moglie, per regolare anche quel servizio nel modo più lodevole, così che la stampa poi, quella sera stessa, ne potesse parlare come d’un altro avvenimento. – Grazie, oh prego, per carità… Oh signora Marchesa, quanta degnazione… Sì, sì, vada, grazie… Venga, venga avanti, Zago, ecco, le faccio stringer la mano, e poi via, mi raccomando. Un po’ di largo, prego, signori… Grazie, grazie… Oh signora Barmis, signora Barmis, mi dia ajuto, per carità… Guardi, Raceni, se viene il senatore Borghi… Largo, largo, per favore… Sissignore, parte senz’avere assistito neanche a una rappresentazione del suo dramma… Come dice? Ah sì… purtroppo, sì, neanche una volta, neanche alle prove… Eh, come si fa? deve partire, perché io… Grazie, Centanni!… Deve partire… Ciao, Mola, ciao! E mi raccomando, sai?… Deve partire, perché… Come dice? Sissignora, quella è la Carmi, la prima attrice… La Spera, sissignora!… Perché io… mi lasci stare, ah, mi lasci stare… Non me ne parli, non me ne parli, non me ne parli… A Napoli, a Bologna, a Firenze, a Milano, a Torino, a Venezia… non so come spartirmi… sette, sette compagnie in giro, sissignore…
Così, una parola a questo, una a quello, per lasciar tutti contenti; e occhiatine e sorrisi d’intelligenza ai giornalisti; e tutte quelle notizie distribuite così, quasi per incidenza; e or questo ora quel nome pronunziato forte a bella posta, perché i giornalisti ne prendessero nota.
Cèrea, con le. labbra esangui, le nari dilatate, tutta occhi, i capelli cascanti, Silvia Roncella appariva piccola, minima, misera, quale centro di tutto quel movimento attorno a lei; più che stordita, smarrita.
Le si notavano sul volto certi sgrati movimenti, guizzi nervosi, contrazioni, che tradivano duri sforzi d’attenzione; come se ella, a tratti, non sapesse più credere a quel che vedeva e si domandasse che cosa infine dovesse fare, quel che si volesse da lei, ora, nel momento di partire, col bambino accanto, a cui forse tutto quell’assembramento, tutto quel rimescolìo potevano far male, come facevano male a lei.
«Perché? perché?», dicevano chiaramente quegli sforzi. «Ma dunque è vero, proprio vero, questo trionfo?»
E pareva avesse paura di crederlo vero, o fosse all’improvviso assaltata dal dubbio che ci fosse sotto sotto qualcosa di combinato, tutta una macchinazione ordita dal marito che si dava tanto da fare, una gonfiatura, ecco, per cui ella dovesse provare, più che sdegno, onta, come per una irriverenza indecente alla sua maternità, alle atroci sofferenze che essa le era costata, e uno strappo, una violenza alle sue modeste, raccolte abitudini; una violenza non solo importuna ma anche fuor di luogo, perché ella ora lì non stava a far nulla da richiamare tanto popolo: doveva partire, e basta; con la bàlia e il piccino e la suocera, povera cara vecchina tutta sbalordita, e lo zio Ippolito, che si prestava con gran sacrifizio ad accompagnarla fin lassù, invece del marito, e anche a tenerle compagnia in casa della suocera: – ecco, così, un viaggetto in famiglia, da far con le debite precauzioni, inferma com’era tuttavia.
Se il trionfo era vero, in quel momento, per lei, voleva dir fastidio, oppressione, incubo. Ma forse… sì, forse, in altro momento, appena ella avrebbe riacquistato le forze… se esso era vero… chi sa!
Qualcosa come un émpito immenso, tutto pungente di brividi, le si levava dal fondo dell’anima, turbando, sconvolgendo, strappando affetti e sentimenti. Era il dèmone, quell’ebbro dèmone che ella sentiva in sé, di cui aveva avuto sempre sgomento, a cui sempre s’era sforzata di contrastare ogni dominio su lei, per non farsi prendere e trascinar chi sa dove, lontano da quegli affetti, da quelle cure in cui si rifugiava e si sentiva sicura.
Ah, faceva proprio di tutto, di tutto, il marito per gittarla in preda ad esso! E non gli balenava in mente che se ella…?
No, no: ecco; contro il dèmone un altro più tremendo spettro le sorgeva dentro: quello de la morte: la aveva toccata, da poco, toccata; e sapeva com’era: gelo, bujo freddo e duro. Quell’urto! ah, quell’urtó! Sotto la morbida mollezza delle carni, sotto il fervido fluire del sangue, quell’urto contro le ossa del suo scheletro, contro la sua cassa interna! Era la morte, quella; la morte che la urtava coi piedini del suo bimbo, che voleva vivere uccidendola. La sua morte e la vita del suo bambino le sorgevano dinanzi contro il dèmone malioso della gloria: una laidezza sanguinosa, brutale, vergognosa, e quel roseo d’alba lì tra i veli, quella purezza gracile e tenera, carne della sua carne, sangue del suo sangue.
Così combattuta, nella spossatezza della convalescenza, così sbalzata da un sentimento all’altro, Silvia Roncella or si volgeva al bambino, tra un saluto e l’altro; or abbassava la mano per dare una rapida stretta incoraggiante alle mani della vecchina che le sedeva accanto; ora rispondeva con uno sguardo freddo e quasi ostile agli augurii, alle congratulazioni d’un giornalista o d’un letterato, come a dir loro: «Non me n’importa poi tanto, sa? Io sono stata per morire!» – ora, invece, a qualche altra congratulazione, a qualche altro augurio, si rischiarava in viso, aveva come un lampo negli occhi e sorrideva.
– È meravigliosa! meravigliosa! Ingenuità, primitività incantevole! Freschezza di prato! – non rifiniva intanto d’esclamare la Barmis tra il crocchio dei comici venuti anch’essi, come tanti altri, a veder per la prima volta, a conoscer l’autrice del dramma.
Quelli, per non parere imbronciati, assentivano col capo. Eran venuti sicuri d’una calorosissima accoglienza da parte della Roncella al cospetto di tutti, d’una accoglienza quale si conveniva, se non proprio agli artefici primi di tanto trionfo, ai più efficaci cooperatori di lei, non facilmente surrogabili o superabili, via! Erano stati accolti invece, come tutti gli altri, e d’un subito s’erano immelensite le ariè con cui erano entrati e raggelati i loro modi.
– Sì, ma soffre, – osservava il Grimi, facendo boccacce con gravità baritonale. – È chiaro che soffre, guardatela! Ve lo dico io che soffre quella poverina là…
– Tanto di donnetta, che forza! – diceva invece la Carmi, mordicchiandosi il labbro. – Chi lo direbbe? Me la immaginavo tutt’altra!
– Ah sì? Io, no! io, no! Io proprio così, – affermò la Barmis. – Ma se la guardate bene…
– Già, sì, negli occhi… – riconobbe subito la Carmi. – C’è! c’è! negli occhi c’è qualcosa… Certi lampi, sì, sì… Perché il grande della sua arte è… non saprei… in alcuni guizzi, eh? non vi pare? subitanei, improvvisi… in certi bruschi arresti che vi scuotono e vi stonano. Noi siamo abituati a un solo tono, ecco; a quelli che ci dicono: la vita è questa, questa e questa; ad altri che ci dicono: è quest’altra, quest’altra e quest’altra, è vero? La Roncella vi dipinge un lato, anch’essa; ma poi d’un tratto si volta e vi presenta l’altro lato, subito. Ecco, questo mi pare!
E la Carmi, succhiando come una caramella la soddisfazione d’aver parlato così bene, forte, volse gli occhi in giro come a raccogliere gli applausi di tutta la sala, o almeno almeno i segni dell’unanime consenso, e vendicarsi così, cioè con vera superiorità, della freddezza e della ingratitudine della Roncella. Ma non raccolse neanche quelli del suo crocchio, perché tanto la Barmis quanto i suoi compagni di palcoscenico s’accorsero bene eh’essa più che per loro aveva parlato per essere intesa dagli altri, e sopra tutto dalla Roncella. Due soli, rincantucciati in un angolo, la signora Ely Faciolli e Cosimo Zago appoggiato alla stampella, approvarono col capo, e Laura Carmi li guatò con sdegno, come se essi con la loro approvazione la avessero insultata.
A un tratto, un vivo movimento di curiosità si propagò nella sala e molti, cavandosi di capo, inchinandosi, s’affrettarono a trarsi da canto per lasciar passare uno, cui evidentemente l’insospettata presenza di tanta gente cagionava, più che fastidio e imbarazzo, un vero e profondo turbamento, quasi ira, stizza e vergogna insieme; un turbamento che saltava a gli occhi di tutti e che non poteva affatto spiegarsi col solo sdegno ben noto in quell’uomo di darsi in pascolo alla gente.
Altro doveva esserci sotto; e altro c’era. Lo diceva piano, in un orecchio del Raceni, Dora Barmis, con gioja feroce:
– Teme, teme che i giornalisti questa sera, nel resoconto, facciano il suo nome! È sicuro che lo faranno! sfido io, se lo faranno! in prima! capolista! Chi sa, caro mio, dove avrà detto alla Frezzi che sarebbe andato; e invece, eccolo qua; è venuto qua… E questa sera Livia Frezzi leggerà i giornali; leggerà in prima il nome di lui, e figuratevi che scenata gli farà! Gelosa pazza, ve l’ho già detto! gelosa pazza; ma – siamo giusti – con ragione, mi sembra… Per me, via, non c’è più dubbio!
– Ma statevi zitta! – le diede su la voce il Raceni. – Che dite! Se le può esser padre!
– Bambino! – esclamò allora la Barmis con un sorriso di commiserazione.
– Sarà gelosa la Frezzi! Lo sapete voi; io non lo so, – insistette il Raceni.
La Barmis aprì le braccia:
– Ma lo sa tutta Roma, santo Dio!
– Va bene. E che vuol dire? – seguitò il Raceni, accalorandosi. – Gelosa e pazza, se mai! Non può esser altro che pazzia… Ma se alla prima rappresentazione se n’andò dopo il primo atto. Lo notarono tutti i maligni, come una prova che il dramma non gli è piaciuto!
– Per altra ragione, caro, per altra ragione andò via! – canterellò la Barmis.
– Grazie, lo so! Ma quale? – domandò il Raceni. – Perché innamorato della Roncella? Fate ridere, se lo dite. Controsenso! Andò via per la Frezzi. D’accordo! E che vuol dire? Ma se lo sanno tutti che è schiavo di quella donna! che quella donna lo vessa! e che egli farebbe di tutto per stare in pace con lei!
– E viene qua? – domandò argutamente la Barmis.
– Sicuro! viene qua! sicuro! – rispose con stizza il Raceni. – Perché avrà saputo com’è stata interpretata dai maligni quella sua uscita dal teatro, e viene a riparare. È turbato, sfido! non s’aspettava qua tutta questa gente. Teme che questa sera colei, come voi e come tutti possa malignare su questa venuta. Ma via! ma via! Se fosse altrimenti, o non sarebbe venuto, o non sarebbe così turbato. È chiaro!
– Bambino! – ripetè la Barmis.
Non potè aggiungere altro, perché, imminente ormai la partenza, la Roncella tra Maurizio Gueli e il senatore Romualdo Borghi, col marito davanti, battistrada, si disponeva a uscir dalla sala per prender posto sul treno.
Tutti si scoprirono il capo; si levarono grida di evviva tra un lungo scroscio d’applausi; e Giustino Boggiolo, già preparato, in attesa, guardando di qua e di là, sorridente, raggiante, con gli occhi lustri lustri e i pomelli accesi, s’inchinò a ringraziare più volte, invece della moglie.
Nella sala, dietro la porta vetrata, rimase sola a singhiozzare dentro il moccichino profumato la signora Ely Faciolli, dimenticata e inconsolabile. Guardando cauto, obliquo, col grosso testone triste arruffato, lo zoppetto Cosimo Zago balzò con la stampella a quel posto del divano ove poc’anzi stava seduta la Roncella, ghermì una piccola piuma che s’era staccata dal boa di lei e se la cacciò in tasca appena in tempo da non essere scoperto dal romanziere napoletano Raimondo Jàcono, il quale riattraversava sbuffante la sala per andar via, stomacato.
– Ohè! tu? che fai? Mi sembri un cane sperduto… Senti, senti che grida? Gli osanna! È la santa del giorno! Buffoni, peggio di quel suo marito! Su, su, coraggio, figlio mio! È la cosa più facile del mondo, vedi… Quella ha preso Medea e l’ha rifatta stracciona di Taranto; tu piglia Ulisse e rifallo gondoliere veneziano. Un trionfo! Te l’assicuro io! E vedrai che quella mo’ si fa ricca, oh! Due, trecento mila lire, come niente! Balla, comare, che fortuna suona!
2.
Ritornando a casa in vettura con la signora Ely Faciolli (la poverina non sapeva staccarsi il fazzoletto dagli occhi, ma ormai non tanto più per il cordoglio della partenza di Silvia, quanto per non scoprire i guasti che le lagrime avevano cagionato, lunghi e profondi, alla sua chimica), Giustino Boggiolo scoteva le spalle, arricciava il naso, friggeva, pareva che ce l’avesse proprio con lei. Ma no, povera signora Ely, no; lei non c’entrava per nulla.
Tre minuti prima della partenza del treno s’era attaccato a Giustino un nuovo fastidio; ne aveva pochi! quasi un pezzo di carta, uno straccio, un vilucchio, che s’attacchi al piede d’un corridore tutto compreso della gara in una pista assiepata di popolo. Il senatore Borghi, parlando con Silvia affacciata al finestrino della vettura, le aveva chiesto nientemeno il copione de La nuova colonia per pubblicarlo nella sua rassegna. Per fortuna egli aveva fatto in tempo a intromettersi, a dimostrargli che non era possibile: già tre editori, tra i primi, gli avevano fatto ricchissime profferte e ancora egli li teneva a bada tutti e tre, temendo che la diffusione del libro scemasse alquanto la curiosità del pubblico in tutte quelle città che aspettavano con febbrile impazienza la rappresentazione del dramma. Il Borghi allora, in cambio, s’era fatto promettere da Silvia una novella – lunghetta, lunghetta – per la Vita Italiana.
– Ma a quali patti, scusi? – cominciò a dire Giustino, come se avesse accanto nella vettura il senatore direttore e già ministro, e non quella sconsolata signora Ely, che non poteva davvero mostrare gli occhi e affrontare una conversazione in quello stato. – A quali patti? Bisogna vedere; bisogna intenderci, ora… Non sono più i tempi della Casa dei nani. Quel che può bastare a un nano, signora mia, diciamola com’è, non può bastare più a un gigante, ecco. La gratitudine, sissignora! Ma la gratitudine… la gratitudine prima di tutto non bisogna sfruttarla, ecco! Come dice?
Approvò, approvò più volte col capo, dentro il moccichino, la signora Ely; e Giustino seguitò:
– Al mio paese, chi sfrutta la gratitudine non solo perde ogni merito del beneficio, ma si regola… no, che dico? peggio! si regola peggio di chi nega con crudeltà un ajuto che potrebbe prestare. Questo me lo conservo, guardi! come un buon pensiero per il primo album che mi manderà lui, il signor senatore. Anzi, me l’appunto. Così lo leggerà…
Trasse dalla tasca il taccuino e prese nota del pensiero.
– Creda che se non faccio così… Ah, signora mia, signora mia! Cento teste dovrei avere, cento, e sarebbero poche! Se penso a tutto quello che devo fare, Dio, mi prende la vertigine! Ora vado all’ufficio e domando sei mesi d’aspettativa. Non posso farne di meno. E se non me l’accordano? Mi dica lei… Se non me l’accordano? Sarà un affar serio; mi vedrò costretto a… a… Come dice?
Disse qualche altra cosa dentro il moccichino la signora Ely, qualche altra cosa che non volle ridire né manifestar per segni: solamente alzò un poco le spalle. E allora Giustino:
– Ma veda, per forza… Vedrà che per forza mi costringeranno a dare un calcio all’ufficio! E poi cominceranno a dire, uh, ne sono sicuro!, che vivo alle spalle di mia moglie. Io, già! alle spalle di mia moglie! Come se mia moglie, senza di me… roba da ridere, via! Già si vede: eccola là: se n’è andata in villeggiatura; e chi resta qua, a lavorare, a far la guerra? Guerra, sa? guerra davvero, guerra… Si entra ora in campo! Sette eserciti e cento città! Se ci resisto… Andate a pensare all’ufficio! Se domani lo perdo, per chi lo perdo? lo perdo per lei… Bah, non ci pensiamo!
Aveva tante cose per il capo, che più di qualche minuto di sfogo non poteva concedere al dispiacere anche grave che qualcuna gli cagionava. Tuttavia non potè fare a meno di ripensare, prima d’arrivare a casa, a quella tal richiesta a tradimento del senatore Borghi. Gli aveva fatto troppa stizza, ecco, anche perché, se mai, gli pareva che non alla moglie, ma a lui avrebbe dovuto rivolgersi il signor senatore. Ma, poi, Cristo santo! un po’ di discrezione! Quella poverina partiva per rimettersi in salute, per riposarsi. Se a qualche cosa poi, là a Cargiore, le fosse venuto voglia di pensare, ma avrebbe pensato a un nuovo dramma, perbacco! non a cosettine che portan via tanto tempo, e non fruttano nulla. Un po’ di discrezione, Cristo santo!
Appena arrivato a casa – paf! un altro inciampo, un altro grattacapo, un’altra ragione di stizza. Ma questa, assai più grave!
Trovò nello studiolo un giovinotto lungo lungo, smilzo smilzo, con una selva di capelli riccioluti indiavolati, pizzo ad uncino, baffi all’erta, un vecchio fazzoletto verde di seta al collo che forse nascondeva la mancanza della camicia, un farsettino nero inverdito, le cui maniche, sdrucite ai gomiti, gli lasciavano scoperti i polsi ossuti e gli facevano apparire sperticate le braccia e le mani. Lo trovò come padrone del campo, in mezzo a una mostra di venticinque pastelli disposti giro giro per la stanza, su le seggiole, su le poltrone, su la scrivania, da per tutto: venticinque pastelli tratti dalle scene culminanti de La nuova colonia.
– E scusi… e scusi… e scusi… – si mise a dire Giustino Boggiolo, entrando, stordito e sperduto, tra tutto quell’apparato. – Ma chi è lei, scusi?
– Io? – disse il giovinotto, sorridendo con aria di trionfo. – Chi sono io? Nino Pirino. Io sono Nino Pirino, pittorino tarentino, dunque compatriottino di Silvia Roncella. Lei è il marito, è vero? Piacere! Ecco, io ho fatto questa roba qua, e son venuto a mostrarla a Sjlvia Roncella, mia celebre compatriota.
– E dov’è? – fece Giustino.
Il giovinotto lo guardò, stordito.
– Dov’è? chi? come?
– Ma signor mio, è partita!
– Partita?
– Lo sa tutta Roma, perbacco! c’era tutta Roma alla stazione, e lei non lo sa! Ho tanto poco tempo io, scusi… Ma già… aspetti un momento… Scusi, queste sono scene de La nuova colonia, se non sbaglio?
– Sissignore.
– E che è roba di tutti La nuova colonia, scusi? Lei prende così le scene e… e se le appropria… Come? con qual diritto?
– Io? che dice? ma no! – fece il giovinotto. – Io sono un artista! Io ho veduto e…
– Ma nossignore! – esclamò con forza Giustino. – Che ha veduto? Ha veduto La nuova colonia di mia moglie…
– Sissignore.
– E questa è l’isola abbandonata, è vero?
– Sissignore.
– Dove l’ha mai veduta Lei? esiste forse nella realtà, nella carta geografica quest’isola? Lei non ha potuto vederla!
Il giovinotto credeva propriamente che il caso fosse da ridere, e in verità a ridere era disposto; così investito contro ogni sua aspettazione, ora si sentiva rassegare il riso su le labbra. Più che mai stordito, disse:
– Con gli occhi? con gli occhi no, certo! con gli occhi non l’ho veduta. Ma l’ho immaginata, ecco!
– Lei? Ma nossignore! – incalzò Giustino. – Mia moglie! L’ha immaginata mia moglie, non Lei! E se mia moglie non l’avesse immaginata, Lei non avrebbe dipinto lì un bel corno, glielo dico io! La proprietà…
A questo punto Nino Pirino riuscì a fare erompere la risata che gli gorgogliava dentro da un pezzo.
– La proprietà? ah sì? quale? quella dell’isola? oh bella! oh bella! oh bella! vuol esser Lei soltanto il proprietario dell’isola? il proprietario d’un’isola che non esiste?
Giustino Boggiolo, sentendolo ridere così, s’intorbidò tutto dall’ira e gridò, fremente:
– Ah, non esiste? Lo dite voi che non esiste! Esiste, esiste, esiste, sissignore! Ve lo faccio vedere io se esiste!
– L’isola?
– La proprietà! il mio diritto di proprietà letteraria! il mio diritto, il mio diritto esiste; e vedrete se saprò farlo rispettare e valere! Ci sono qua io, per questo! Tutti ormai sono avvezzi a violarlo questo diritto, che pure emana da una legge dello Stato, perdio, sacrosanta! Ma ripeto che ci sono qua io, ora, e glielo faccio vedere!
– Va bene… ma guardi… sissignore… si calmi, guardi… – gli diceva intanto il giovinotto, angustiato di vederlo in quelle furie. – Guardi, io… io non ho voluto usurpare alcun diritto, alcuna proprietà… Se lei s’arrabbia così… ma io sono pronto a lasciarle qua tutti i miei pastelli, e me ne vado. Glieli regalo e me ne vado… Mi sono inteso di fare un piacere, di fare onore alla mia compaesana… Sì, volevo anche pregarla di… di… ajutarmi col prestigio del suo nome, perché credo, via, di meritarmi qualche ajuto… Sono belli, sa? Li degni almeno d’uno sguardo, questi miei pastellini… Non c’è male, creda! Glieli regalo, e me ne vado.
Giustino Boggiolo si trovò d’un tratto disarmato e restò brutto di fronte alla generosità di quel ricchissimo straccione.
– No, nient’affatto… grazie… scusi… dicevo, discutevo per il… la… il… diritto, la proprietà, ecco. Creda che è un affar serio… come se non esistesse… Una pirateria continua nel campo letterario… Mi sono riscaldato, eh? ma perché, veda… in questo momento, mi… mi… mi… riscaldo facilmente: sono stanco, stanco, stanco da morirne; e non c’è peggio della stanchezza! Ma io devo guardarmi davanti e dietro, caro signore; devo difendere i miei interessi, Lei lo capisce bene.
– Ma certo! ma naturalmente! – esclamò Nino Pirino, rifiatando. – Però, senta… Non s’arrabbi di nuovo, per carità! Senta… crede che io non possa fare un quadro, poniamo, su… sui Promessi sposi, ecco? Leggo i Promessi sposi… ho l’impressione d’una scena… non posso dipingerla?
Giustino Boggiolo si concentrò con grande sforzo; rimase un po’ cogitabondo a stirarsi con due dita la moschetta della barba a ventaglio:
– Eh, – poi disse. – Veramente non saprei… Forse, trattandosi dell’opera d’un autore morto, già caduta da un pezzo in pubblico dominio… Non so. Bisogna che studii la questione. Qui il suo caso, a ogni modo, è diverso. Guardi! Sta di fatto che se un musicista domani mi chiede di musicare La nuova colonia – glielo dico perché sono già in trattative con due compositori, tra i primianche facendosene cavare il libretto da altri, deve pagare a me quel che io pretendo, e non poco, sa? Ora, se non sbaglio, il suo caso è lo stesso: lei per la pittura, quello per la musica…
– Veramente… già… – cominciò a dire Nino Pirino, uncinandosi vieppiù il pizzo; ma poi, d’un balzo, ricredendosi. – Ma no! sbaglia, sa! Veda… il caso è un altro! Il musicista paga perché, per il melodramma, prende le parole; ma se non prende più le parole, se riesprime solo musicalmente in una sinfonia, o che so io, le impressioni, i sentimenti suscitati in lui dal dramma della sua signora, non paga più, sa? ne può star sicuro; non paga più!
Giustino Boggiolo parò le mani come ad arrestar subito un pericolo o una minaccia.
– Parlo accademicamente, – s’affrettò allora a soggiungere il giovinotto. – Io le ho già detto perché sono venuto e, ripeto, sono pronto a lasciarle qua i miei pastelli.
Un’idea luminosa balenò in quel momento a Giustino. Il dramma, prima o poi, doveva andare a stampa. Farne un’edizione ricchissima, illustrata, con la riproduzione a colori di quei venticinque pastelli là… Ecco, il libro così non sarebbe andato per le mani di tutti; così egli avrebbe anche impedito lo sfruttamento dell’opera della moglie da parte di quel pittore; e avrebbe anche prestato a questo l’ajuto richiesto, morale e materiale, perché avrebbe imposto all’editore un adeguato compenso per quei pastelli là.
Nino Pirino si dichiarò entusiasta dell’idea e per poco non baciò le mani al suo benefattore, il quale intanto aveva avuto un altro lampo e gli faceva cenno d’aspettare che la luce gli si facesse intera.
– Ecco. Una prefazione del Gueli, al volume… Così, tutti i maligni che vanno gracchiando che al Gueli il dramma non è piaciuto… Egli è venuto questa mattina a ossequiar la mia signora alla stazione, sa? Ma possono ancora dire (li conosco bene, io!) che è stato per mera cortesia. Se il Gueli fa la prefazione… Benissimo, sì sì, benissimo. Ci andrò oggi stesso, subito com’esco dall’ufficio. Ma vede quant’altri pensieri, quant’altro da fare mi dà Lei adesso? E ho i minuti contati! Debbo partire stasera per Bologna. Basta, basta… Vedrò di pensare a tutto. Lei mi lasci qua i pastelli. Le prometto che appena passo da Milano… Dica, il suo indirizzo?
Nino Pirino si strinse i gomiti alla vita e domandò, tirando su il busto, impacciato:
– Ecco… quando… quando passerà, Lei, da Milano?
– Non so, – disse il Boggiolo. – Fra due, tre mesi al massimo…
– E allora, – sorrise Pirino, – è inutile che le dica il mio indirizzo. Di qui a tre mesi, ne avrò cangiati otto per lo meno. Nino Pirino, ferma in posta: ecco, mi scriva così.
3.
Quando, sul tardi, Giustino Boggiolo rientrò in casa (aveva appena il tempo di fare in fretta in furia le valige) era così stanco, in tale vana fissità di stordimento, che finanche alle pietre avrebbe fatto pietà. Solamente a sé stesso non ne faceva.
Appena entrato nella cupa ombra dello studiolo, si trovò senza saper come né perché tra le braccia, sul seno d’una donna che lo sorreggeva in piedi e gli carezzava la guancia pian pianino con la tepida mano profumata e gli diceva con dolce voce materna:
– Poverino… poverino… ma si sa!… ma così voi vi distruggete, caro!… oh poverino… poverino…
Ed egli, senza volontà, abbandonato, rinunziando affatto a indovinare come mai Dora Barmis fosse là, nella sua casa, al bujo, e potesse sapere ch’egli per tutte le fatiche sostenute, per i dispiaceri incontrati e la stanchezza enorme aveva quello strapotente bisogno di conforto e di riposo, si lasciava carezzare come un bambino.
Forse era entrato nello studiolo vagellando e lamentandosi.
Non ne poteva più, davvero! All’ufficio il capo lo aveva accolto a modo d’un cane, e gli aveva giurato che la domanda di sei mesi d’aspettativa non si sarebbe chiamato più Gennaro Ricoglia se non gliel’avrebbe fatta respingere, respingere, respingere. In casa del Gueli, poi… Oh Dio, che era accaduto in casa del Gueli?… Non sapeva raccapezzarsi più… Aveva sognato? Ma come? non era andato il Gueli quella mattina alla stazione? Doveva essersi impazzito… O impazzito lui, o il Gueli… Ma forse, ecco, in mezzo a tutto quel tramenio vertiginoso qualche cosa doveva essere avvenuta, a cui egli non aveva fatto caso, e per cui ora non poteva capire più nulla; neanche perché la Barmis fosse là… Forse era giusto, era naturale che fosse là… e quel conforto pietoso e carezzevole era anche opportuno, sì, e meritato… ma ora… ma ora basta, ecco.
E fece per staccarsi. Dora gli trattenne con la mano il capo sul seno:
– No, perché? Aspettate…
– Devo… le… le valige… – balbettò Giustino.
– Ma no! che dite! – gli diede su la voce Dora. – Volete partire in questo stato? Voi non potete, caro, non potete!
Giustino resistè alla pressione della mano parendogli ormai troppo quel conforto e un poco strano, benché sapesse che la Barmis spesso non si ricordava più, proprio, d’esser donna.
– Ma… ma come?… – seguitò a balbettare, – senza… senza lume qui? Che ha fatto la serva della signora Ely?
– Il lume? Non l’ho voluto io, – disse Dora. – L’avevano portato. Qua, qua, sedete con me, qua. Si sta bene al bujo… qua…
– E le valige? Chi me le fa? – domandò Giustino, pietosamente.
– Volete partire per forza?
– Signora mia…
– E se io ve l’impedissi?
Giustino, nel bujo, si sentì stringere con violenza un braccio. Più che mai sbalordito, sgomento, tremante, ripetè:
– Signora mia…
– Ma stupido! – scattò allora quella con un fremito di riso convulso, afferrandolo per l’altro braccio e scotendolo. – Stupido! stupido! Che fate? Non vedete? È stupido… sì, stupido che voi partiate così… Dove sono le valige? Saranno nella vostra camera. Dov’è la vostra camera? Su, andiamo, v’ajuterò io!
E Giustino si sentì trascinare, strappare. Reluttò, perduto, balbettando:
– Ma… ma se… se non ci portano un lume…
Una stridula risata squarciò a questo punto il bujo e parve facesse traballare tutta la casa silenziosa.
Giustino era ormai avvezzo a quei sùbiti prorompimenti d’ilarità folle nella Barmis. Trattando con lei era sempre tra perplessità ambasciose, non riuscendo mai a sapere come dovesse interpretare certi atti, certi sguardi, certi sorrisi, certe parole di lei. In quel momento, sì, in verità gli pareva chiaro che… – ma se poi si fosse sbagliato? E poi… ma che! A parte lo stato in cui si trovava… ma che! sarebbe stata una nequizia bell’e buona, di cui non si sentiva capace.
Trovò in questa coscienza della sua inespugnabile onestà coniugale il coraggio di accendere risolutamente e anche con un certo sdegno un fiammifero.
Una nuova, più stridula, più folle risata assalì e scontorse la Barmis alla vista di lui con quel fiammifero acceso tra le dita.
– Ma perché? – domandò Giustino con stizza. – Al bujo… certo che…
Ci volle un bel pezzo prima che Dora si riavesse da quella convulsione di riso e prendesse a ricomporsi, ad asciugarsi le lagrime. Intanto egli aveva acceso una candela trovata su la scrivania, dopo aver fatto volare tre dei pastelli del Pirino.
– Ah, vent’anni! vent’anni! vent’anni! – fremette Dora alla fine. – Sapete, gli uomini? stecchini mi parevano! Qua, tra i denti, spezzati, e via! Sciocchezze! sciocchezze! L’anima, adesso, l’anima, l’anima… Dov’è l’anima? Dio! Dio! Ah, come fa bene respirare… Dite, Boggiolo: per voi dov’è? dentro o fuori? dico l’anima! Dentro di noi o fuori di noi? Sta tutto qui! Voi dite dentro? Io dico fuori. L’anima è fuori, caro; l’anima è tutto; e noi, morti, non saremo più nulla, caro, più nulla, più nulla… Su, fate lume! Queste valige subito… V’ajuterò io… Sul serio!
– Troppo buona – disse Giustino, mogio mogio, sbigottito, avviandosi innanzi, con la candela, verso la camera.
Dora, appena entrata, guardò il letto a due, guardò in giro tutti gli altri mobili più che modesti, sotto il tetto basso:
– Ah, qua… – disse. – Bene, sì… Che buono odor di casa, di famiglia, di provincia… Sì, sì… bene… beato voi, caro! Sempre così! Ma dovete far presto. A che ora parte la corsa? Ih, subito… Su, su, senza perder tempo…
E prese a disporre con sveltezza e maestria nelle due valige aperte sul letto le robe che Giustino cavava dal cassettone e le porgeva. Frattanto:
– Sapete perché son venuta? Volevo avvertirvi che la Carmi… tutti gli attori della Compagnia… ma specialmente la Carmi, caro mio, sono su le furie!
– E perché? – domandò Giustino, restando.
– Ma vostra moglie, caro, non ve ne siete accorto? – rispose Dora, facendogli cenno con le mani di non arrestarsi. – Vostra moglie… forse, poverina, perché ancora così… li ha accolti male, male, male…
Giustino, inghiottendo amaro, chinò più volte il capo, per significare che se n’era accorto e doluto tanto.
– Bisogna riparare! – riprese la Barmis. – Voi appena da Bologna raggiungerete a Napoli la Compagnia… Ecco, la Carmi si vuol vendicare a tutti i costi; voi dovete assolutamente ajutarla a vendicarsi.
– Io? come? – domandò Giustino, di nuovo stordito.
– Oh Dio! – esclamò la Barmis, stringendosi ne le spalle. – Non pretenderete che ve l’insegni io, come. È difficile con voi… Ma quando una donna si vuole vendicare di un’altra… Guardate, la donna può essere anche buona verso un uomo, specialmente se egli le si dà come un fanciullo… Ma verso un’altra donna la donna è perfida, caro mio; capace di tutto poi, se crede d’averne ricevuto un affronto, uno sgarbo. E poi l’invidia! Sapeste quanta invidia tra le donne, e come le rende cattive! Voi siete un bravo giovane, un gran brav’uomo… enormemente bravo, capisco; ma, se volete fare i vostri interessi, ècco… dovete… dovete sforzarvi… farvi un po’ di violenza magari… Del resto, starete parecchi mesi lontano da vostra moglie, è vero? Ora, via, non mi darete a intendere…
– Ma no! ma no, creda, signora mia! – esclamò Giustino. – Io non ci penso! Non ho neanche il tempo di pensarci! Per me, ho preso moglie, e basta!
– Siete appadronato?
– È finita! non ci penso più! Tutte le donne per me sono come uomini, ecco; non ci faccio più alcuna differenza. Donna per me è mia moglie, e basta. Forse per le donne è un’altra cosa… ma per gli uomini, creda pure, almeno per me… L’uomo ha tant’altre cose a cui pensare… Si figuri se io, tra tanti pensieri, con tanto da fare…
– Oh Dio, lo so! ma io dico nel vostro stesso interesse, non volete capirlo? – riprese la Barmis, trattenendosi a stento di ridere e affondando il capo nelle valige. – Se voi volete fare i vostri interessi, caro… Per voi, sta bene; ma dovete trattar con donne per forza: attrici, giornaliste… E se non fate come vogliono loro? Se non le seguite nel loro istinto? sia pur malvagio, d’accordo! Se queste donne invidiano vostra moglie? se vogliono vendicarsi… capite? Dico nel vostro stesso interesse… Sono necessità, caro, che volete farci? necessità della vita! Su, su, ecco fatto; chiudete e partiamo subito. Vi accompagnerò fino alla stazione.
In vettura, istintivamente gli prese una mano; subito si ricordò e fu lì lì per lasciargliela; ma poi… tanto, dacché c’era… Giustino non si ribellò. Pensava a quel che gli era accaduto in casa del Gueli.
– Mi spieghi Lei; io non so, – disse a Dora. – Sono andato dal Gueli…
– In casa? – domandò Dora, e subito esclamò: – Oh Dio, che avete fatto?
– Ma perché? – replicò Giustino. – Sono andato per., per chiedergli un favore… Bene. Lo crederebbe? Mi… mi ha accolto come se non mi avesse mai conosciuto…
– La Frezzi era presente? – domando la Barmis.
– Sissignora, c’era…
– E allora, che meraviglia? – disse Dora. – Non lo sapete?
– Ma scusi! – riprese Giustino. – C’è da cascar dalle nuvole! Fingere finanche di non ricordarsi più che questa mattina è stato alla stazione…
– Anche questo avete detto, lì, voi, in presenza della Frezzi? – proruppe Dora, ridendo. – Oh povero Gueli, povero Gueli! Che avete fatto, caro Boggiolo!
– Ma perché? – tornò a replicar Giustino. – Scusi, sa!… io non posso ammettere che…
– Voi! e già, siamo sempre lì! – esclamò la Barmis. – Voi volete fare i conti senza la donna! Ve lo dovete levar dal capo… Volete ottenere un favore dal Gueli? che egli abbia ancora amicizia per la vostra signora? Caro mio, dovete provarvi a fare un po’ di corte a quella sua nemica. Chi sa!
– Anche a quella?
– Non è mica brutta, vi prego di credere, Livia Frezzi! Non sarà più una… una giovinetta… ma…
– Via, non lo dica neanche per ischerzo, – fece Giustino.
– Ma io ve lo dico proprio sul serio, caro, sul serio, sul serio, – ribattè Dora. – Dovete mutar registro! Così non farete nulla…
E ancora, fino al momento che il treno si scrollò per partire, Dora Barmis seguitò a battere su quel chiodo:
– Ricordatevi… la Carmi! la Carmi!, Ajutatela a vendicarsi… Pazienza… caro… Addio!… Sforzatevi… nel vostro interesse… fatevi un po’ di violenza… Addio, caro, buone cose! addio! addio!
4.
Dov’era?
Sì, dirimpetto, oltre il prato, di là dal sentiero, sorgeva nello spiazzo erboso la chiesa antica, dedicata alla Vergine sidera scandenti, col lungo campanile dalla cuspide ottagonale e le finestre bifore e l’orologio che recava una leggenda assai strana per una chiesa: ognvno a svo modo; e accanto alla chiesa era la bianca cura con l’orto solingo, e più là, recinto da muri, il piccolo cimitero.
All’alba la voce delle campane su quelle povere tombe.
Ma forse la voce, no: il cupo ronzo che si propaga quando han finito di sonare, penetra in quelle tombe e desta un fremito nei morti, d’angoscioso desiderio.
Oh donne dei casali sparsi, lasciate, donne di Villareto e di Galleana, donne di Rufinera e di Pian del Viermo, donne di Brando e di Fornello, lasciate che a questa messa dell’alba vadano per una volta tanto esse sole le vostre antiche nonne di vote, dal cimitero; e officii il loro vecchio curato da tant’anni anch’esso sepolto, il quale forse, appena finita la messa, prima d’andare a riporsi sotterra, s’indugerà a spiare attraverso il cancelletto l’orto solingo della cura, per vedere se al nuovo curato esso sta tanto a cuore quanto stette a lui.
No, ecco… Dov’era? dov’era?
Sapeva ormai tanti luoghi e il loro nome; luoghi anche lontani da Cargiore. Era stata su Roccia Corba; sul colle di Bràida, a veder tutta la Valsusa immensa. Sapeva che il viale, qua, oltre la chiesa, scende tra i castagni e i cerri a Giaveno, ov’era anche stata, attraversando giù quella curiosa Via della Buffa, larga, a bastorovescio, tutta sonora d’acque scorrenti nel mezzo. Sapeva ch’era la voce del Sangone quella che s’udiva sempre, e più la notte, e le impediva il sonno tra tante smanie con l’immagine di tanta acqua in corsa perenne, senza requie. Sapeva che più su, per la vallata dell’Indritto, si precipita fragoroso il Sangonetto: era stata in mezzo al fragore, tra le rocce, a vederlo: gran parte delle acque devolve incanalata nei lavori di presa: lì, romorosa, libera, vorticosa, spumante, sfrenata; qui, placida pei canali, domata, assoggettata all’industria dell’uomo.
Aveva visitato tutte le frazioni di Cargiore, quei ceppi di case sparsi tra i castagni e gli ontani e i pioppi e ne sapeva il nome. Sapeva che quella a levante, lontana lontana, alta sul colle, era la Sacra di Superga. Sapeva i nomi dei monti attorno, già coperti di neve: Monte Luzera e Monte Uja e la Costa del Pagliajo e il Cugno dell’Alpet, Monte Brunello e Roccia Vrè. Quello di fronte, a mezzodì, era il monte Bocciarda; quello di là, il Rubinett.
Sapeva tutto; la avevano già informata di tutto la mamma (madama Velia, come lì la chiamavano) e la Graziella e quel caro signor Martino Prever, il pretendente. Sì, di tutto. Ma ella… dov’era? dov’era?
Si sentiva gli occhi pieni di uno splendor vago, innaturale; aveva negli orecchi come una perenne onda musicale, ch’era a un tempo voce e lume, in cui l’anima si cullava serena, con una levità prodigiosa, ma a patto che non fosse tanto indiscreta da volere intendere quella voce, fissar quel lume.
Era veramente così pieno di fremiti, come a lei pareva, il silenzio di quelle verdi alture? trapunto, quasi pinzato a tratti da zighi lunghi, esilissimi, da acuti fili di suono, da fritinnìi? Era quel fremito perenne il riso dei tanti rivoli scorrenti per borri, per zane, per botri scoscesi e cupi all’ombra di bassi ontani; rivoli che s’affrettano, in cascatelle garrule spumose, dopo avere irrigato un prato, benedetti, a far del bene altrove, a un altro campo che li aspetta, dove par che tutte le foglie li chiamino, brillando festose?
No, no, attorno a tutto – luoghi e cose e persone – ella vedeva soffusa come una vaporosa aria di sogno, per cui anche gli aspetti più vicini le sembravan lontani e quasi irreali.
Certe volte, è vero, quell’aria di sogno le si squarciava d’un tratto, e allora certi aspetti pareva le si avventassero agli occhi, diversi, nella loro nuda realtà. Turbata, urtata da quella dura fredda impassibile stupidità inanimata, che la assaltava con precisa violenza, chiudeva gli occhi e si premeva forte le mani su le tempie. Era davvero così quella tal cosa? No, non era forse neanche così! Forse, chi sa come la vedevano gli altri… se pur la vedevano! E quell’aria di sogno le si ricomponeva.
Una sera, la mamma s’era ritirata nella sua cameretta, perché le faceva male il capo. Ella era entrata con Graziella a sentir come stésse. Nella cameretta linda e modesta ardeva solo un lampadino votivo su una mensola innanzi a un antico crocefisso d’avorio; ma il plenilunio la inalbava tutta, dolcemente. Graziella, appena entrata, s’era messa a guardar dietro i vetri della finestra i prati verdi inondati di lume, e a un tratto aveva sospirato:
– Che luna, madama! Dio, par che sia raggiornato…
La mamma allora aveva voluto ch’ella aprisse la mezza imposta.
Ah che solennità d’attonito incanto! In qual sogno erano assorti quegli alti pioppi sorgenti dai prati, che la luna inondava di limpido silenzio? E a Silvia era parso che quel silenzio si raffondasse nel tempo, e aveva pensato a notti assai remote, vegliate come questa dalla Luna, e tutta quella pace attorno aveva allora acquistato agli occhi suoi un senso arcano. Da lungi, continuo, profondo, come un cupo ammonimento, il borboglìo del Sangone, ne la valle. Là presso, di tratto in tratto, un curioso stridore.
– Che stride così, Graziella? – aveva domandato la mamma.
E Graziella, affacciata alla finestra, nell’aria chiara, aveva risposto lietamente:
– Un contadino. Falcia il suo fieno, sotto la luna. Sta a raffilare la falce.
Donde aveva parlato Graziella? A Silvia era parso ch’ella avesse parlato dalla Luna.
Poco dopo, da un lontano ceppo di case s’era levato un canto dolcissimo di donne. E Graziella, parlando ancor quasi dalla Luna, aveva annunziato:
– Cantano a Rufinera…
Non una parola aveva potuto ella proferire.
Da che s’era mossa da Roma e, con quel viaggio, tante e tante imagini nuove le avevano invaso in tumulto lo spirito, da cui già appena appena si diradavano le tenebre della morte, ella notava in sé con sgomento un distacco irreparabile da tutta la sua prima vita. Non poteva più parlare né comunicar con gli altri, con tutti quelli che volevano seguitare ad aver con lei le relazioni solite finora. Le sentiva spezzate irrimediabilmente da quel distacco. Sentiva che ormai ella non apparteneva più a sé stessa.
Quel che doveva avvenire, era avvenuto.
Forse perché lassù, dove l’avevano portata, le eran mancate attorno quelle umili cose consuete, alle quali ella prima si aggrappava, nelle quali soleva trovar rifugio?
S’era trovata come sperduta lassù, e il suo dèmone ne aveva profittato. Le veniva da lui quella specie d’ebbrezza sonora in cui vaneggiava, accesa e stupita, poiché le trasformava con quei vapori di sogno tutte le cose.
E lui, lui faceva sì che di tratto in tratto la stupidità di esse le s’avventasse agli occhi, squarciando quei vapori.
Era un dispetto atroce. Specialmente di tutte quelle cose ch’ella aveva voluto e avrebbe ancora voluto aver più care e sacre, esso si divertiva ad avventarle agli occhi la stupidità; e non rispettava neppure il suo bambino, la sua maternità! Le suggeriva che stupidi l’una e l’altro non sarebbero più stati solo a patto ch’ella, mercé lui, ne facesse una bella creazione. E che così era di quelle cose, come di tutte le altre. E che soltanto per creare ella era nata, e non già per produrre materialmente stupide cose, né per impacciarsi e perdersi tra esse.
Là, nella vallata dell’Indritto, che c’era? L’acqua incanalata, saggia, buona massaja, e l’acqua libera, fragorosa, spumante. Ella doveva esser questa, e non già quella.
Ecco: sonava l’ora… Come diceva l’orologio del campanile? OGNVNO A SVO MODO.
Verrà tra poco, senza fin, la neve,
e case e prati, tutto sarà bianco,
il tetto, il campami di quella pieve,
donde ora, all’alba, qual dal chiuso un branco
di pecorelle, escono per due porte
le borghigiane, ed hanno il damo a fianco.
Hanno pensato all’anima, alla morte
(qua presso è il cimiter pieno di croci);
le riprende or la vita, e parlan forte,
liete di riudir le loro voci
nell’aria nuova del festivo giorno,
tra i rivoli che corrono veloci
tra i prati che verdeggiano d’intorno.
Ecco ecco, così! A suo MODO. Ma no! ma che! Ella finora non aveva mai scritto un verso! Non sapeva neppure come si facesse a scriverne… – Come? Oh bella! Ma così, come aveva fatto! Così come cantavano dentro… Non i versi, le cose.
Veramente le cantavano dentro tutte le cose, e tutte le si trasfiguravano, le si rivelavano in nuovi improvvisi aspetti fantastici. Ed ella godeva d’una gioja quasi divina.
Quelle nuvole e quei monti… Spesso i monti parevano nuvoloni lontani impietrati, e le nuvole montagne d’aria nere grevi cupe. Avevano le nuvole verso quei monti un gran da fare! Ora tonando e lampeggiando li assalivano con furibondi impeti di rabbia; ora languide, morbide si sdrajavano su i loro fianchi e li avvolgevano carezzose. Ma né di quelle furie né di questi languori pareva che essi si curassero levati, con le azzurre fronti al cielo, assorti nel mistero dei più remoti evi racchiuso in loro. Femmine, e nuvole! I monti amavano la neve.
E quel prato lassù, di quella stagione, coperto di margherite? S’era sognato?O aveva voluto la terra fare uno scherzo al cielo, imbiancando di fiori quel lembo, prima che esso di neve? No, no: in certi profondi, umidi recessi del bosco ancora spuntavano fiori; e di tanta vita recondita ella aveva provato quasi uno strano stupor religioso… Ah, l’uomo che prende tutto alla terra e tutto crede sia fatto per lui! Anche quella vita? No. Lì, ecco, era signore assoluto un grosso calabrone ronzante, che s’arrestava a bere con vorace violenza nei teneri e delicati calici dei fiori, che si piegavano sotto di lui. E la brutalità di quella bestia bruna, rombante, vellutata e striata d’oro offendeva come alcunché d’osceno, e faceva quasi dispetto la sommissione con cui quelle campanule tremule gracili subivan l’oltraggio di essa e restavano poi a tentennar lievi un tratto sul gambo, dopo che quella, sazia e ingorda tuttavia, se n’era oziando allontanata.
Di ritorno alla quieta casetta, soffriva di non poter più essere o almeno apparire a quella cara vecchina della suocera qual’era prima. In verità, forse perché non era mai riuscita a tenersi, a comporsi, a fissarsi in un solido e stabile concetto di sé, ella aveva sempre avvertito con viva inquietudine la straordinaria disordinata mobilità del suo essere interiore, e spesso con una meraviglia subito cancellata in sé come una vergogna, aveva sorpreso tanti moti incoscienti, spontanei così del suo spirito, come del suo corpo, strani, curiosissimi, quasi di guizzante bestiola incorreggibile; sempre aveva avuto una certa paura di sé e insieme una certa curiosità quasi nata dal sospetto non ci fosse in lei anche un’estranea che potesse far cose ch’ella non sapeva e non voleva, smorfie, atti anche illeciti, e altre pensarne, che non stavano proprio né in cielo né in terra; ma sì! cose orride, talvolta, addirittura incredibili, che la riempivano di stupore e di raccapriccio. Lei! lei così desiderosa di non prender mai troppo posto e di non farsi notare, anche per non avere il fastidio di molti occhi addosso! Temeva ora che la suocera non le scorgesse negli occhi quel riso che si sentiva fremere dentro ogni qualvolta nella saletta da pranzo trovava aggrondato e con le ciglia irsute, gonfio di cupa ferocia quel bravo, innocuo signor Martino Prever, geloso come una tigre dello zio Ippolito, il quale, seguitando quietamente a lisciarsi anche lì il fiocco del berretto da bersagliere e a fumar da mane a sera la lunghissima pipa, si divertiva un mondo a farlo arrabbiare.
Era anche lui, monsù Prever, un bel vecchione con una barba anche più lunga di quella de lo zio Ippolito, ma incolta e arruffata, con un pajo d’occhi cernii chiari da fanciullo, non ostante la ferma intenzione di farli apparire spesso feroci. Portava sempre in capo un berretto bianco di tela, con una larga visiera di cuojo. Molto ricco, cercava soltanto la compagnia della gente più umile, e la beneficava nascostamente; aveva anche edificato e dotato un asilo d’infanzia. Possedeva a Cargiore un bel villino, e su la vetta del Colle di Bràida in Valgioje una grande villa solitaria, donde si scopriva tra i castagni i faggi e le betulle tutta l’ampia, magnifica Valsusa, azzurra di vapori. In compenso dei tanti beneficii ricevuti, il paesello di Cargiore non l’aveva rieletto sindaco; e forse perciò egli schivava la compagnia delle poche persone così dette per bene. Tuttavia, non abbandonava mai il paese, neppure d’inverno.
La ragione c’era, e la sapevano tutti lì a Cargiore: quel persistente cocciuto amore per madama Velia Boggiolo. Non poteva stare, povero monsù Martino, non poteva vivere senza vederla, quella sua madamina. Tutti a Cargiore conoscevano madama Velia, e però nessuno malignava, anche sapendo che monsù Martino passava quasi tutto il giorno in casa di lei.
Egli avrebbe voluto sposarla; non voleva lei; e non voleva perché… oh Dio, perché sarebbe stato ormai inutile, all’età loro., Sposare per ridere? Non stava egli là, a casa sua, tutto il giorno da padrone? E dunque! Poteva ormai bastargli… La ricchézza? Ma era noto a tutti che, essendo il Prever senza parenti né prossimi né lontani, tutto il suo, tranne forse qualche piccolo legato ai servi, sarebbe andato un giorno, lo stesso, a madama Velia, se fosse morta dopo di lui.
Era una specie di fascino, un’attrazione misteriosa che monsù Martino aveva sentito tardi verso quella donnetta, che pure era stata sempre così quieta, umile, timida, al suo posto. Tardi lui, il signor Martino; ma un suo fratello, invece, troppo presto e con tanta violenza che, un giorno, sapendo ch’ella era già fidanzata, zitto zitto, povero ragazzo, s’era ucciso.
Eran passati più di quarant’anni, e ancora nel cuore di madama Velia ne durava, se non il rimorso, uno sbigottimento doloroso; e anche perciò, forse, pur sentendosi qualche volta imbarazzata – ecco – non diceva proprio infastidita – dalla continua presenza del Prever in casa, la sopportava con rassegnazione. Graziella anzi aveva detto a Silvia in un orecchio che madama la sopportava per timore che anche lui, monsù Martino – se ella niente niente si fosse provata ad allontanarlo un po’ – non facesse, Dio liberi, come quel suo fratellino. Ma sì, ma sì, perché… – rideva? oh non c’era mica da ridere: un filettino di pazzia dovevano proprio averlo quei Prever là, lo dicevano tutti a Cargiore, un filettino di.pazzia. Bisognava sentire come parlava solo, forte, per ore e ore, monsù… E forse lo zio, il signor Ippolito, ecco, avrebbe fatto bene a non insister tanto su quello scherzo di volerla sposar lui madama. E Graziella aveva consigliato a Silvia d’indurre lo zio a dar la baja invece a don Buti, il curato, che veniva qualche volta in casa anche lui.
– Ecco, a chiel là sì! a chiel là!
Ah, quel don Buti, che disillusione! In quella bianca canonica, con quell’orto accanto, Silvia s’era immaginato un ben altro uomo di Dio. Vi aveva trovato invece un lungo prete magro e curvo, tutto aguzzo, nel naso, negli zigomi, nel mento, e con un pajo d’occhietti tondi, sempre fissi e spaventati. Disillusione, da un canto; ma, dall’altro, che gusto aveva provato nel sentir parlare quel brav’uomo dei prodigi d’un suo vecchio cannocchiale adoperato come strumento efficacissimo di religione e però sacro a lui quasi quanto il calice dell’altar maggiore.
Gli uomini, pensava don Buti, sono peccatori perché vedon bene e belle grandi le cose vicine, quelle della terra; le cose del cielo, a cui dovrebbero pensare sopratutto, le stelle, le vedon male, invece, e piccoline, perché Dio le volle mettere troppo alte e lontane. La gente ignorante le guarda, e sì, a dis magava ch’a son bele! ma così piccoline come pajono, non le calcola, non le sa calcolare, ed ecco che tanta parte della potenza di Dio resta loro sconosciuta. Bisogna far vedere agli ignoranti che la vera grandezza è lassù. Onde, il canucial.
E ne le belle serate don Buti lo armava sul sagrato, quel suo cannocchiale, e chiamava attorno ad esso tutti i suoi parrocchiani che scendevano anche da Rufinera e da Pian del Viermo, le giovani cantando, i vecchi appoggiati al bastone, i bimbi trascinati dalle mamme, a vedere le «gran montagne» della Luna. Che risate ne facevan le rane in fondo ai botri! E pareva che anche le stelle avessero guizzi d’ilarità in cielo. Allungando, accorciando lo strumento per adattarlo alla vista di chi si chinava a guardare, don Buti regolava il turno, e si udivano da lontano, tra la confusione, i suoi strilli:
– Con un euj soul! con un euj soul!
Ma sì! specialmente le donne e i ragazzi aprivano tanto di bocca e storcevano in mille smorfie le labbra per riuscire a tener chiuso l’occhio manco e aperto il diritto, e sbuffavano e appannavan la lente del cannocchiale, mentre don Buti, credendo che già stessero a guardare, scoteva in aria le mani col pollice e l’indice congiunti ed esclamava:
– La gran potensa ’d Nosgnour, eh? la gran potensa ’d Nosgnour!
Che scenette gustose quando veniva a parlarne con lo zio Ippolito e con monsù Martino in quel caro tepido nido tra i monti, pieno di quel sicuro conforto familiare che spirava da tutti gli oggetti ormai quasi animati dagli antichi ricordi della casa, santificati dalle sante oneste cure amorose; che scenette specialmente nei giorni che pioveva e non si poteva andar fuori neanche un momento!
Ma proprio in quei giorni, appena Silvia cominciava a riassaporar la pace della vita domestica, ecco sopravvenire il procaccia carico di posta per lei, e ventate di gloria irrompevano allora là dentro a investirla, a sconvolgerla tutta, da quei fasci di giornali che il marito le spediva da questa e da quella città.
Trionfava da per tutto La nuova colonia. E la trionfatrice, la acclamata da tutte le folle, ecco, era là, in quella casettina ignorata, perduta in quel verde pianoro su le Prealpi.
Era lei, davvero? o non piuttosto un momento di lei, che era stato? Un subitaneo lume nello spirito e, nello sprazzo, là, una visione, di cui poi ella stessa provava stupore…
Davvero non sapeva più lei stessa, ora, come e perché le fosse venuta in mente quella Nuova colonia, quell’isola, con quei marinai… Ah che ridere! Non lo sapeva lei; ma lo sapevano bene, benissimo lo sapevano tutti i critici drammatici e non drammatici di tutti i giornali quotidiani e non quotidiani d’Italia. Quante ne dicevano! Quante cose scoprivano in quel suo dramma, a cui ella non si era mai neppur sognata di pensare! Oh, ma cose tutte, badiamo, che le recavano un gran piacere, perché erano la ragione appunto delle maggiori lodi; lodi che, in verità, più che a lei, che quelle cose non aveva mai pensate, andavano diritte diritte ai signori critici che ve le avevano scoperte. Ma forse, chi sa! c’erano veramente, se quelli così in prima ve le scoprivano…
Giustino nelle sue lettere frettolose si lasciava intravveder tra le righe soddisfatto, anzi contentissimo. Si rappresentava, è vero, come rapito in un turbine, e non rifiniva di lamentarsi della stanchezza estrema e delle lotte che doveva sostenere con gli amministratori delle compagnie e con gl’impresarii, delle arrabbiature che si prendeva coi comici e coi giornalisti; ma poi parlava di teatroni rigurgitanti di spettatori, di penali a cui i capicomici si sobbarcavano volentieri pur di trattenersi ancora per qualche settimana oltre i limiti dei contratti in questa e in quella «piazza» a soddisfar la richiesta di nuove repliche da parte del pubblico, che non si stancava di accorrere e di acclamare in delirio.
Leggendo quei giornali e quelle lettere, da cui le vampava innanzi agli occhi la visione affascinante di quei teatri, di tanta e tanta moltitudine che la acclamava, che acclamava lei, lei, l’autrice – Silvia si sentiva risollevare da quell’émpito tutto pungente di brividi già avvertito nella sala d’aspetto della stazione di Roma, allorché per la prima volta s’era trovata di fronte al suo trionfo, impreparata, prostrata, smarrita.
Risollevata da quell’émpito, e tutta accesa ora e vibrante, domandava a sé stessa perché non doveva esser là, lei, dove la acclamavano con tanto calore, anziché qua, nascosta, appartata, messa da canto, come se non fosse lei!
Ma sì, se non lo diceva chiaramente, lo lasciava pure intender bene Giustino, che lei lì non c’entrava, che tutto doveva far lui, lì, lui che sapeva ormai a meraviglia come si dovesse fare ogni cosa.
Eh già, lui… Se lo immaginava, lo vedeva or faccente, accaldato, or su le furie, ora esultante tra i comici, tra i giornalisti; e un senso le si destava, non d’invidia né di gelosia, ma piuttosto di smanioso fastidio, un’irritazione ancora non ben definita, tra d’angustia, di pena e di dispetto.
Che doveva pensar mai di lei e di lui tutta quella gente? di lui in ispecie, nel vederlo così? ma anche di lei? che forse era una stupida? Stupida, no, se aveva potuto scrivere quel dramma… Ma, via, una che non sapeva forse né muoversi né parlare; impresentabile?
Sì, era vero: senza di lui La nuova colonia forse non sarebbe neanche andata in iscena. Egli aveva pensato a tutto; e di tutto ella doveva essergli grata. Ma ecco, se stava bene o poteva almeno non saltar tanto agli occhi tutto quel gran da fare ch’egli s’era dato finché il nome di lei era ancor modesto, modesta la fama, e lei poteva starsene in ombra, chiusa, in disparte; ora che il trionfo era venuto a coronare tutto quel suo fervido impegno, che figura ci faceva lui, lui solo là, in mezzo ad esso? Poteva più ella starsene così in disparte, ora, e lasciar lì lui solo, esposto, come l’artefice di tutto, senza che il ridicolo investisse e coprisse insieme lui e lei? Ora che il trionfo era venuto, ora che egli alla fine – lei reluttante – era riuscito nel suo intento, a sospingerla, a lanciarla verso la luce abbagliante della gloria, ella – per forza – sì, anche contro voglia e facendosi violenza, doveva apparire, mostrarsi, farsi avanti; e lui – per forza ritrarsi, ora, non esser più così faccente, così accanito, sempre in mezzo: tutto lui!
La prima impressione del ridicolo, di cui già agli occhi suoi cominciava a vestirsi il marito, Silvia l’aveva avuta da una lettera della Barmis, nella quale si parlava del Gueli e della visita inconsulta che Giustino era andato a fargli per averne la prefazione al volume della Nuova colonia. Nelle sue lettere Giustino non gliene aveva mai fatto alcun cenno. Alcune frasi della Barmis sul Gueli, non chiare, sinuose, la avevano spinta a strappare quella lettera con schifo.
Pochi giorni dopo, le pervenne dal Gueli appunto una lettera, anch’essa non ben chiara, che le accrebbe il malumore e il turbamento. Il Gueli si scusava con lei di non poter fare la prefazione alla stampa del dramma, Con certi vaghi accenni a segrete ragioni che gli avevano impedito la prima sera di assistere all’intera rappresentazione di esso; parlava anche di certe miserie (senza dir quali) tragiche e ridicole a un tempo, che avviluppan le anime e sbarrano la via, quando non tolgano anche il respiro; e terminava con la preghiera che ella (se voleva rispondergli) anziché a casa indirizzasse la risposta presso gli ufficii di redazione della Vita Italiana, ov’egli di tanto in tanto si recava a parlar di lei col Borghi.
Silvia lacerò con dispetto anche questa lettera. Quella preghiera in coda la offese. Ma già tutta la lettera le parve un’offesa. La miseria tragica e ridicola a un tempo, di cui egli le parlava, non doveva esser altro per lui che la Frezzi; ma egli ne parlava a lei come di cosa che ella dovesse intendere e conoscer bene per propria esperienza. Ne resultava chiarissima, insomma, un’allusione al marito. E di tale allusione Silvia si offese tanto più, in quanto che già veramente cominciava a scorgere il ridicolo del marito.
L’inverno intanto s’era inoltrato, orribile su quelle alture. Piogge continue e vento e neve e nebbia, nebbia che soffocava. Se ella non avesse avuto in sé tante ragioni di smania e d’oppressione, quel tempo gliele avrebbe date. Sarebbe scappata via, sola, a raggiungere il marito, se il pensiero di lasciare il bambino prima del tempo non l’avesse trattenuta.
Aveva per quella sua creaturina momenti di tenerezza angosciosa, sentendo di non poter essere per lei una mamma quale avrebbe voluto. E anche di quest’angoscia, che il pensiero del figlio le cagionava, incolpava con rancor sordo il marito che con quel suo testardo furore la aveva tant’oltre spinta e disviata dai raccolti affetti, dalle modeste cure.
Ah forse egli se l’era già bell’e tracciato il suo piano: farla scrivere, là, come una macchina; e perché la macchina non avesse intoppi, via il figlio, isolarla; poi badare a tutto lui, fuori, gestir lui quella nuova grande azienda letteraria. Ah, no! ah no! Se lei non doveva esser più neanche madre…
Ma forse era ingiusta. Il marito nelle ultime lettere le parlava della nuova casa che, tra poco, in primavera, avrebbero avuto a Roma, e le diceva di prepararsi a uscir finalmente dal guscio, intendendo che il suo salotto fosse domani il ritrovo del fior fiore dell’arte, delle lettere, del giornalismo. Anche quest’altra idea però, di dover rappresentare una parte, la parte della «gran donna» in mezzo alla insulsa vanità di tanti letterati e giornalisti e signore così dette intellettuali, la sconcertava, le dava uggia e nausea in quei momenti.
Forse meglio, forse meglio rimaner lì nascosta, in quel nido tra i monti, accanto a quella cara vecchina e al suo bambino, lì tra il signor Prever e lo zio Ippolito, il quale anche lui diceva di non volere andar via mai più, mai più di lì, mai più – e strizzava un occhio furbescamente ammiccando a chièl, a monsù Martino, che si rodeva dentro nel sentirgli dir così.
Ah povero zio!… Mai più, mai più davvero, povero zio! Davvero lui doveva rimanere per sempre lì a Cargiore!
Una sera, mentre si affannava a gridare contro a Giustino, di cui poc’anzi era arrivata una lettera, nella quale annunziava che, messo alle strette, s’era licenziato dall’impiego; e a gridar contro il signor Prever, il quale misteriosamente si ostinava a dire che alla fin fine non sarebbe stato un gran danno, perché… perché… un giorno… chi sa! (alludeva senza dubbio alle sue disposizioni testamentarie) – tutt’a un tratto, aveva stravolto gli occhi, lo zio Ippolito, e storto la bocca come per uno sbadiglio mancato; un gran sussulto delle spalle poderose e del capo gli aveva fatto saltar su la faccia il fiocco del berretto da bersagliere; poi giù il capo sul petto, e l’estremo abbandono di tutte le membra.
Fulminato!
Quanto tempo, quante pene perdute invano dal signor Prever per andare a scovar con quel tempaccio il medico condotto, il quale alla fine venne a dire tutto affannato quel che già si sapeva; e dalla povera Graziella per condurre il curato con l’olio santo!
«Piano! piano! Non gli guastate così la bella barba!», avrebbe voluto ella dire a tutti, scostandoli, per starselo a mirare ancora per poco lì sul letto, il suo povero zio, immobile e severo, con le braccia in croce.
«– Che fa, signor Ippolito?»
«-Il giardiniere…»
E, mirandolo, non riusciva a levarsi dagli occhi quel fiocco del berretto che nell’orrendo sussulto gli era saltato su la faccia, povero zio! povero zio! Tutta una pazzia per lui e quell’impegno testardo di Giustino e la letteratura, i libri, il teatro… Ah sì; ma pazzia fors’anche tutta quanta la vita, ogni affanno, ogni cura, povero zio!
Voleva restar lì? Ed ecco, ci restava. Lì, nel piccolo cimitero, presso la bianca cura. Il suo rivale, il signor Prever che non sapeva consolarsi d’aver provato tanta stizza per la venuta di lui, ecco, gli dava ricetto nella sua gentilizia, ch’era la più bella del cimitero di Cargiore…
I giorni che seguirono quell’improvvisa morte dello zio Ippolito furono pieni per Silvia d’una dura, ottusa, orrida tetraggine, in cui più che mai le si rappresentò cruda la stupidità di tutte le cose e della vita.
Giustino seguitò a mandarle, prima da Genova, poi da Milano, poi da Venezia, fasci e fasci di giornali e lettere. Ella non li aprì, non li toccò nemmeno.
La violenza di quella morte aveva spezzato il lieve superficiale accordo di sentimenti tra lei e le persone e anche le cose che la circondavano lì; accordo che si sarebbe potuto mantenere e per breve tempo, solo a patto che nulla di grave e d’inatteso fosse venuto a scoprir l’interno degli animi e la diversità degli affetti e delle nature.
Scomparso così d’un tratto dal suo lato colui che la confortava con la sua presenza, colui che aveva nelle vene il suo stesso sangue e rappresentava la sua famiglia, si sentì sola e come in esilio in quella casa, in quei luoghi, se non proprio tra nemici, fra estranei che non potevano comprenderla, né direttamente partecipare al suo dolore, e che, col modo onde la guardavano e seguivan taciti e come in attesa tutti i suoi movimenti e gli atti con cui esprimeva il suo cordoglio, le facevano intendere ancor più e quasi vedere e toccare la sua solitudine, inasprendogliene di mano in mano la sensazione. Si vide esclusa da tutte le parti: la suocera e la bàlia, poiché il suo bambino doveva rimaner lì affidato alle loro cure, la escludevano già fin d’ora dalla sua maternità; il marito, correndo di città in città, di teatro in teatro, la escludeva dal suo trionfo; e tutti così le strappavano le cose sue più preziose e nessuno si curava di lei, lasciata lì in quel vuoto, sola. Che doveva far lei? Non aveva più nessuno della sua famiglia, morto il padre, morto ora anche lo zio; fuori e tanto lontana dal suo paese; distolta da tutte le sue abitudini; sbalzata, lanciata in una via che rifuggiva dal percorrere così, non col suo passo, liberamente, ma quasi per violenza altrui, sospinta dietro da un altro… E la suocera forse la accusava entro di sé d’aver fuorviato lei il marito, d’avergli riempito l’animo di fumo e acceso la testa fino al punto da fargli perdere l’impiego. Ma sì! ma sì! aveva già scorto chiaramente quest’accusa in qualche obliqua occhiata di lei, colta all’improvviso. Quegli occhietti vivi nel pallore del volto, che si volgevano sempre altrove, quasi a sperdere l’acume degli sguardi, dimostravano bene una certa sbigottita diffidenza di lei, un rammarico che si voleva celare, pieno d’ansie e di timori per il figliuolo.
Lo sdegno per questa ingiustizia però, anziché contro quella vecchina ignara, si ritorceva nel cuore di Silvia contro il marito lontano. Era egli cagione di quella ingiustizia, egli, accecato così dal suo furore, che non vedeva più né il male che faceva a lei, né quello che faceva a sé stesso. Bisognava arrestarlo, gridargli che la smettesse. Ma come? era possibile, ora che tant’oltre erano spinte le cose, ora che quel dramma, composto in silenzio, nell’ombra e nel segreto, aveva suscitato tanto fragore e acceso tanta luce attorno al suo nome? Come poteva giudicare ella, da quel cantuccio, senz’aver veduto ancor nulla, che cosa avrebbe dovuto o potuto fare? Avvertiva confusamente che non poteva e non doveva essere più qual’era stata finora; che doveva buttar via per sempre quel che d’angusto e di primitivo aveva voluto serbare alla sua esistenza, e dar campo invece e abbandonarsi a quella segreta potenza che aveva in sé e che finora non aveva voluto conoscer bene. Solo a pensarci, se ne sentiva turbare, rimescolar tutta dal profondo. E questo le si affermava preciso innanzi agli occhi: che, cangiata lei, non poteva più il marito restarle davanti, tra i piedi, così a cavallo della sua fama e con la tromba in bocca.
In che strani atteggiamenti da pazzi si storcevano i tronchi ischeletriti degli alberi affondati giù nella neve, con viluppi, stracci, sbrèndoli di nebbia impigliati tra gl’ispidi rami! Guardandoli dalla finestra, ella si passava macchinalmente la mano su la fronte e su gli occhi, quasi per levarseli, quegli sbrèndoli di nebbia, anche dai pensieri ispidi, atteggiati pazzescamente, come quegli alberi là, nel gelo della sua anima. Fissava su l’umida imporrita ringhiera di legno del ballatojo le gocce di pioggia in fila, pendule, lucenti su lo sfondo plumbeo del cielo. Veniva un soffio d’aria; urtava quelle gocce abbrividenti; l’una traboccava nell’altra, e tutte insieme in un rivoletto scorrevano giù per la bacchetta della ringhiera. Tra una bacchetta e l’altra ella allungava lo sguardo fino alla cura che sorgeva là dirimpetto, accanto alla chiesa; vedeva le cinque finestre verdi che guardavan l’orto solingo sotto la neve, guarnite di certe tendine, che col loro candore dicevano d’essere state lavate e stirate insieme coi mensali degli altari. Che dolcezza di pace in quella bianca cura! Li presso, il cimitero…
Silvia s’alzava all’improvviso, s’avvolgeva lo scialle attorno al capo e usciva fuori, su la neve, diretta al cimitero, per fare una visita allo zio. Dura e fredda come la morte era la tetraggine del suo spirito.
Cominciò a rompersi questa tetraggine col sopravvenire della primavera, allorché la suocera, che la aveva tanto pregata di non andar tutti i giorni con quella neve, con quel vento, con quella pioggia al cimitero, si mise invece a pregarla, or che venivano le belle giornate, ad andar con la bàlia e col piccino giù per la via di Giaveno, al sole.
Ed ella prese ad uscire col bambino. Mandava innanzi per quella via la bàlia, dicendole che la aspettasse al primo tabernacolo; ed entrava nel cimitero per la visita consueta allo zio.
Una mattina, li davanti al primo tabernacolo, trovò con la bàlia, impostato dietro una macchina fotografica, un giovane giornalista venuto su da Torino proprio per lei, o, com’egli disse, «alla scoperta di Silvia Roncella e del suo romitorio».
Quanto la fece parlare e ridere quel grazioso matto, che volle saper tutto e veder tutto e tutto fotografare e sopratutto lei in tutti gli atteggiamenti, con la bàlia e senza bàlia, col bambino e senza bambino, dichiarandosi felice addirittura di aver scoperto una miniera, una miniera affatto inesplorata, una miniera vergine, una miniera d’oro.
Quand’egli andò via, Silvia restò a lungo stupita di sé stessa. Anche lei, anche lei si era scoperta un’altra, or ora, di fronte a quel giornalista. Si era sentita felice anche lei di parlare, di parlare… E non sapeva più che cosa gli avesse detto. Tante cose! Sciocchezze? Forse… Ma aveva parlato, finalmente! Era stata lei, quale ormai doveva essere.
E godè senza fine il giorno appresso nel veder riprodotta la sua imagine in tanti diversi atteggiamenti sul giornale che quegli le mandò e nel leggere tutte le cose che le aveva fatto dire, ma sopratutto per le espressioni di meraviglia e d’entusiasmo che quel giornalista profondeva, più che per l’artista ormai celebre, per lei donna ancora a tutti ignota.
Una copia di quel giornale Silvia a sua volta volle spedir subito al marito per dargli una prova che, via – a mettercisi – non lui soltanto, ma poteva far per benino le cose anche lei.
| Suo marito – Indice
Introduzione |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com