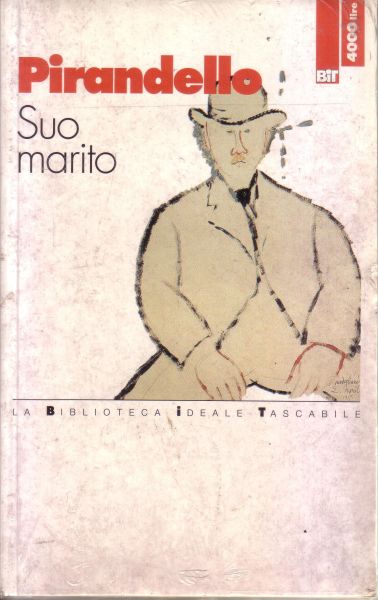««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «Suo marito» su Amazon
III. Mistress Roncella two accouchements
1.
La servotta abruzzese, che rideva sempre vedendo quel berretto da bersagliere in capo al signor Ippolito, entrò nello studiolo ad annunziare che c’era di là un signore forestiere, il quale voleva parlare col signor Giustino.
– All’Archivio!
– Se poteva riceverlo la signora, dice.
– Pollo d’india, non sai che la signora è… (e disse con le mani com’era; quindi soggiunse:) – Fallo passare. Parlerà con me.
La servotta uscì, com’era entrata, ridendo. E il signor Ippolito borbottò tra sé, stropicciandosi le mani:
«L’accomodo io».
Entrò poco dopo nello studiolo un signore biondissimo, dalla faccia rosea, da bamboccione ingenuo, con certi occhi azzurri ilari parlanti.
Ippolito Onorio Roncella accennò di levarsi con grandissima cura il berretto.
– Prego, segga pure. Qua, qua, su la poltrona. Permette ch’ io tenga in capo? Mi raffredderei.
Prese il biglietto che quel signore tra smarrito e sconcertato gli porgeva e vi lesse: C. NATHAN CROWELL.
– Inglese?
– No, signor, americano, – rispose il Crowell, quasi incidendo con la pronunzia le sillabe. – Corrispondente giornale americano The Nation, New York. Signor Bòggiolo…
– Boggiòlo, scusi.
– Ah! Boggiòlo, grazie. Signor – Boggiòlo – accordato – intervista – su – nuova – grande – opera grande – scrittrice – italiana – Silvia – Roncella.
– Per questa mattina? – domandò il signor Ippolito, parando le mani. (Ah che vellicazione al ventre gli producevano lo stile telegrafico e lo stento della pronunzia di quel forestiere!)
Il signor Crowell si alzò, trasse di tasca un taccuino e mostrò in una paginetta l’appunto scritto a lapis: Mr oggiolo, Thursday, 23 (morning).
– Benissimo. Non capisco; ma fa lo stesso, – disse il signor Ippolito. – S’accomodi. Mio nipote, come vede, non c’è.
– Ni – pote?
– Sissignore. Giustino Boggiolo, mio ni – po – te… Nipote, sa? sarebbe… nepos, in latino; neveu, in francese. L’inglese non lo so… Lei capisce l’italiano?
– Sì, poco, – rispose, sempre più smarrito e sconcertato, il signor Crowell.
– Meno male, – riprese il signor Ippolito. – Ma nipote, intanto, eh?… Veramente, mio nipote, non lo capisco neanche io. Lasciamo andare. C’è stato un contrattempo, veda.
Il signor Crowell s’agitò un poco su la seggiola, come se certe parole gli facessero proprio male e credesse di non meritarsele.
– Ecco, le spiego, – disse il signor Ippolito, agitandosi un poco anche lui. – Giustino è andato all’ufficio… uffi – uf – fi – ciò, all’ufficio, sissignore (Archivio Notarile). È andato per domandare il permesso… – ancora, già! e perderà l’impiego, glielo dico io! – il permesso d’assentarsi, perché jersera noi abbiamo avuto una bella consolazione.
A quest’annunzio il signor Crowell rimase dapprima un po’ perplesso, poi tutt’a un tratto ebbe un prorompimento di vivissima ilarità, come se finalmente gli si fosse fatta la luce.
– Conciolescione? – ripetè, con gli occhi pieni di lagrime. – Veramente, conciolescione?
Questa volta ci restò brutto il signor Ippolito, invece.
– Ma no, sa! – disse irritato. – Che ha capito? Abbiamo ricevuto da Cargiore un telegramma con cui la signora Velia Bòggiolo, che sarebbe la mamma di Giustino, sissignore, ci annunzia per oggi la sua venuta; e non c’è mica da stare allegri, perché viene per assistere Silvia, mia nipote, la quale finalmente… siamo lì lì: tra pochi giorni, o maschio o femmina. E speriamo tutti che sia maschio, perché, se nasce femmina e si mette a scrivere anche lei, Dio ne liberi e scampi, caro signore! Ha capito?
(«Scommetto che non ha capito un corno!», borbottò tra sé, guardandolo.)
Il signor Crowell gli sorrise.
Il signor Ippolito, allora, sorrise anche lui al signor Crowell. E tutti e due, così sorridenti, si guardarono un pezzo. Che bella cosa, eh? Sicuro… sicuro…
Bisognava riprendere daccapo la conversazione, adesso.
– Mi pare che Lei tanto tanto non lo… non lo… mastichi, ecco, l’italiano, – disse bonariamente il signor Ippolito: – Scusi, part… par – to – ri – re, almeno…
– Oh, sì, partorire, benissimo, – affermò il Crowell.
– Sia lodato Dio! – esclamò il Roncella. – Ora, mia nipote…
– Grande opera? dramma?
– Nossignore: figliuolo. Figliuolo di carne. Ih, com’è duro lei d’intendere certe cose! Io che voglio parlare con creanza. Il dramma è già partorito. Sono cominciate le prove l’altro jeri, a teatro. E forse, sa? verranno alla luce tutt’e due insieme, dramma e figliuolo. Due parti… cioè, parti, sì, plurale di parto… parti nel senso di… di… partorì… là, partorizioni, capisce?
Il signor Crowell diventò molto serio; s’eresse su la vita; impallidì; disse:
– Molto interessante.
E, tratto di tasca un altro taccuino, prese frettolosamente l’appunto: Mrs. Roncella two accouchements.
– Ma creda pure, – riprese Ippolito Onorio Roncella, sollevato e contento, – che questo è nulla. C’è ben altro! Lei crede che meriti tanta considerazione mia nipote Silvia? Non dico di no; sarà una grande scrittrice. Ma c’è qualcuno molto più grande di lei, in questa casa, e che merita d’esser preso in maggior considerazione dalla stampa internazionale.
– Veramente? Qua? In questa casa? – domandò, sbarrando gli occhi, il signor Crowell.
– Sissignore, – rispose il Roncella. – Mica io, sa! Il marito, il marito di Silvia…
– Mister Bòggiolo?
– Se lei lo vuol chiamare Bòggiolo, si serva pure, ma le ho detto che si chiama Boggiòlo. Incommensurabilmente più grande. Guardi, Silvia stessa, mia nipote, riconosce che lei non sarebbe nulla, o ben poco, senza di lui.
– Molto interessante, – ripetè con la stessa aria di prima il signor Crowell, ma un po’ più pallido.
E Ippolito Onorio Roncella:
– Sissignore. E se Lei vuole, potrei parlarle di lui fino a domattina. E Lei mi ringrazierebbe.
– Oh, sì, io molto ringraziare, signore, – disse alzandosi e inchinandosi più volte il signor Crowell.
– No, dicevo, – riprese il signor Ippolito, – segga segga, per carità! Mi ringrazierebbe, dicevo, perché la sua… come la chiama? intervista, già, già, intervista… la sua intervista riuscirebbe molto più… più… saporita, diremo, che se riferisse notizie sul nuovo dramma di Silvia. Già io poco potrei dargliene, perché la letteratura non è affar mio, e non ho mai letto un rigo, che si dice un rigo, di mia nipote. Per principio, sa? e un po’ anche per stabilire un certo equilibrio salutare in famiglia. Ne legge tanti lui, mio nipote! E li leggesse soltanto… Scusi, è vero che in America i letterati sono pagati a tanto per parola?
Il signor Crowell s’affrettò a dir di sì e aggiunse che ogni parola degli scrittori più famosi soleva esser pagata anche una lira, anche due e perfino due lire e cinquanta centesimi, in moneta nostrale.
– Gesù! Gesù! – esclamò il signor Ippolito. – Scrivo, per esempio, ohibò, due lire e cinquanta? E allora, figuriamoci, gli Americani non scriveranno mai quasi, già, scriveranno sempre quasi quasi, già già… Ora comprendo perché quel povero figliuolo… Ah dev’essere uno strazio per lui contare tutte le parole che gli sgorbia la moglie e pensare quanto guadagnerebbe in America. Per ciò dice sempre che l’Italia è un paese di straccioni e d’analfabeti… Caro signore, da noi le parole vanno più a buon mercato; anzi si può dire che siano l’unica cosa che vada a buon mercato; e per questo ci sfoghiamo tanto a chiacchierare e si può dire che non facciamo altro…
Chi sa dove sarebbe arrivato il signor Ippolito quella mattina, se non fosse sopravvenuto a precipizio Giustino Boggiòlo a levargli dalle grinfie quella vittima innocente.
Giustino non tirava più fiato: acceso in volto e in sudore, volse un’occhiata feroce allo zio e poi, tartagliando in inglese, si scusò del ritardo col signor Crowell e lo pregò che fosse contento di rimandare alla sera l’intervista, perché adesso egli aveva le furie: doveva recarsi alla stazione a prendere la madre, poi al Valle per la prova del dramma, poi…
– Ma se lo stavo servendo io! – gli disse il signor Ippolito.
– Lei dovrebbe almeno farmi il piacere di non immischiarsi in queste faccende, – non potè tenersi di rispondergli Giustino. – Pare che me lo faccia apposta, scusi!
Si volse di nuovo all’Americano; lo pregò di attenderlo un istante: voleva vedere di là come stésse la moglie; sarebbero poi andati via insieme.
– Perde l’impiego, perde l’impiego, com’è vero Dio! – ripetè il signor Ippolito, stropicciandosi di nuovo contentone le mani, appena Giustino varcò la soglia.
– Ha perduto la testa; ora perde l’impiego.
Il signor Crowell tornò a sorridergli.
All’Archivio Giustino aveva litigato davvero col Capo-Archi vista, che non voleva concedergli d’assentarsi anche di mattina, dopo avere ottenuto per parecchi giorni di fila la licenza di non ritornare in ufficio nel pomeriggio per potere assistere alle prove.
– Troppo, – gli aveva detto, – troppo, caro signor Roncello!
– Roncello? – aveva esclamato Giustino, restando.
Ignorava che all’Archivio tutti i compagni d’ufficio lo chiamavano così, quasi senza farci più caso.
– Boggiòlo, già… scusi, Boggiòlo, – s’era ripreso subito il Capo-Archivista. – Scambiavo col nome della sua egregia signora. Del resto, mi sembra naturalissimo.
– Come!
– Non se n’abbia per male, e permetta anzi che glie lo dica paternamente: lei stesso, cav. Boggiòlo, pare che faccia di tutto per… sì, per posporsi alla sua signora. Lei sarebbe un bravo impiegato, attento, intelligente… ma debbo dirglielo? Troppo… troppo per la moglie, ecco.
– È Silvia Roncella, mia moglie, – aveva mormorato Giustino.
E il Capo-Archivista:
– Tanto piacere! Mia moglie è donna Rosolina Caruso! Capirà che questa non è una buona ragione perché io non faccia qua il mio dovere. Per questa mattina, vada. Ma pensi bene a ciò che le ho detto.
Liberatosi a piè della scala del signor Crowell, Giustino Boggiolo, molto seccato da tutte quelle piccole e volgari contrarietà alla vigilia della grande battaglia, s’avviò quasi di corsa per la stazione, tenendo tuttavia un libro aperto sotto gli occhi: la grammatica inglese.
Superata l’erta di Santa Susanna, si cacciò il libro sotto il braccio; guardò l’orologio, cavò dalla tasca del panciotto una lira e la ficcò subito in un portamonete che teneva nella tasca posteriore dei pantaloni; poi trasse un taccuino e vi scrisse col lapis:
Vettura stazione… L. 1,00
L’aveva guadagnata. Fra cinque minuti sarebbe giunto alla stazione, in tempo per il treno che arrivava da Torino. Era, sì, accaldatuccio e affannatello, ma… – una lira è sempre una lira.
A chi avesse avuto la leggerezza di accusarlo di tirchieria, Giustino Boggiolo avrebbe potuto dare a sfogliare un po’ quel suo taccuino, dov’erano le prove più lampanti non pure di quanto egli, anzi, fosse splendido nelle intenzioni, ma anche della generosità de’ suoi sentimenti e della nobiltà de’ suoi pensieri, della larghezza delle sue vedute, non che dell’inclinazione che avrebbe avuto deplorabilissima – allo spendere.
In quel taccuino erano, infatti, segnati tutti i denari ch’egli avrebbe speso, se si fosse sbilanciato. E rappresentavano lotte d’intere giornate con se stesso alcune di quelle cifre, e cavillazoni penose, e un volgere e rivolgere infinito di contrarie ragioni e calcoli d’opportunità sottilissimi: Pubbliche sottoscrizioni, feste di beneficenza per calamità cittadine o nazionali, a cui con ingegnosi sotterfugi, senza far cattive figure, non aveva partecipato; elegantissimi cappellini per la moglie da trentacinque, da quaranta lire cadauno, che non aveva mai comperati: poltrone di teatro da lire venti per straordinarie rappresentazioni, a cui non aveva mai assistito; e poi… e poi quante spesucce giornaliere, segnate lì a testimonianza, almeno, del suo buon cuore! Vedeva, per esempio, andando all’ufficio o tornandone, un poverello cieco, che destava veramente pietà? Ma egli, prima d’ogni altro passante, se ne impietosiva; si fermava a considerar da lontano la miseria di quell’infelice; diceva a se stesso:
«Chi non gli darebbe due soldini?».
E spesso li traeva realmente dal portamonete del panciotto, ed era lì lì per avvicinarsi a porgerli, quand’ecco una considerazione e poi un’altra e poi tante insieme, angustiose, gli facevano alzar le ciglia, tirar fiato, abbassar la mano e gliela guidavano pian pianino al portamonete dei pantaloni, e quindi a segnar nel taccuino con un sospiro: Elemosina, lire zero,centesimi dieci. Perché una cosa è il buon cuore, un’altra la moneta; tiranno il buon cuore, più tiranna la moneta; e costa più pena il non dare, che il dare, quando non si può.
Già già la famiglia cominciava a crescere, ohè; e chi ne portava il peso? Sicché dunque, più della soddisfazione che in quel tal giorno egli aveva avuto un desiderio gentile, una generosa intenzione, l’impulso a soccorrere l’umana miseria, non poteva concedersi, in coscienza di galantuomo.
2.
Non rivedeva la madre da più di quattro anni, da quando cioè lo avevano sbalestrato a Taranto. Quante cose erano avvenute in quei quattro anni, e come si sentiva cambiato, ora che l’imminente arrivo della madre lo richiamava alla vita che aveva vissuto con lei, agli umili e santi affetti rigorosamente custoditi, ai modesti pensieri, da cui per tante vicende imprevedute egli s’era staccato e allontanato!
Quella vita quieta e romita, tra le nevi e il verde de’ prati sonori d’acqua, fracastagni del suo Cargiore vegliato dal borboglìo perenne del Sangone, quegli affetti, quei pensieri egli avrebbe riabbracciato tra breve in sua madre, ma con un penoso disagio interno, con non tranquilla coscienza.
Sposando, egli aveva nascosto alla madre che Silvia fosse una letterata; le aveva parlato a lungo, invece, nelle sue lettere, delle qualità di lei che alla madre sarebbero riuscite più accétte; vere, pertanto; ma appunto per ciò sentiva ora più spinoso il disagio: ché proprio lui aveva indotto la moglie a trascurare quelle qualità; e se ora Silvia dal libro spiccava un salto al palcoscenico, a questo salto la aveva spinta lui. E se ne sarebbe accorta bene la madre in quel momento, trovando Silvia derelitta e bisognosa soltanto di cure materne, lontanissima da ogni pensiero che non si riferisse al suo stato miserevole; trovando lui invece, là, tra i comici, in mezzo alle brighe d’una prima rappresentazione.
Non era più un ragazzo, è vero; doveva ormai regolarsi con la propria testa; e non vedeva nulla di male, del resto, in ciò che faceva; tuttavia da buon figliuolo com’era sempre stato, obbediente e sottomesso alla volontà e incline ai desiderii, al modo di pensare e di sentire della sua buona mamma, si turbava al pensiero di non aver l’approvazione di lei, di far cosa che a lei, anzi, certamente doveva dispiacere, e non poco. Tanto più se ne turbava, in quanto prevedeva che la sua santa vecchierella, venuta per amor suo da così lontano a soffrire con la nuora, non gli avrebbe in alcun modo manifestato la sua riprovazione, né mosso il minimo rimprovero.
Molta gente attendeva con lui il treno da Torino, già in ritardo. Per stornarsi da quei pensieri molesti egli si forzava d’attendere alla grammatica inglese, andando su e giù per la banchina; ma a ogni fischio di treno si voltava o s’arrestava.
Fu dato finalmente il segno dell’arrivo. I numerosi aspettanti s’affollarono, con gli occhi al convoglio che entrava sbuffante e strepitoso nella stazione. Si schiusero i primi sportelli; la gente accorse con varia ansia, cercando da una vettura all’altra.
– Eccola! – disse Giustino, ilarandosi e cacciandosi tra la ressa, per raggiungere una delle ultime vetture di seconda classe, da cui s’era sporta con aria smarrita la testa d’una vecchina pallida, vestita di nero. – Mamma! Mamma!
Questa si volse, alzò una mano e gli sorrise con gli occhi neri, intensi, la cui vivacità contrastava col pallore del volto già appassito dagli anni.
Nella gioja di rivedere il figliuolo la piccola signora Velia cercò quasi un rifugio dallo sbalordimento che la aveva oppressa durante il lungo viaggio e dalle tante e nuove impressioni che le avevano tumultuosamente investito la stanca anima, chiusa e ristretta ormai da anni e anni nelle abituali relazioni dell’angusta e timida sua vita.
Era come intronata e rispondeva a monosillabi. Le pareva diventato un altro il figliuolo, tra tanta gente e tanta confusione; anche il suono della voce, lo sguardo, tutta l’aria del volto le parevano cangiati. E la stessa impressione aveva Giustino della vista della madre. Sentivano entrambi che qualcosa tra loro s’era come allentata, disgiunta: quell’intimità naturale, che prima impediva loro di vedersi così come si vedevano adesso; non più come un essere solo, ma due; non già diversi, ma staccati. E non s’era egli difatti nutrito, lontano da lei – pensava la madre – d’una vita che le era ignota? non aveva egli adesso un’altra donna accanto, ch’ella non conosceva e che certo doveva essergli cara più di lei? Tuttavia, quando si vide sola, finalmente, con lui nella vettura, e vide salvi la valigia e il sacchetto che aveva portati con sé, si sentì sollevata e confortata.
– Tua moglie? – domandò poi, dando a vedere nel tono della voce e nello sguardo, che ne aveva una grande suggezione.
– T’aspetta con tanta ansia, – le rispose Giustino. – Soffre molto…
– Eh, poverina… – sospirò la signora Velia, socchiudendo gli occhi. – Ho paura però, che io poco… poco potrò fare… perché forse per lei… non sarò…
– Ma che! – la interruppe Giustino. – Non ti mettere in capo codeste prevenzioni, mamma! Tu vedrai quanto è buona…
– Lo credo, lo so bene, – s’affrettò a dire la signora Velia. – Dico per me…
– Perché ti figuri che una che scrive, – soggiunse Giustino, – debba essere per forza una… una smorfiosa? aver fumi?… Nient’affatto! Vedrai. Troppo… troppo modesta, anzi… È la mia disperazione! E poi, sì, in quello stato… Via, via, mammina, è come te, sai? senza differenza…
La vecchietta approvò col capo. Le ferirono il cuore quelle parole. Lei era la mamma; e un’altra donna, adesso, per il figliuolo era come lei, senza differenza… Ma approvò, approvò col capo.
– Faccio tutto io! – seguitò Giustino. – Gli affari li tratto io. Del resto, ohè, a Roma, cara mamma… che! tutto il doppio… non te lo puoi neanche figurare! e se non ci s’ajuta in tutti i modi… Lei lavora a casa; io faccio fruttare il suo lavoro fuori…
– E… frutta, frutta? – domandò timidamente la madre, cercando di smorzare l’acume degli occhi.
– Perché ci sono io, che lo faccio fruttare! – rispose Giustino. – Opera mia, non ti figurare! Sono io… tutta opera mia… Quello che fa lei… ma sì, niente, sarebbe come niente… perché la cosa… la… la letteratura, capisci? è una cosa che… puoi farla e puoi non farla, secondo i giorni… Oggi ti viene un’idea; sai scriverla, e la scrivi… Che ti costa? Non ti costa niente! Per sé stessa, la letteratura, è niente; non dà, non darebbe frutto, se non ci fosse… se non ci fosse… se non ci fossi io, ecco! Io faccio tutto. E se lei ora è conosciuta in Italia…
– Bravo, bravo… – cercò d’interromperlo la signora Velia. Poi arrischiò: – Anche dalle nostre parti conosciuta?
– Ma anche fuori d’Italia! – esclamò Giustino. – Tratto con la Francia, io! Con la Francia, con la Germania, con la Spagna. Ora comincio con l’Inghilterra! Vedi? Studio l’inglese. Ma è un affar serio, l’Inghilterra! Basta; l’anno scorso, sai quanto? Ottomilacinquecentoquarantacinque lire, tra originali e traduzioni. Più, con le traduzioni.
– Quanto! – esclamò la signora Velia, ricadendo nella costernazione.
– E che sono? – sghignò Giustino. – Mi fai ridere… Sapessi quanto si guadagna in America, in Inghilterra! Centomila lire, come niente. Ma quest’anno, chi sa!
Invece d’attenuare, si sentiva ora spinto a esagerare da un’irritazione ch’egli di fronte a se stesso fingeva gli fosse cagionata dall’angustia mentale della madre, mentre gli era in fondo cagionata da quel disagio interno, da quel rimorso.
La madre lo guardò e abbassò subito gli occhi.
Ah, com’era tutto preso, povero figliuolo, dalle idee della moglie! Che guadagni sognava! E non le aveva domandato nulla del loro paese; appena appena a lei della salute e se aveva viaggiato bene. Sospirò e disse, come tornando di lontano:
– Ti saluta tanto la Graziella, sai?
– Ah, brava! – esclamò Giustino. – Sta bene la mia nutrice?
– Comincia a essere stolida, come me, – gli rispose la madre. – Ma, tu sai, è fidata. Anche il Prever ti saluta.
– Sempre matto? – domandò Giustino.
– Sempre, – fece la vecchietta, sorridendo.
– Ti vuole sposare ancora?
La signora Velia agitò una mano, come se cacciasse via una mosca, sorrise e ripetè:
– Matto… matto… Abbiamo già la neve a Cargiore, sai? La neve su Roccia Vrè e sul Rubinett!
– Se tutto andrà bene, – disse Giustino, – dopo il parto, chi sa che Silvia non venga su con te, a Cargiore, per alcuni mesi…
– Su, con la neve? – domandò, quasi sgomenta, la madre.
– Anzi! – esclamò Giustino. – Le piacerà tanto: non l’ha mai veduta! Io dovrò muovermi per affari, forse… Speriamo! Riparleremo poi di questo, a lungo. Tu vedrai come t’accorderai subito con Silvia che, poverina, è cresciuta senza mamma…
3.
Fu veramente così.
Fin dal primo vedersi, la signora Velia lesse negli occhi dolenti di Silvia il desiderio d’essere amata come una figliuola, e Silvia negli occhi di lei il timore e la pena di non bastare col suo affetto semplice al compito per cui il figliuolo la aveva chiamata. Subito l’una e l’altra s’affrettarono di soddisfare quel desiderio e di cancellare quel timore.
– Me l’ero immaginata proprio così! – disse Silvia, con gli occhi pieni di affettuosa e tenera riverenza. – È strano!… Mi pare che l’abbia sempre conosciuta…
– Qua, niente! – rispose la signora Velia, alzando una mano alla fronte. – Cuore, sì, figlia, quanto ne vuoi…
– Viva il pane di casa! – esclamò il signor Ippolito, consolato di veder finalmente una brava donnetta all’antica. – Cuore, cuore, sì, dice bene, signora! Cuore ci vuole e maledetta la testa! Lei che è mamma, faccia il miracolo! tolga il mantice dalle mani al suo figliuolo!
– Il mantice? – domandò la signora Velia, non comprendendo e guardando le mani di Giustino.
– Il mantice, sissignora, – rispose il signor Ippolito. – Un certo manticetto, ch’egli caccia nel buco dell’orecchio di cotesta povera figliuola, e soffia e soffia e soffia, da farle diventar la testa grossa cosi!
– Povero Giustino! – esclamò Silvia con un sorriso, rivolgendosi alla suocera. – Non gli dia retta, sa?
Giustino rideva come una lumaca nel fuoco.
– Ma va’ là, che la signora mi comprende! – riprese lo zio Ippolito. – Fortuna che codesta scioccona, signora mia, non piglia vento! Ci ha cuore anche lei, e solido sa?; se no, a quest’ora… Il cervello, un pallone… su per le nuvole… se non ci fosse un po’ di zavorra qua, nella navicella del cuore… Non scrivo, io, stia tranquilla; parlo bene, quando mi ci metto; e mia nipote mi ruba le immagini… Tutte sciocchezze!
E, scrollando le spalle, se n’andò a fumare nello studiolo.
– Un po’ matto, ma buono, – disse Silvia per rassicurar la vecchietta stordita. – Non può soffrire che Giustino…
– Già l’ho detto alla mamma! – la interruppe questi, stizzito. – Faccio tutto io. Lui fuma, e io penso a guadagnar denari! Siamo a Roma. Senti, Silvia: adesso la mamma si mette in libertà; poi si desina. Debbo subito scappare per la prova. Sai che ho i minuti contati. Oh, a proposito, volevo dirti che la Carmi…
– Oh Dio, no, Giustino! – pregò Silvia. – Non mi dir nulla oggi, per carità!
– E due! e tre! – proruppe Giustino, perdendo finalmente la pazienza. – Tutti addosso a me! E va bene… Bisogna che ti dica, cara mia! Potevi levarti la seccatura in una volta sola, ricevendo la Carmi.
– Ma come? Possibile, in questo stato? – domandò la Silvia. – Lo dica lei, mamma…
– Che vuoi che sappia la mamma! – esclamò Giustino, più che mai stizzito. – Che cos’è? Non è una donna anche lei, la Carmi? Ha marito e ha fatto figliuoli anche lei. Un’attrice… Sfido! Se il dramma si deve rappresentare, bisogna pure che ci siano le attrici! Tu non puoi andare a teatro per assistere alle prove. Ci sono io: ho pensato io a tutto. Ma capirai che se quella vuole uno schiarimento su la parte che deve rappresentare, bisogna che lo domandi a te. Riceverla, nossignore! parlarne con me, neppure! Come devo fare io?
– Poi, poi, – disse Silvia, per troncare il discorso. – Lasciami attendere alla mamma adesso.
Giustino scappò via su le furie.
Era così preso e infiammato dell’imminente battaglia, che non avvertiva al turbamento della moglie, ogni qual volta le moveva il discorso del dramma.
Deplorabile contrattempo davvero, che La nuova colonia dovesse andare in iscena, mentre Silvia si trovava in quello stato. Ma era rimasto gabbato nel computo dei mesi, Giustino: aveva calcolato che per l’ottobre la moglie sarebbe stata libera; invece…
La Compagnia Carmi-Revelli, scritturata al Valle giusto per quel mese, faceva assegnamento sopra tutto su La nuova colonia, di cui s’era accaparrata la primizia da parecchi mesi.
Il cav. uff. Claudio Revelli, direttore e capocomico, detestava cordialmente, come tutti i suoi colleghi direttori e cavalieri capicomici, i lavori drammatici italiani; ma Giustino Boggiolo in quei mesi di preparazione, ajutato da tutti quelli che, in compenso, pigliavano a goderselo, aveva saputo far tanto scampanìo attorno a quel dramma, eh’esso ormai era atteso come un vero e grande avvenimento d’arte e prometteva quasi quasi di fruttare quanto una sconcia farsaccia parigina. Credette perciò il Revelli di potere arrendersi per quella volta alle voglie ardenti e smaniose della sua consocia e prima attrice della Compagnia, signora Laura Carmi, che ostentava una fervorosa predilezione per gli scrittori di teatro italiani e un profondo disprezzo per tutte le miserie del palcoscenico; e non volle sapere di rimandar la prima rappresentazione del dramma al prossimo novembre a Napoli, perché avrebbe perduto, così facendo, non solo la priorità, ma anche, nel giro, la «piazza» di Roma; giacché un’altra Compagnia, che recitava adesso a Bologna e aspettava l’esito di Roma per mettere in iscena colà il dramma, l’avrebbe subito e per la prima offerto al giudizio del pubblico bolognese e quindi portato a Roma novissimo, in dicembre.
Giustino non poteva proprio, dunque, risparmiare alla moglie quelle trepidazioni.
Silvia aveva sofferto moltissimo durante l’estate. La signora Ely Faciolli la aveva tanto pregata e pregata d’andare con lei in villeggiatura a Catino, presso Farfa; le aveva inviato di là parecchie calorosissime lettere d’invito e cartoline illustrate; ma ella non solo non si era voluta muovere da Roma, ma non era neppur voluta uscire di casa, provando ribrezzo e quasi onta della propria deformità, parendole di vedere in essa quasi un’irrisione della natura – sconcia e crudele.
– Hai ragione, figliuola! – le diceva lo zio Ippolito. – Molto più gentile con le galline, la natura. Un uovo, e il calore materno.
– Eh già! – borbottava Giustino. – Deve nascere un pulcino, infatti…
– Ma dall’asina, caro! – gli rispondeva il signor Ippolito, – deve nascere un uomo, dall’asina? E trattare una donna come un’asina ti sembra gentile?
Silvia sorrideva pallidamente. Meno male che c’era lui in casa, lo zio, che di tratto in tratto con quei razzi la scoteva dal torpore, dall’istupidimento in cui si sentiva caduta.
Sotto il peso d’una realtà così opprimente, ella provava in quei giorni disgusto profondo di tutto quanto nel campo dell’arte è necessariamente, come nella vita stessa, convenzionale. Anche i suoi lavori, pur così spesso violentati da irruzioni improvvise di vita, quasi da sbuffi di vento e da ondate impetuose, irruzioni contrarie talvolta alla logica della sua stessa concezione, le apparivano falsi e la disgustavano.
E il dramma?
Si sforzava di non pensarci, per non agitarsi La crudezza di certe scene però la assaltava a quando a quando e le toglieva il respiro! Le pareva mostruoso, ora, quel dramma.
Aveva immaginato un’isoletta del Jonio, feracissima, già luogo di pena, abbandonata dopo un disastro tellurico, che aveva ridotto un mucchio di rovine la cittaduzza che vi sorgeva. Sgomberata dei pochi superstiti, era rimasta deserta per anni, destinata probabilmente a scomparire un giorno dalle acque.
Qua si svolgeva il dramma.
Una prima colonia di marinai d’Otranto, rozzi, primitivi, è andata di nascosto ad annidarsi tra quelle rovine, non ostante la terribile minaccia incombente su l’isola. Essi vivono là, fuori d’ogni legge, quasi fuori del tempo. Tra loro, una sola donna, la Spera, donna da trivio, ma ora lì onorata come una regina, venerata come una santa, e contesa ferocemente a colui che l’ha condotta con sé: un tal Currao, divenuto, per ciò solo, capo della colonia. Ma Currao è anche il più forte e col dominio di tutti mantiene a sé la donna, la quale in quella vita nuova è diventata un’altra, ha riacquistato le virtù native, custodisce per tutti il fuoco, è la dispensiera d’ogni conforto familiare, e ha dato a Currao un figliuolo, ch’egli adora.
Ma un giorno uno di quei marinai, il rivale più accanito di Currao, sorpreso da costui nell’atto di trarre a sé con la violenza la donna, e sopraffatto, sparisce dall’isola. Si sarà forse buttato in mare su una tavola; avrà forse raggiunto a nuoto qualche nave che passava lontana.
Di lì a qualche tempo, una nuova colonia sbarca nell’isola, guidata da quel fuggiasco: altri marinai che recano però con sé le loro donne, madri, mogli, figlie e sorelle. Quando gli uomini della prima colonia s’accorgono di questo, smettono d’osteggiarne l’approdo sotto il comando di Currao. Questi resta solo, perde d’un tratto ogni potestà; la Spera ridiventa subito per tutti quella che era prima. Ma ella non se ne duole tanto per sé, quanto per lui; s’avvede, sente che egli, prima così orgoglioso di lei, ora ne ha onta; ne sopporta in paceil disprezzo. Alla fine la Spera s’accorge che Currao, per rialzarsi di fronte a sé stesso e a gli altri, medita d’abbandonarla. Dileggiandola, alcuni giovani marinai, quelli stessi che già spasimarono tanto per lei invano, vengono a dirle ch’egli non si cura più di farle la guardia perché s’è messo a farla invece a Mita, figliuola d’un vecchio marinajo, padron Dodo, che è come il capo della nuova colonia. La Spera lo sa; e s’aggrappa ora al figliuolo, con la speranza di tener così l’uomo che le sfugge. Ma il vecchio padron Dodo, per consentire alle nozze, pretende che Currao abbia con sé il ragazzo. La Spera prega, scongiura, si rivolge ad altri perché s’interpongano. Nessuno vuol darle ascolto. Ella si reca allora a supplicare il vecchio e la sposa; ma quegli le dimostra che dev’esser più contenta che il figliuolo rimanga col padre; l’altra la assicura che il ragazzo sarà da lei ben trattato. Disperata, la donna, per non abbandonare il figliuolo e per colpire nel cuore l’uomo che l’abbandona, in un impeto di rabbia furibonda abbraccia la sua creatura e in quel terribile amplesso, ruggendo, lo soffoca. Cade un masso, dopo quel grido, e un altro, lúgubremente, nel silenzio orribile che segue al delitto; e altre grida lontane si levano dall’isola. La Spera abita in cima a un poggio, tra le rovine d’una casa crollata al tempo del primo disastro. Pare che non sia ben certa se lei stessa col suo ruggito abbia fatto crollare quei massi, abbia suscitato quelle grida d’orrore. Ma no, no, è la terra! è la terra! – Balza in piedi; sopravvengono urlanti, scontraffatti dal terrore, alcuni fuggiaschi, scampati all’estrema rovina. S’è aperta la terra! è sprofondata la terra! La Spera sente chiamarsi, sente chiamare il figliuolo con grida strazianti dalla costa del poggio; accorre, vacillando, con gli altri, si sporge di lassù a guardare raccapricciata e, tra i clamori che vengono dal basso, grida:
– Ti s’è aperta sotto i piedi? t’ha inghiottito a metà? Il figlio? Te l’avevo ucciso io con le mie mani… Muori, muori dannato!
Che impressione avrebbe fatto questo dramma? Silvia chiudeva gli occhi, vedeva in un baleno la sala del teatro, il pubblico di fronte all’opera sua, e s’atterriva. No! No! Ella lo aveva scritto per sé! Scrivendolo, non aveva pensato minimamente al pubblico, che ora lo avrebbe veduto, ascoltato, giudicato. Quei personaggi, quelle scene ella li vedeva su la carta, come li aveva scritti, traducendo con la massima fedeltà la visione interna. Ora dalla carta come sarebbero balzati vivi su la scena? con qual voce? con quali gesti? Che effetto avrebbero fatto quelle parole vive, quei movimenti reali, su le tavole del palcoscenico, tra le quinte di carta, in una realtà fittizia e posticcia?
– Vieni a vedere, le consigliava Giustino. – Non c’è bisogno nemmeno che tu salga sul palcoscenico. Potrai assistere alle prove dalle poltrone, da un palchetto vicino. Nessuno potrebbe giudicare meglio di te, consigliare, suggerire.
Silvia era tentata d’andare; ma poi, sul punto, sentiva mancarsi l’animo e le forze, aveva paura che la soverchia emozione recasse danno a quell’altro essere, che già le viveva in grembo. E poi, come presentarsi in quello stato? come parlare ai comici? No, no, chi sa che strazio sarebbe stato per lei!
– Come fanno almeno? – domandava al marito. – Ti pare che intendano la loro parte?
Giustino, di ritorno dalle prove, con gli occhi lustri e il volto pezzato di rosso, come se gli avessero dato tanti pizzichi in faccia, sbuffava, levando irosamente le mani:
– Non ci si capisce niente!
Era profondamente avvilito, Giustino. Quel palcoscenico bujo, intanfato di muffa e di polvere bagnata; quei macchinisti che martellavano sui telai, inchiodando le scene per la rappresentazione della sera; tutti i pettegolezzi e le piccinerie e la svogliatezza e la cascaggine di quei comici sparsi a gruppetti qua e là, quel suggeritore nella buca con la papalina in capo e il copione davanti, pieno di tagli e di richiami; il direttore capocomico, sempre arcigno e sgarbato, seduto presso alla buca; quello che copiava lì su un tavolinetto le parti; il trovarobe in faccende tra i cassoni, tutto sudato e sbuffante, gli avevano cagionato un disinganno crudele, che lo esasperava.
S’era fatto mandare da Taranto parecchie fotografie di marinai e popolane di Terra d’Otranto, per i figurini, e anche vesti e scialli e berretti, per modelli. Il vestiario, alla maggior parte, aveva fatto molto effetto; ma qualche stupida attrice secondaria aveva dichiarato di non volersi camuffar così da stracciona. Il Revelli, per gli scenarii tutti ad aria aperta, «selvaggi» come egli diceva, voleva lesinare. E Laura Carmi, la prima attrice, se ne fingeva indignata. Lei sola, la Carmi, era un po’ il conforto di Giustino: aveva voluto leggere le Procellarie e La casa dei nani, per introdursi più preparata – aveva detto – nella finzione del dramma; e si dichiarava entusiasta della parte di Spera: ne avrebbe fatto una «creazione»! Ma non sapeva ancora neanche lei una parola della parte; passava innanzi alla buca del suggeritore e ripeteva meccanicamente, come tutti gli altri, le battute che quello, vociando e dando le indicazioni secondo le didascalie, leggeva nel copione. Solo il caratterista Adolfo Grimi cominciava a dare qualche rilievo, qualche espressione alla parte del vecchio Padron Dodo e il Revelli a quella di Currao; ma a Giustino pareva che così l’uno che l’altro le caricassero un po’ troppo; il Grimi baritoneggiava addirittura. In confidenza e con garbo Giustino glielo aveva fatto notare; ma al Revelli non s’arrischiava, e si struggeva dentro. Avrebbe voluto domandare a questo e a quello come avrebbero fatto quel tal gesto, come avrebbero proferita quella tal frase. Alla terza o alla quarta prova, il Revelli, piccato dell’entusiasmo ostentato dalla Carmi, s’era messo a interrompere tutti, di tratto in tratto, e sgarbatamente; interrompeva tante volte proprio per un nonnulla, sul più bello, quando a Giustino pareva già che tutto andasse bene e la scena cominciasse a prender calore, ad assumer vita da sé, vincendo man mano l’indifferenza degli attori e costringendoli a colorir la voce e a muovere i primi gesti. La Grassi, ad esempio, che faceva la parte di Mita, per uno sgarbo del Revelli per poco non s’era messa a piangere. Perdio! Almeno con le donne avrebbe dovuto essere un po’ più gentile, colui! Giustino s’era fatto in quattro per consolarla.
Non s’accorgeva che sul palcoscenico parecchi comici, e sopra tutti il Grimi,lo pigliavano in giro, lo beffavano. Eran finanche arrivati, quando il Revelli non c’era, a fargli provare le «battute» più difficili del dramma.
– Come direbbe lei questo? come, quest’altro? Sentiamo.
E lui, subito! Sapeva, sapeva benissimo che avrebbe detto male; non prendeva mica sul serio gli applausi e gli urli di ammirazione di quei burloni scapati; ma almeno avrebbe fatto intravveder loro l’intenzione della moglie nello scrivere quelle… come si chiamavano? ah, già, battute… quelle battute, sicuro.
Cercava in tutti i modi d’infiammarli, d’averli cooperatori amorosi a quella suprema e decisiva impresa. Gli pareva che alcuni comici fossero un po’ sgomenti dell’arditezza di certe scene, della violenza di certe situazioni. Egli stesso, per dir la verità, non era tranquillo su più d’un punto, e qualche volta era assalito dallo sgomento anche lui, guardando dal palcoscenico la sala del teatro, tutte quelle file di poltrone e di sedie disposte lì, come in attesa, gli ordini dei palchi, tutti quei vani buj, quelle bocche d’ombra, in giro, minacciose. E poi le quinte sconnesse, le scene tirate su a metà, il disordine del palcoscenico, in quella penombra umida e polverosa, i discorsi alieni dei comici che finivan di provare qualche scena e non prestavano ascolto ai compagni ch’erano in prova, le arrabbiature del Revelli, la voce fastidiosa del suggeritore, lo sconcertavano, gli scompigliavano l’animo, gl’impedivano di costruirsi l’idea di ciò che sarebbe stato fra poche sere lo spettacolo.
Laura Carmi veniva a scuoterlo da quei subitanei abbattimenti.
– Boggiolo, ebbene? Non siamo allegri?
– Signora mia… – sospirava Giustino, aprendo le braccia respirando con piacere il profumo dell’elegantissima attrice, dalle forme provocanti, dall’espressione voluttuosa, quantunque avesse il volto quasi tutto rifatto artificialmente, gli occhi allungati, le pàlpebre annerite, le labbra invermigliate, e sotto tanta biuta s’intrav vedessero i guasti e la stanchezza.
– Su, caro! Sarà un successone, vedrete!
– Lei crede?
– Ma senza dubbio! Novità, potenza, poesia: c’è tutto! E non c’è teatro, – soggiungeva con una smorfia di disgusto. – Né personaggi, né stile, né azione, qui sentent le «théâtre». Voi comprendete?
Giustino si riconfortava.
– Senta, signora Carmi: lei dovrebbe farmi un piacere: dovrebbe farmi sentire il ruggito di Spera all’ultimo atto, quando soffoca il figlio.
– Ah, impossibile, caro mio! Quello deve nascere lì per lì. Voi scherzate? Mi lacererebbe la gola… E poi, se lo sento una volta, io stessa, anche fatto da me, addio! lo ricopio alla rappresentazione. Mi verrebbe a freddo. No, no! Deve nascere lì per lì. Ah, sublime, quell’amplesso! Rabbia d’amore e d’odio insieme. La Spera, capite? vuole quasi far rientrare in sé, nel proprio seno, il figliuolo che le vogliono strappare dalle braccia, e lo strozza! Vedrete! Sentirete!
– Sarà il suo figliuolo? – le domandava, gongolante, Giustino.
– No, strozzo il figlio di Grimi, – gli rispondeva la Carmi. – Mio figlio, caro Boggiolo, per vostra regola, non metterà mai piede sul palcoscenico. Che! che!
Finita la prova, Giustino Boggiolo scappava nelle redazioni dei giornali, a trovare qua il Lampini, Ciceroncino, là il Centanni o il Federici o il Mola, coi quali aveva stretto amicizia e per mezzo dei quali aveva già fatto conoscenza con quasi tutti i giornalisti così detti militanti della Capitale. Anche costoro, è vero, se lo pigliavano a godere, apertamente; ma non se n’aveva per male; mirava alla meta, lui. Casimiro Luna aveva saputo che all’Archivio Notarile gli storpiavano il nome. Indegnità! I cognomi si rispettano, i cognomi non si storpiano! E aveva aperto tra i colleghi una sottoscrizione a dieci centesimi per offrire al Boggiolo cento biglietti da visita stampati così:
GIUSTINO RONCELLA
nato Boggiolo
Sì, sì, benissimo. Ma lui, intanto, da Casimiro Luna aveva ottenuto un brillante articolo su tutta quanta l’opera della moglie, ed era riuscito a far rilevare da tutti i giornali la vivissima attesa del pubblico per il nuovo dramma La nuova colonia, stuzzicando la curiosità con «interviste» e «indiscrezioni».
La sera rincasava stanco morto e stralunato. La sua vecchia mamma non lo riconosceva più; ma egli ormai non era più in grado d’avvertire né allo stupore di lei né all’aria di dileggio dello zio Ippolito, come non avvertiva all’agitazione che cagionava alla moglie. Le riferiva l’esito delle prove e quel che si diceva nelle redazioni dei giornali.
– La Carmi è grande! E quella piccola Grassi, nella parte di Mita, se la vedessi: un amore! Si sono già affissi per le vie i primi manifesti a strisce. Stasera comincia la prenotazione dei posti. È un vero e proprio avvenimento, sai? Dicono che verranno i maggiori critici teatrali di Milano, di Torino, di Firenze, di Napoli e di Bologna…
La sera della vigilia ritornò a casa com’ebbro addirittura. Recava tre notizie: due luminose, come il sole; l’altra, nera, viscida e velenosa come una serpe. Il teatro, tutto venduto per tre sere; la prova generale, riuscita mirabilmente; i giornalisti più accontati e qualche letterato che vi avevano assistito, rimasti tutti quanti sbalorditi, a bocca aperta. Solo il Betti, Riccardo Betti, quel frigido imbecille tutto leccato, aveva osato dire nientemeno che La nuova colonia era «la Medea tradotta in tarentino».
– La Medea? – domandò Silvia, confusa, stordita.
Non sapeva nulla, proprio nulla, lei, della famosa maga della Colchide; aveva sì letto qualche volta quel nome, ma ignorava affatto chi fosse Medea, che avesse fatto.
– L’ho detto! l’ho detto! – gridò Giustino. – Non mi son potuto tenere… Forse ho fatto male. Infatti la Barmis, ch’era lì presente, voleva che non lo dicessi. Ma che Medea! Ma che Euripide! Per curiosità, domattina, appena arriva la signora Faciolli da Catino, fatti prestare questa benedetta Medea: dicono che è una tragedia di… di… coso… l’ho detto or ora… Stùdiale, stùdiale queste benedette cose greche, mice… non so come le chiamino… micenatiche… stùdiale! Vanno tanto oggi! Capisci che con una frase, buttata così, ti possono stroncare? La Medea tradotta in tarentino… Basta questo! Sono tanti imbecilli che non capiscono nulla, peggio di me! Li conosco adesso… oh se li conosco!
Dopo cena, la signora Velia, molto impensierita dello stato di Silvia in quegli ultimi giorni, la forzò amorosamente a uscir di casa col marito. Era già tardi, e nessuno la avrebbe veduta. Una passeggiatina pian piano le avrebbe fatto bene: ella non avrebbe dovuto mai trascurare, in tutti quei mesi, un po’ di moto.
Silvia si lasciò indurre; ma quando Giustino, a una cantonata, al gialliccio lume tremolante d’un fanale volle mostrarle il manifesto già affisso del Teatro Valle, che recava a grossi caratteri il titolo del dramma e il nome di lei e poi l’elenco dei personaggi, e sotto, ben distinto, novissimo; si sentì mancare, ebbe come una vertigine e appoggiò la fronte pallida, gelida, su la spalla di lui:
– Se morissi? – mormorò.
4.
Giustino Boggiolo arrivò tardi a teatro, e con la vettura veramente questa volta, e di trotto, avvampato, quasi avesse la febbre, e sconvolto.
Fin dalla piazzetta di Sant’Eustachio la via era ingombra, ostruita dalle vetture, tra le quali la gente si cacciava impaziente e agitata. Per non stare a far lì la coda, Giustino pagò la corsa, sguisciò tra i legni e la folla. Su la meschina facciata del teatro le grosse lampade elettriche vibravano, ronzavano, quasi partecipassero al vivo fermento di quella serata straordinaria.
Ecco Attilio Raceni su la soglia.
– Ebbene?
– Mi lasci stare! – sbuffò Giustino, con un gesto disperato. – Ci siamo! Le doglie. L’ho lasciata con le doglie!
– Santo Dio! – fece il Raceni. – Era da aspettarselo… L’emozione…
– Il diavolo! dica il diavolo, mi faccia il piacere! – replicò Giustino, fieramente irritato, girando gli occhi e provandosi ad accostarsi al botteghino, innanzi al quale si pigiava la gente per acquistare i biglietti d’ingresso.
Si levò su la punta dei piedi per vedere il cartellino affisso su lo sportello del botteghino: – Tutto esaurito.
Un signore lo urtò, di furia.
– Scusi…
– Di niente… Ma sa, è inutile, glielo dico io. Non c’è più posti. Tutto esaurito. Torni domani sera. Si ripete.
– Venga, venga, Boggiolo! – lo chiamò il Raceni. – Meglio che si faccia vedere sul palcoscenico.
– Due… quattro… uno… due… uno… tre… – gridavano intanto all’ingresso le maschere in livrea di gran gala, ritirando i biglietti.
– Ma dove si vuol ficcare tutta questa gente adesso? – domandò Giustino su le spine. – Quanti biglietti d’ingresso avranno dato via? Avrei dovuto trovarmi là di prima sera… Ma quando il diavolo ci caccia la coda! E sto in pensiero, creda, sto proprio in pensiero… Ho un brutto presentimento…
– Non dica così! – gli diede su la voce il Raceni.
– Per Silvia, dico per Silvia! – spiegò Giustino. – Mica pel dramma… L’ho lasciata, creda, molto, molto male… Speriamo che tutto vada bene… ma ho paura che… E poi, guardi, tutta questa gente… dove si ficcherà? Starà scomoda, sarà impaziente, turbolenta… Ohè, paga, e vorrà godere… Ma poteva venire la seconda sera, perdio! Si ripete… Andiamo, andiamo…
Tutto il teatro risonava d’un fragorìo vario, confuso, di gigantesco alveare. Come saziar la brama di godimento, la curiosità, i gusti, l’aspettativa di tutto quel popolo, già per il suo stesso assembramento sollevato a una vita diversa dalla comune, più vasta, più calda, più fusa?
Avvertì come uno smarrimento angoscioso, Giustino, guardando attraverso l’entrata della platea il vaso rigurgitante di spettatori. Il volto, di solito rubicondo, gli era diventato paonazzo.
Sul palcoscenico stenebrato appena da alcune lampadine elettriche accese dietro i fondali, i macchinisti e il trovarobe davano gli ultimi tocchi alla scena, mentre già con miagolii lamentosi si accordavano gli strumenti dell’orchestrina. Il direttore di scena, col campanello in mano, faceva fretta; voleva dar subito il primo segnale agli attori.
Alcuni di questi eran già pronti; la piccola Grassi parata da Mita e il Grimi da Padrón Dodo, con la barba finta, grigia e corta, il volto affumicato come un presciutto, orribile a vedere così da vicino, il berrettone marinaresco ripiegato su un orecchio, i calzoni rimboccati e i piedi che parevano scalzi, in una maglia color carne, parlavano con Tito Lampini in marsina e col Centanni e il Mola. Appena videro Giustino e il Raceni, vennero loro incontro, rumorosamente.
– Eccolo qua! – gridò il Grimi, levando le braccia. – Ebbene, come va? come va?
– Teatrone! – esclamò il Centanni.
– Contento, eh? – aggiunse il Mola.
– Coraggio! – gli disse la Grassina, stringendogli forte forte la mano.
Il Lampini gli domandò:
– La sua signora?…
– Male… male… – prese a dire Giustino.
Ma il Raceni, sgranando gli occhi, gli fece un rapido cenno col capo. Giustino comprese, abbassò le pàlpebre e aggiunse:
– Capiranno che… tanto… tanto bene non può stare…
– Ma starà bene! benone starà! benone! – fece il Grimi col suo vocione pastoso, dimenando il capo e sogghignando.
– Su, Lampini, – disse il Centanni. – L’augurio di prammatica: In bocca al lupo!
– La signora Carmi? – domandò Giustino.
– In camerino, – rispose la Grassi.
Si sentiva attraverso il sipario il rimescolìo incessante dell’ampio vaso. Mille voci confuse, prossime, lontane, rombanti, e sbatacchiar d’usci e stridore di chiavi e scalpiccio di piedi. Il mare nel fondo della scena, il Grimi vestito da marinajo, diedero a Giustino l’impressione che ci fosse un gran molo di là con tanti piroscafi in partenza. Gli orecchi presero d’un tratto a gridargli e una densa oscurità gli occupò il cervello.
– Vediamo la sala! – gli disse il Raceni, prendendolo sotto il braccio e tirandolo verso la spia del telone. – Non si lasci scappare, per carità! – aggiunse poi, piano, – che la signora è soprapparto.
– Ho capito, ho capito, – rispose Giustino, che si sentiva morir le gambe accostandosi alla ribalta.
– Senta, Raceni, lei mi dovrebbe fare il piacere di correre a casa mia a ogni fin d’atto.
– Ma s’intende! – lo interruppe il Raceni, – non c’è bisogno che me lo dica…
– Per Silvia, dicevo… – soggiunse Giustino, – per avere io notizie… Capirà che a lei non si potrà dir nulla… Ah che sciagurata congiuntura! E meno male che ho avuto la ispirazione di far venire mia madre! Poi c’è lo zio… E ho sacrificato anche quella povera signora Faciolli, che aveva tanto desiderio d’assistere allo spettacolo…
Mise l’occhio alla spia e restò sgomento a mirar prima giù nelle poltrone, in platea, poi in giro nei palchi e su al loggione formicolante di teste. Erano inquieti, impazienti lassù, vociavano, battevano le mani, pestavano i piedi. Giustino trasalì a una scampanellata furiosa del buttafuori.
– Niente! – gli disse il Raceni, trattenendolo, – è il segnale all’orchestra.
E l’orchestrina si mise a strimpellare.
Tutti, tutti i palchi erano straordinariamente affollati e non un posto vuoto in platea, e che ressa nel breve spazio dei posti all’in piedi! Giustino si sentì come arso dal soffio infocato della sala luminosa, dallo spettacolo tremendo di tanta moltitudine in attesa, che lo feriva, lo trafiggeva con gl’innumerevoli occhi. Tutti, tutti quegli occhi col loro luccichio irrequieto rendevano terribile e mostruosa la folla. Cercò di distinguere, di riconoscere qualcuno lì nelle poltrone. Ah ecco il Luna, che guardava nei palchi e inchinava il capo, sorridendo… ecco là il Betti, che puntava il binocolo. Chi sa a quanti e quante volte aveva ripetuto quella sua frase, con signorile sprezzatura:
– La Medea tradotta in tarentino.
Imbecille! Guardò di nuovo ai palchi e, seguendo le indicazioni del Raceni,cercò nel primo ordine il Gueli, nel secondo donna Francesca Lampugnani, la Bornè-Laturzi; ma non riuscì a scorgere né queste né quello. Era gonfio d’orgoglio, ora, pensando che già era uno splendido e magnifico spettacolo per sé stesso quel teatro cosi pieno, e che si doveva a lui: opera sua, frutto del suo costante, indefesso lavoro, la considerazione di cui godeva la moglie, la fama di lei. L’autore, il vero autore di tutto, era lui.
– Boggiolo! Boggiolo!
Si volse: gli stava davanti Dora Barmis, raggiante.
– Che magnificenza! Non ho mai visto un teatro simile! Un mago, siete un mago, Boggiolo! Una vera magnificenza, à ne voir que les dehors. E che miracolo, avete visto? È in teatro Livia Frezzi! Dicono che sia già terribilmente gelosa di vostra moglie.
– Di mia moglie? – esclamò Giustino, stordito. – Perché?
Era così infatuato in quel momento, che se la Barmis gli avesse detto che la amica del Gueli e tutte le donne eh’erano in teatro deliravan per lui, lo avrebbe compreso e creduto facilmente. Ma sua moglie… – che c’entrava sua moglie? Livia Frezzi gelosa di Silvia? E perché?
– Ve ne fate? – soggiunse la Barmis. – Ma chi sa quante donne saranno tra poco gelose di Silvia Roncella! Che peccato ch’ella non sia qui! Come sta? come sta?
Giustino non ebbe tempo di risponderle. Squillarono i campanelli. Dora Barmis gli strinse forte forte la mano e scappò via. Il Raceni lo trascinò tra le quinte a destra.
Si levò il sipario, e a Giustino Boggiolo parve che gli scoperchiassero l’anima e che tutta quella moltitudine d’un tratto silenziosa s’apparecchiasse al feroce godimento del supplizio di lui, supplizio inaudito, quasi di vivisezione, ma con un che di vergognoso, come se egli fosse tutto una nudità esposta, che da un momento all’altro, per qualche falsa mossa impreveduta, potesse apparire atrocemente ridicola e sconcia.
Sapeva a memoria da capo a fondo il dramma, le parti di tutti gli attori dalla prima all’ultima battuta, e involontariamente per poco non le ripeteva ad alta voce, mentre quasi in preda a continue scosse elettriche si voltava a scatti di qua e di là con gli occhi brillanti spasimosi, i pomelli accesi, straziato, dalla lentezza dei comici, che gli pareva s’indugiassero apposta su ogni battuta per prolungargli il supplizio, come se anch’essi ci si divertissero.
Il Raceni, caritatevolmente, a un certo punto tentò di strapparlo di là, di condurlo nel camerino del Revelli, non ancora entrato in iscena; ma non riuscì a smuoverlo.
Man mano che la rappresentazione procedeva, una violenza strana, un fascino teneva e legava lì Giustino, sgomento, come al cospetto d’un fenomeno mostruoso: il dramma che sua moglie aveva scritto, ch’egli sapeva a memoria parola per parola, e che finora aveva quasi covato, ecco, si staccava da lui, si staccava da tutti, s’inalzava, s’inalzava come un pallone di carta ch’egli avesse diligentemente portato lì, in quella sera di festa, tra la folla, e che avesse a lungo e con cura trepidante sorretto su le fiamme da lui stesso suscitate perché si gonfiasse, a cui ora infine egli avesse acceso lo stoppaccio; si staccava da lui, si liberava palpitante e luminoso, si inalzava, si inalzava nel cielo, traendosi seco tutta la sua anima pericolante e quasi tirandogli le viscere, il cuore, il respiro, nell’attesa angosciosa che da un istante all’altro un buffo d’aria, una scossa di vento, non lo abbattesse da un lato, ed esso non s’incendiasse, non fosse divorato lì nell’alto dallo stesso fuoco ch’egli vi aveva acceso.
Ma dov’era il clamore della folla per quell’inalzamento?
Ecco: la mostruosità del fenomeno era questo silenzio terribile in mezzo al quale il dramma s’inalzava. Esso solo, lì, da sé e per conto suo viveva, sospendendo, anzi assorbendo la vita di tutti, strappando a lui le parole di bocca, e con le parole il fiato. E quella vita là, di cui egli ormai sentiva l’indipendenza prodigiosa, quella vita che si svolgeva ora calma e possente, ora rapida e tumultuosa in mezzo a tanto silenzio, gl’incuteva sgomento e quasi orrore, misti a un dispetto a mano a mano crescente; come se il dramma, godendo di se stesso, godendo di vivere in sé e per sé solo, sdegnasse di piacere altrui, impedisse che gli altri manifestassero il loro compiacimento, si assumesse insomma una parte troppo preponderante e troppo seria, trascurando e rimpicciolendo le cure innumerevoli ch’egli se n’era dato sinora, fino a farle apparire inutili e meschine, e compromettendo quegli interessi materiali a cui egli doveva attendere sopratutto. Se non scoppiavano applausi… se tutti restavano così sino alla fine, sospesi e intontiti… Ma com’era? che cos’era avvenuto? Tra poco il primo atto sarebbe terminato… Non un applauso… non un segno d’approvazione… niente!… Gli pareva d’impazzire… apriva e chiudeva le mani, affondandosi le unghie nelle palme, e si grattava la fronte ardente e pur bagnata di sudor freddo. Figgeva gli occhi nel viso alterato del Raceni tutto intento allo spettacolo, e gli pareva di leggervi il suo stesso sgomento… no, uno sgomento nuovo, quasi uno sbalordimento… forse quello stesso che teneva tutti gli spettatori… Per un momento temette non fosse una cosa atrocemente orrida, non mai finora perpetrata, quel dramma, e che tra poco, da un istante all’altro non scoppiasse una feroce insurrezione di tutti gli spettatori sdegnati, adontati. Ah era veramente una cosa terribile quel silenzio! Com’era? com’era? si soffriva? si godeva? Nessuno fiatava… E le grida dei comici sul palcoscenico, già all’ultima scena, rimbombavano. Ecco, ora calava la tela…
Parve a Giustino che egli, egli solo, lì dal fondale, con l’ansia sua, con la sua brama, con tutta l’anima in un tremendo sforzo supremo strappasse dalla sala, dopo un attimo eterno di voraginosa aspettazione, gli applausi, i primi applausi, secchi, stentati, come un crepitìo di sterpi, di stoppie bruciate, poi una vampata, un incendio: applausi pieni, caldi, lunghi, lunghi, strepitosi, assordanti… – e allora si sentì rilassar tutte le membra e venir meno, quasi cadendo, affogando in mezzo a quello scroscio frenetico, che durava, ecco, durava, durava ancora, incessante, crescente, senza fine…
Il Raceni lo aveva raccolto tra le braccia, sul petto, singhiozzante e lo sorreggeva, mentre quattro, cinque volte gli attori si presentavano alla ribalta, a quell’incendio là… Egli singhiozzava, rideva e singhiozzava e tremava tutto di gioja. Dalle braccia del Raceni cadde tra quelle della Carmi, e poi del Revelli, e poi del Grimi che gli stampò su le labbra, su la punta del naso e sulla guancia i colori della truccatura, perché in un impeto di commozione egli volle baciarlo a ogni costo, a ogni costo, non ostante che quegli, sapendo il guajo che ne sarebbe venuto, si schermisse. E col volto così impiastricciato, seguitò a cadere tra le braccia dei giornalisti e di tutti i conoscenti accorsi sul palcoscenico a congratularsi; non sapeva far altro; era così esausto, spossato, sfinito, che solo in quell’abbandono trovava sollievo; e ormai s’abbandonava a tutti, quasi meccanicamente; si sarebbe abbandonato anche tra le braccia dei pompieri di guardia, dei macchinisti, dei servi di scena, se finalmente a distoglierlo da quel gesto comico e compassionevole, a scuoterlo con una forte scrollatina di braccia non fosse sopravvenuta la Barmis, che lo guidò nel camerino della Carmi per fargli ripulir la faccia. Il Raceni era scappato a casa a prender notizie della moglie.
Nei corridoi, nei palchi era un gridìo, un’esagitazione, un subbuglio. Tutti gli spettatori, per tre quarti d’ora soggiogati dal fascino possente di quella creazione così nuova e straordinaria, così viva da capo a fondo d’una vita che non dava respiro, rapida, violenta, tutta lampeggiante di guizzi d’anima impreveduti, s’erano come liberati con quell’applauso frenetico, interminabile, dallo stupore che li aveva oppressi. Era in tutti adesso una gioja tumultuosa, la certezza assoluta che quella vita, la quale, nella sua novità d’atteggiamenti e d’espressioni, si dimostrava d’una saldezza così adamantina, non avrebbe potuto più frangersi per alcun urto di casi, poiché ogni arbitrio ormai, come nella stessa realtà, sarebbe apparso necessario, dominato e reso logico dalla fatalità dell’azione.
Consisteva appunto in questo il miracolo d’arte, a cui quella sera quasi con sgomento si assisteva. Pareva non ci fosse la premeditata concezione d’un autore, ma che l’azione nascesse lì per lì, di minuto in minuto, incerta, imprevedibile, dall’urto di selvagge passioni, nella libertà d’una vita fuori d’ogni legge e quasi fuori del tempo, nell’arbitrio assoluto di tante volontà che si sopraffacevano a vicenda, di tanti esseri abbandonati a sé stessi, che compivano la loro azione nella piena indipendenza della loro natura, cioè contro ogni fine che l’autore si fosse proposto.
Molti, tra i più accesi e pur non di meno afflitti dal dubbio che la loro impressione potesse non collegare col giudizio dei competenti, cercavano con gli occhi nelle poltrone, nei palchi i visi dei critici drammatici dei più diffusi giornali quotidiani, e si facevano indicare quelli venuti da fuori, e stavano a spiarli a lungo.
Segnatamente su un palco di prima fila si appuntavano gli occhi di costoro: nel palco di Zeta, terrore di tutti gli attori e autori che venivano ad affrontare il giudizio del pubblico romano.
Zeta discuteva animatamente con due altri critici, il Devicis venuto da Milano, il Corica venuto da Napoli. Approvava? disapprovava? e che cosa? il dramma o l’interpretazione degli attori? Ecco, entrava nel palco un altro critico. Chi era? Ah, il Fongia di Torino… Come rideva! E fingeva di piangere e di abbandonarsi sul petto del Corica e poi del Devicis. Perché? Zeta scattava in piedi, con un gesto di fierissimo sdegno, e gridava qualcosa, per cui gli altri tre prorompevano in una fragorosa risata. Nel palco accanto, una signora dal volto bruno, torbido, dagli occhi verdi profondamente cerchiati, dall’aria cupa, rigidamente altera, si levò e andò a sedere all’altro angolo del palco, mentre dal fondo un signore dai capelli grigi… – ah, il Gueli, il Gueli! Maurizio Gueli! – sporgeva il capo a guardare nel palco dei critici.
– Maestro; perdonate, – gli disse allora Zeta, – e fatemi perdonare dalla signora. Ma quello è un guajo, Maestro! Quello è la rovina della povera figliola! Se voi volete bene alla Roncella…
– Io? Per carità! – fece il Gueli; e si ritrasse col viso alterato, guardando negli occhi la suà amica.
Questa, con un fremito di riso tagliente su le labbra nere e restringendo un po’ le pàlpebre quasi a smorzare il lampo degli occhi verdi, chinò più volte il capo e disse al giornalista:
– Eh, molto… molto bene…
– Signora, con ragione! – esclamò allora quello. – Genuina figliuola di Maurizio Gueli, la Roncella! Lo dico, l’ho detto e lo dirò. Questa è una cosa grande, signora mia! Una cosa grande! La Roncella è grande! Ma chi la salverà da suo marito?
Livia Frezzi tornò a sorridere come prima e disse:
– Non abbia paura… Non le mancherà l’ajuto… paterno, s’intende.
Poco dopo questa conversazione da un palco all’altro, mentre già si levava il sipario sul secondo atto, Maurizio Gueli e la Frezzi lasciavano il teatro come due che, non potendo più oltre frenare in sé l’impeto dell’avversa passione, corressero fuori per non dare un laido e scandaloso spettacolo di sé. Stavano per montare in vettura, quando da un’altra vettura arrivata di gran furia smontò, stravolto, Attilio Raceni.
– Ah, Maestro, che sventura!
– Che cos’è? – domandò con voce che voleva parer calma il Gueli.
– Muore.. muore… muore… La Roncella, forse, a quest’ora… l’ho lasciata che… vengo a prendere il marito…
E senza neanche salutar la signora, il Raceni s’avventò dentro il teatro. Passando innanzi all’ingresso della platea udì un fragore altissimo d’applausi. In due salti fu sul palcoscenico. Qui, a prima giunta, si trovò come in mezzo a una mischia furibonda. Giustino Boggiolo ormai ringalluzzito, anzi quasi impazzito dalla gioja, tra i comici che lo tiravano per le falde della giacca, gridava e si divincolava per presentarsi lui, lui alla ribalta, invece della moglie, a ringraziare il pubblico che ancora non si stancava di chiamar fuori l’autrice, a scena aperta.
| Suo marito – Indice
Introduzione |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com